Vi racconto un canto
Commenti ai canti del repertorio, ma non solo, ed altro
(da "I monti pallidi"
di CarloFelice Wolff)
Marmoléda - La leggenda di Conturina
Nella valle del Contrin, adagiata ai piedi dell’immensa parete verticale della Marmoléda, vive ancora il ricordo della leggenda di Conturina, la splendida fanciulla vittima della propria bellezza e dell’odio della matrigna.
La matrigna di Conturina era una nobile e ricca signora, padrona di un castello e madre di due brutte ragazze. Molti giovani principi e cavalieri venivano in visita al castello: tutti ammiravano Conturina e nessuno guardava le altre due. La castellana, indispettita di vedere le sue figlie sempre trascurate, un bel giorno ordinò a Conturina di non pronunziare più una parola in presenza degli ospiti. E disse a tutti che la ragazza era muta e stupida.
Ma principi e cavalieri continuarono ad ammirare Conturina, e Conturina soltanto. Allora la matrigna ordinò che quando vi fossero ospiti in casa, Conturina restasse sempre immobile. E disse a tutti che la figliastra era muta, stupida e paralitica.
Ma i giovani visitatori ammirarono anche così la fanciulla bellissima. La castellana, furente, mandò a chiamare una strega, la quale con un incantesimo trasformò Conturina in pietra.
Ma principi e cavalieri s’innamorarono della statua stupenda ed ebbero sguardi soltanto per lei. Allora la matrigna diede ordine che la fanciulla impietrita venisse portata sopra un’altissima rupe che domina il Passo di Ombretta; che venisse infitta nella roccia e abbandonata lassù. E così fu fatto.
Mesi e anni passarono senza che nessuno sapesse dove fosse andata a finire la povera Conturina. Ma dopo alcuni anni fra i pastori si cominciò a dire che nella solitudine di Valle Ombretta qualche volta si udiva un canto di donna. E una note un giovane soldato, che faceva la sentinella sul Passo, nel silenzio profondo riuscì a comprendere anche le parole del canto, nel quale Conturina raccontava la sua storia. Il soldato le gridò che allo spuntar del giorno si sarebbe arrampicato fino a lei, per liberarla.. Ma Conturina gli rispose che era troppo tardi. Nei primi sette anni la sua liberazione sarebbe stata possibile; ma alla fine del settimo anno l’incantesimo si era fatto insolubile e nessuna forza umana sarebbe valsa ormai a staccarla da quella rupe, dove era suo destino rimanere per sempre. E così fu. Qualche volta, chi passi per quel deserto di rocce che è la Valle Ombretta, specialmente di sera, ode ancora il mesto canto della povera Conturina.
Questa leggenda era ricordata in particolar modo dalle "resteleris" le ragazze che rastrellano il fieno; le quali, lavorando nei campi, solevano cantare la canzone di Conturina. Oggi la canzone è quasi tutta perduta; una sola strofa ne sopravvive:
"Son de sass e non me meve,
son de crepa en Marmoléda,
son na fia arbandoneda
e no sê per che resòn."
Attorno all’unica strofa rimasta della canzone di Conturina, Ugo Pomarici, corista degli anni sessanta, scrisse altre strofe e le mise in musica. Massimo De Bernart, allora giovane studente al Conservatorio "B.Marcello" ed oggi direttore d’orchestra, armonizzò per noi il pezzo che, da allora, con il titolo di "Marmoléda", divenne la nostra sigla.
Toni Dittura
Non c'é Coro che non abbia nel repertorio natalizio questo antico canto, almeno in una delle numerose armonizzazioni che ne sono state fatte. E non c'é chiesa nella quale l'intera Assemblea non lo canti a gran voce il giorno di Natale, mettendo magari qualche "S" in più alla fine di ogni versetto.
Si potrebbe quindi pensare che, oltre alla melodia, sia noto anche il significato del testo latino. Non é proprio così.
Una prima, veloce lettura ci porta solo ad una parziale comprensione, ma un ulteriore approfondimento e soprattutto un'attenta "costruzione diretta" ci fa scoprire qualcosa di più nelle quattro strofe del canto.
La prima parola "Adeste" grammaticalmente é un Imperativo presente, che significa:"siate presenti, avvicinatevi". Ma chi dà questo ordine o, se volete, chi fa questa esortazione?
Un angelo forse. . . che però subito dopo ci invita ad essere gioiosi (laeti) e trionfanti.
Ed é ancora un ordine quel reiterato , comprensibilissimo " Venite".
Non altrettanto comprensibile, ma sicuramente più ordine che esortazione quel "videte" (Imperativo presente), che frettolosamente viene tradotto con un insulso "vedete",come se nel testo fosse scritto "videtis" (Indicativo presente), mentre il suo vero significato é "ammirate" il nato Re degli Angeli, (natum videte Regem Angelorum). Infatti non é possibile ordinare di "vedere", mentre si può invitare ad "ammirare".
La seconda strofa offre altri spunti interessanti: non più ordini o esortazioni, ma un invito all'osservazione dell'Evento, con un testo così riordinato: "En vocati pastores, relictogrege, adproperant ad humiles cunas", dove quell' "humiles" potrebbe riferirsi a "pastores" (poiché nell'accezione comune i pastori sono sempre umili), mentre invece va riferito a "cunas", nome
che in latino ha solo il plurale. Ed allora il tutto significa: "Ecco i richiamati pastori, abbandonato il gregge, si avvicinano all'umile cuna”.
A questo punto si assiste ad un vero e proprio cambiamento: "Et nos festinemus (congiuntivo esortativo), ovanti gradu" cioé: "Affrettiamoci anche noi con passo festoso, dove quel "nos festinemus" é sicuramente un'esortazione che l'Assemblea rivolge a se stessa,come d'altro canto si evince dal ritornello: "Venite adoremus", cioè: "Venite"(voi), "adoriamo" (noi…assieme).
Ed ecco anche un nuovo concetto di Presepio: niente pecore (relicto grege) lente e sonnacchiose accanto ad un pastore immobile e silenzioso, ma persone allegre e festose che accorrono alla grotta, dove "videbimus" (Indicativo futuro) vedremo l'eterno splendore del Padreterno, "velatum" cioè nascosto sotto la carne: incarnato. Il Dio Bambino avvolto nelle fasce (pannis involutum). Decisamente meno elegante nella forma la quarta strofa, nella quale le parole mal si adattano alla musica; sembra quasi una strofa aggiunta da un altro Autore. Forse per questo nessuno la canta mai!
Riordinata suona così: “Foveamus (altro congiuntivo esortativo) piis amplexibus egenum pro nobis et foeno cubantem” “Riscaldiamo con affettuose carezze Colui che (fattosi) povero per noi, ora dorme nel fieno”. Alla fine una domanda retorica: “Quis non redamaret sic nos amantem”? “Chi non ricambierebbe l’amore (redamaret: congiuntivo imperfetto che traduce il nostro condizionale presente) di Colui che ci ama cosi tanto?” Ed allora: “VENITE” (imperativo presente) “ADOREMUS” (congiuntivo presente) “DOMINUM” … “VEINITE ADORIAMO IL SIGNORE”.
In definitiva una versione quasi letterale potrebbe essere quella riportata a fianco
Accorrete fedeli,lieti, festosi! / Venite, venite in Betlemme./ Ammirate il Nato Re degli Angeli
Venite adoriamo il Signore.
Ecco gli esortati pastori che, abbandonato il gregge,/ si avvicinano all'umile giaciglio. / Affrettiamoci anche noi, con passo festoso!
Venite adoriamo il Signore.
Vedremo l’eterno splendore del Padreterno nascosto nelle carne: / il Dio Bambino avvolto in miseri panni.
Venite adoriamo il Signore.
Riscaldiamo con tenere carezze / Colui che, fattosi povero per noi,/ ora dorme nel fieno;/chi non ricambierebbe l'amore di Colui/ che ci ama così tanto
VENITE ADORIAMO IL SIGNORE.
Come spesso accade nel leggere canti e poesie friulane, questa, per la musica di Franco Escher e l’armonizzazione di Luigi Pigarelli, propone un andamento e una melodia davvero simili ad un canto e a una preghiera, intimamente connessi, nell’ispirazione e nell’emozione che sanno trasferire.
“Ai preât la biele stele” è una villotta friulana, molto diffusa tra i nostri soldati nel corso della prima guerra mondiale: vi si riconosce la tipica forma poetica di origine ottocentesca: quattro ottonari alternati piani (primo e terzo) e tronchi (secondo e quarto); un canto che unisce alla semplicità del testo, caratteristica costante dei brani di derivazione popolare, una raffinata armonizzazione melodica.
Tecnicamente ancora, si ritiene che le villotte friulane, per la struttura melodico-ritmica, risentano di un’ influenza della musica strumentale di matrice austro-ungarica e slavo-balcanica, potendosi aggiungere che gli arrangiamenti delle canzoni popolari dell’arco alpino discendono, in generale, da modelli di canto corale di tradizione austro-tedesca, e meno da tipologie derivate dalle scuole musicali italiane, le quali hanno, invece, riservato a queste forme di canto corale un ruolo piuttosto marginale.
La guerra, dunque. Essa ha coinvolto e sconvolto anche coloro che si
trovavano a casa, che vivevano giorni di speranza e d'apprensione
attendendo ogni giorno chi portasse una notizia dal fronte.
In questo canto una ragazza rivolge una preghiera alla stella per lei
più bella, e a tutti i santi del paradiso, affinché Dio possa fermare la
guerra e il suo amato finalmente possa ritornare al paese.
All’apice della divaricazione, del sentimento e della poesia, la preghiera accorata di un’innamorata ( ma anche la madre è ‘innamorata’ di quel figlio… ) raccoglie l’invocazione di quel ragazzo in guerra, di tutti i ragazzi precipitati nella tempesta del conflitto, e quasi chiama le fredde stelle a scendere dolci sulle paure, sulle solitudini, a ricucire il filo radicale dell’umana condizione, quello per il quale davvero e unicamente non desideriamo conoscere la rassegnazione animale alle leggi naturali del vivere e del morire, ma scegliamo il filo dell’amore, della mutua vicinanza e comprensione: “ Ai preât la biele stele / duc’ i sants del paradis / che il Signor fermi la uère / che il mio ben torni al pais! / Ma tu stele biele stele / va’ daûr di che’ montagne / là ch’a l’è ‘l mio curisìn (cuore) ”.
Certo nel linguaggio e nella fiducia nei sentimenti di appartenenza, che
rimangono comunque strutturati nella cultura religiosa, patriottica e
familiare del mondo che ci ha preceduti, non ancora globalizzato in ciò
e quindi “razionale”, rassicurante, restiamo nell’ambito della
tradizione lirico-romantica nazionale, di ascendenza genericamente
risorgimentale.
Non c’è ancora la rottura di schemi comunicativi, e quindi poetici, indotta sulle sensibilità più attente dal mutare, con le relazioni planetarie in ogni campo, di quegli stessi riferimenti, e quindi, ove essi siano oscurati e non appaia altra trama conciliante per l’emozione ed il sentimento umano dell’essere e dell’esistere, dal manifestarsi e crescere di un nuovo sentire cosmico ma solitario, individuale e separato, proteso negli eventi, sovente infelice.
Più recentemente, l’esperienza di guerra non si limita più a separare dalla sua Sicilia il giovane contadino italiano del primo Novecento, ma anzi, sull’onda conclamata della “nuova professionalità”, dell’essere militare in un mondo “compenetrato”, dissolve i singoli contingenti-comunità sul pianeta, tra le tante aree di crisi, nell’insorgere di sempre nuove tensioni di una realtà incapace di grandi progetti di pace e di giustizia tra i popoli.
Così essa, i suoi schianti, le uccisioni e le devastazioni perdono, come dire, la vecchia configurazione, pur tremenda e sanguinosa, giungendo a frammentare e disperdere il dolore e l’odio al punto che, forse, essi davvero non trovino spazio nel moderno cantare della gente. Il che si potrà sapere solo in futuro.
Tornando alla dolce nostra canzone, come spesso accade la musica può unire, almeno per brevi attimi, almeno nella privata coscienza, nonostante il frastuono delle armi attorno ( o la desolata solitudine di chi rimane a casa senza poter sapere, prevedere alcunché…) ciò che la guerra divide.
Così, accanto alla stella ‘ bièla’, ai santi tutti del Paradiso, e al loro Signore e Dio, la fanciulla chiede la grazia di non condannarla al silenzio, all’annullamento emotivo, di rendere noto, compreso, forse intravisto tra quelle stelle di una notte di trincea o tra i nembi del fumo acre di morte che la sovrasta il suo grido d’amore, la sua ricerca dell’affetto profondo, indivisibile se non a prezzo dell’aridità del vivere, o del morire, anch’essa, poiché laggiù, nel buio dell’insondabile e dell’imprevedibile, sta il suo cuore, ‘l mio curisin, senza il quale tutto il resto perde di valore, senza eccezione, o alternativa, che il momento consenta.
Per tutte e tutti coloro che attesero e attendono il soldato, e la soldatessa oggi; per tutti i soldati e le soldatesse che, in nome della convinzione patriottica o dell’obbedienza civica o della ‘ fatale necessità’ – della costrizione allora, certo, e per quanti ‘soldatini’ del profondo Sud, e delle profonde disagiate campagne – non poterono opporre alla guerra se non obbedienza o rassegnazione, o ebbero sussulti di ribellione e di autotutela, pagati spesso con la fucilazione sul campo, come drammaticamente ‘troppo più tardi’ si disse e si ammise anche a proposito di osannati generali, Cadorna e Giardino per dirne due.
Alakiaz partzer sar a
A conclusione del ciclo concertistico dedicato al Natale, il "Marmolada" si è presentato al Suo Pubblico Veneziano in un luogo particolare sia dal punto di vista storico-religioso sia perché si trattava di un'isola, quella di San Lazzaro degli Armeni dove, dal 1717, risiede la Congregazione Mechitarista Armena. (1)
Giornata di pioggia e di vento quella di domenica 21 Dicembre 2003, accompagnata anche dallo sciopero dei mezzi pubblici ma, nonostante questi inconvenienti, duecento persone circa (questa era la capienza della chiesetta dell'isola) si sono imbarcate su due vaporetti per assistere al nostro concerto organizzato dall'Associazione Settemari. (2)
Il programma predisposto dal nostro Direttore Artistico Lucio Finco, oltre ai canti ispirati alla festività del S. Natale (3) , includeva, in omaggio alla comunità ospite, il canto armeno "Alakiaz".
Non è stata questa la prima volta che il "Marmolada" si è esibito davanti alla comunità armena. Infatti, nel 1955, il coro fu invitato a tenere un concerto in occasione della festa di fine anno scolastico presso il Collegio Armeno che, fino a qualche anno fa, aveva sede nel Palazzo Zenobio (4) ai Carmini. Fu proprio in quell'occasione che, su richiesta, apprese tre canti in lingua armena: Alakiaz, Khenghi-Tzar e Imcinari yare. I documenti di allora ricordano che a quel concerto era presente anche il Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Roncalli, salito al soglio pontificio nel 1958 con il nome di Giovanni XXIII. Gli spartiti dei tre canti provenivano proprio dalla biblioteca di San Lazzaro ed un maestro di musica di lingua armena provvide all'insegnamento dei brani soprattutto per quanto riguardava l'idioma. Nel corso degli anni uno dei canti (Incinary yare) venne abbandonato mentre gli altri due furono fusi in un unico pezzo che prese il titolo di Alakiaz. (5) Il motivo della fusione è stato determinato dalla brevità del primo (Alakiaz), ma anche dalle caratteristiche musicali. A questo proposito ho riscontrato, navigando in internet, che esistono corali armene, in diverse parti d'Europa, che hanno effettuato la stessa operazione. Inoltre, sempre con lo stesso mezzo, ho scoperto che esistono due corali che portano il nome di Alakiaz; si tratta sempre di corali all'interno di comunità armene, una di Neuchatel (CH) (6) e l'altra di Buenos Aires.
Ed a proposito di comunità armene, quella di Venezia è una delle più antiche; infatti fin dal 1253 le cronache ricordano l'esistenza dei primi mercanti provenienti dalla regione caucasica che si stabilirono nella zona della Parrocchia di San Zulian ed anche in Ruga Giuffa (7) , e fu proprio nella Chiesa di San Zulian che celebrarono inizialmente le loro celebrazioni religiose secondo il rito armeno, finché non costruirono, nelle vicinanze, la loro chiesa, Santa Croce degli Armeni, nel 1456. Fu una comunità che si integrò molto bene nella nostra città pur continuando a mantenere vive la lingua e le tradizioni e queste caratteristiche si fecero ancora più peculiari con l'arrivo dei Padri Mechitaristi. Oggi questa comunità, formata principalmente da cittadini italiani, si è espansa nel Veneto e nel resto d'Italia.
E proprio per queste caratteristiche della comunità armena in Venezia e per gli apporti culturali della Congregazione Mechitarista, il Coro Marmolada ha, da sempre, considerato questo canto anche un po' "veneziano" tanto che, nel 1986, in occasione di una richiesta dell'A.S.A.C. (Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali) volta a valorizzare canti del proprio territorio da proporre anche a nuove armonizzazioni, ha segnalato, fra gli altri, anche Alakiaz. Successivamente il canto è stato armonizzato da alcuni musicisti, sia per cori a voci maschili che per cori misti.
_____________________________
1- L'isola di San Lazzaro, a poche centinaia di metri dal Lido, è raggiungibile, con servizio pubblico, da Venezia. Si chiama San Lazzaro perché anticamente era un lebbrosario. Dopo un periodo di abbandono, nel 1717, venne assegnata ad un nobile armeno di Sebaste, Manug di Pietro (1675-1749) monaco detto "Mechitar" (il Consolatore), fuggito in quell'anno da Modone invasa dai turchi , dove, con l'aiuto dei veneziani, era riuscito a fondare un monastero benedettino per accogliere i suoi connazionali e diffondere la luce di sapere e di carità nella sua terra disgraziata. Egli poté riprendere a Venezia, con l'aiuto della Signoria, la sua opera di bontà. Rifabbricati convento e chiesa, raccolse giovani armeni istruendoli. Dal fondatore prese il nome la congregazione dei Padri Mechitaristi Armeni, nel frattempo accresciuta da nuove rendite e donazioni, fra cui quella del ricchissimo Samuel Morath, che resero possibile la fondazione a Palazzo Zenobio, ai Carmini, di un collegio (vedi nota 4).
2- L'Associazione Settemari, veneziana, fra l'altro ha anche lo scopo di promuovere e concorrere a realizzare iniziative a carattere sportivo, culturale, sociale o ricreativo, nel quadro delle più schiette tradizioni Veneziane, avendo cioè come obiettivo fondamentale la conservazione del modo di vivere delle genti lagunari ed il perpetuarsi della Venezianità.
3- Il concerto è stato aperto con l'Ave Maria di B. De Marzi, e ciò sia perché questa preghiera inizia con l'annuncio a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele, sia perché la chiesa è dedicata alla Madonna; l'esecuzione corale è stata accompagnata dal flauto di Monica Finco sulla base dello spartito originale che l'autore ci regalò in occasione del 50° anniversario di fondazione.
4- Palazzo Zenobio ai Carmini è stato costruito per la famiglia Zenobio dall'architetto Antonio Gaspari; all'interno si trovano, fra l'altro, decorazioni di Luca Carlevarijs e di Giambattista Tiepolo. Nel 1850 divenne proprietà dei Padri Mechitaristi Armeni (vedi nota n.1) che lo usarono come collegio nel quale venivano a studiare giovani armeni della diaspora provenienti da tutto il mondo. Da qualche anno il collegio, non esiste più, ma è intenzione di ripristinarlo come Liceo Armeno nel quale verranno a completare la loro istruzione gli studenti dell'ultimo anno del Liceo Italiano di Erevan.
5- Testi di Alakiaz e di Khenghi Tzar in armeno e tradotti in italiano: "Alakiaz partzer sar a / vai-le-le / vai_le_le" "Alakiaz è una montagna alta / evviva! / evviva!" - "Merterane khenghi tar / kulum cian / tzerterane khenghi tzar / kulum cian." "Nel mio giradino fiorito / cantano gli uccellini, / sugli alberi fioriti / cantano gli uccellini".
6- Interpellati se potessero fornire maggiori notizie sul canto e sulla montagna che porta questo nome, gli interessati hanno così risposto: "Cari amici, E una cosa straordinaria che esiste in Italia un coro che canta canzone armene. Peró certo a Venezia si comprende melio... Nostro coro non e grande come il vostro. Nei megliori giorni, siamo 12. E solamente un coro liturgico, serve per fare la liturgia armena una volta al mese in un piccolo paese vicino a Neuchâtel. Quanto al nome Alakiaz, anche noi sappiamo solamente che si tratta di una montagna. Dove? Nessun idea. Forse e une montagna di sogno. Come la nostra Armenia a noi tutti qui, che e un' Armenia di cuore e di sogno, perche non esiste piu. Specialmente per quelli che sono nati en Svizzera, Francia o America... Abbiamo sentito la vostra interpretazione di Alakiaz sul vostro sito internet, e molto bella! Cari saluti, tanti auguri per il 2004 e vostri concerti! - Armand Arapian & Muriel Denzler"
7- La calle di Venezia chiamata Ruga Giuffa (ruga = strada) prende il nome dalla città armena di Juffa, da dove provenivano i mercanti.
Bibliografia:
- Giulio Lorenzetti "Venezia e il suo estuario" - Edizioni Lint Trieste - Ottobre 1974
- Guido Perocco - Antonio Salvadori "Civiltà di Venezia" - La Stamperia di Venezia Editrice - 1976
- Giuseppe Tassini "Curiosità veneziane" - Filippi Editore Venezia - 1970
- Elena Bassi "Palazzi di Venezia" - La Stamperia di Venezia Editrice - 1980
Alpini in Libia
Premessa
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono così le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: « La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. »
In occasione del "Giorno della Memoria" tutte le cerimonie e iniziative sono organizzate affinché simili eventi non possano mai più accadere.
E poi ancora la legge 30 marzo 2004, n. 92 con la quale " .... La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.".
"Per non dimenticare"
Una premessa strana, penserà qualcuno, per "raccontare" un canto, nella fattispecie un canto degli alpini. Non tanto strana, invece, affermo; non tanto strana perché il 27 gennaio ed il 10 febbraio sono due date che servono a ricordare eventi terribili perché gli stessi non debbano più avverarsi.
Vi sarebbero tante altre date, o periodi, da ricordare. Ed è appunto per questo motivo che il Coro Marmolada, ma anche altri cori dello stesso tipo (cori "popolari" o "d'ispirazione popolare"), canta anche i cosiddetti "canti degli alpini" definiti da alcuni "canti di guerra". Apriamo una parentesi proprio sui cosiddetti "canti di guerra": sono questi veramente canti di questo tipo? Ne abbiamo trattato ampiamente, anche in un concerto a tema, con l'intervento di personalità esterne al mondo dei cori e degli alpini, e si è convenuto che proprio non lo sono e che, invece, sono soprattutto canti d'amore, di nostalgia e di speranza.
Quest'anno ed anche nei successivi quattro si ricorderà il centenario della prima guerra mondiale, una guerra che fu soprattutto un "macello" (anche tutte le altre guerre sono state dei macelli più o meno ampi, ampiezza che dipese dal numero degli stati che si scontrarono) e le manifestazioni saranno molteplici e di svariati generi: seminari di studio, conferenze storiche, rappresentazioni teatrali, ricordi di particolari fatti e musica nella quale vanno inseriti anche i concerti corali.
Il corpo degli alpini, fondato nel 1872 per "la difesa dell'arco alpino", ebbe il "battesimo del fuoco" nel 1896 ad Adua in Etiopia (dei 954 alpini partiti dall'Italia sotto il comando del tenente colonnello Davide Menini, ne rimasero vivi solo 92) e tornarono in Africa (Libia) nel 1911 quando l'Italia, la cui classe politica dirigente aveva ambizioni coloniali, decise di impadronirsi della Tripolitania e della Cirenaica, due province dell'ormai decadente impero ottomano. Ed è proprio in questa guerra che nacque il canto denominato "Alpini in Libia" (vedi testo a margine) il cui titolo originale era "Il Vascello di Savoia" (vedi http://www.coroanamilano.it/public/canto.asp?cod=8 ) la nave che trasportava una delle formazioni alpine (Battaglione Saluzzo) ed infatti il canto inizia con il verso "E la nave s'accosta pian piano ...".
Si dice che il canto sia opera di un anonimo alpino del battaglione Saluzzo dopo la battaglia di Uadi Derna vinta dalle truppe italiane che inflissero ai turchi una dura sconfitta. Un verso, pertanto, risulta un po' trionfalistico (" ... i turchi fuggivano gridando: alpini abbiate pietà.") ma subito dopo "... Sulle dune coperte di sabbia i tuoi alpini, o Italia, morivano ma nelle veglie ancor ti sognavano, con la morosa e la mamma nel cuor." , verso che riporta il canto nei sentimenti che prendevano sempre i soldati lontani da casa e dagli amori mentre venivano mandati a combattere sul suolo straniero -in questo caso sulle dune sabbiose e non sulle montagne di casa- una guerra della quale non conoscevano neppure il perché.
"E la nave s'accosta pian piano, salutando Italia sei bella al vederti mi sembri una stella, o morosa ti debbo lasciar." L'inizio del canto dimostra sì un sentimento di amor patrio che, però, subito si trasforma nel pensiero della morosa rimasta a casa. Ma subito un richiamo all'obbedienza " ... i turchi son là" preceduto dalla formalità del saluto del capitano. E poi la descrizione del campo di battaglia con il "rombo del cannon" dove risuonavano anche le trombe degli alpini che avanzavano con le penne al vento "... le nostre trombe si misero a suonare le nostre penne al vento volavano ... ".
"Un pizzico di tracotante trionfalismo" (definizione presa dal sito del Coro Ana di Milano che fu diretto per alcuni anni da Flaminio Gervasi armonizzatore del canto in questione) nel verso citato sopra, seguito, però, da sentimenti più dolci, sentimenti che si ritrovano molto spesso nei canti degli alpini.
Il canto in questione, che già il Coro Marmolada eseguiva negli anni '60 e '70, è stato ripreso recentemente proprio per inserirlo nei concerti a tema riguardanti il ricordo della prima guerra mondiale, anche se storicamente fa parte di un'altra campagna bellica che viene considerata, in ogni caso, per le successive conseguenze (nazionalismo balcanico), una delle cause dello scatenarsi della guerra che sconvolse l'Europa intera e non solo.
Concludiamo quindi affermando, per l'ennesima volta, che i canti degli alpini non sono canti di guerra che, invece, viene ricordata al solo scopo di evitare che altri conflitti sconvolgano le nostre esistenze e quelle dei nostri figli.
Alpini in Libia - E la nave s'accosta pian piano, / salutando Italia sei bella / al vederti mi sembri una stella, / o morosa ti debbo lasciar.
Allora il capitano mi allungò / la mano sopra il bastimento, / mi vuol salutare, e poi mi disse: / i turchi son là.
E difatti si videro spuntare, / le nostre trombe si misero a suonare / le nostre penne al vento volavano / tra la bufera e il rombo del cannon.
E a colpi disperati / mezzi massacrati dalle baionette / i turchi fuggivano gridando: / alpini abbiate pietà.
Sulle dune coperte di sabbia / i tuoi alpini, o Italia, morivano / ma nelle veglie ancor ti sognavano, / con la morosa e la mamma nel cuor.
E col fucile in spalla / caricato a palla / sono ben armato, paura non ho; / quando avrò vinto ritornerò!
Arso (Chi ze stà, chi ze stà, Maria ?....)
“ … La 29enne ricercatrice torinese Valentina Tarallo è stata uccisa l’11 aprile. Quella maledetta sera la giovane ricercatrice italiana stava rientrando a casa dopo una sessione di allenamenti in palestra quando è stata colpita alla testa con una spranga di ferro… … A Miravalle di Molinella, in provincia di Bologna, il 52enne tassista Andrea Balboni ha confessato di aver ucciso la moglie Liliana Bartolini al termine di una furiosa lite, dichiarando che lei l’aveva aggredito e l’aveva accusato di avere una relazione extraconiugale… … In Brianza il 73enne pensionato Giuseppe Gallina ha prima ucciso la moglie recidendole la gola con un coltello da cucina e poi si è suicidato… …
Fabio Piacenti e Paolo De Pasquali (in ‘ Rivista Italiana di criminologia ’) focalizzano l’attenzione sulla spaventosa realtà italiana per gli anni dal 2000 al 2012. Nel periodo si contano in Italia 2.220 donne vittime di omicidio, una media di 171 vittime annue. Il femminicidio, in Italia così come in generale nei Paesi Europei, risulta prevalentemente circoscritto nell’ambito domestico, risultando oltre 7 vittime femminili su 10 uccise nel contesto familiare. Le donne assassinate dal partner rappresentano il 66% degli omicidi domestici … … Il 2013 è stato un anno nero, con 179 uccisioni … … Secondo il rapporto Eures nel 2014 ci sono stati 152 casi … … Nel 2015 sono state 128 le donne uccise in Italia … … E nel 2016 i numeri non danno tregua, anzi … …”
In questi casi almeno si sa chi si sia macchiato degli orrendi delitti, quasi sempre, ma numerose sono le povere ammazzate abbandonate come stracci da qualche parte, o annientate nella loro stessa fisicità e sottratte al pianto di chi le amava, senza che il mascalzone responsabile dell’eccidio abbia un volto che possa essere disprezzato e una giusta pena da scontare.
Come nel caso della Maria cantata da uno straordinario De Marzi, con gli accenti di un sentimento universale, di un risentimento etico e umano che travalica il tempo e il luogo, diventando identificazione antropologica assoluta, pietas luminosa e assorta, limpida coscienza morale.
“ Chi ze stà, Maria!?...”: il canto si apre con un accento accorato, la sorpresa inaudita di un passante – forse il contadino di ritorno alla propria casa dai lavori nel podere, oltre la carraia che porta al paese rasentando un fossatello – e subito dopo l’urlo angoscioso, lo sbalordimento di un’abitudine comunitaria tranquilla, ove tutti conoscono tutti: i saluti sul sagrato la domenica della messa grande, gli uomini a parlar del lavoro, di bestie e di terra, le donne, con i più piccoli attorno a schiamazzare, intente al racconto delle più intime storie familiari, “ chi ze stà che te ga bandonà!...su la strada de casa, dopo mezanote…col vento che tirava ”…
La chiama per nome, con l’aspra emozione che si prova all’impatto con il peggiore atto di crudeltà, la riperpetuazione dell’uccisione ‘ di uno di noi ’, ancora un Abele sacrificato all’odio accidioso di un fratello perverso, ma una ragazza qui, sola, a notte inoltrata, seminuda sulle ghiaie del tratturo, noto da sempre, e fin lì datore di una quotidiana convivenza.
La guarda con l’orrore della riapparizione di un male atavico, tante volte esorcizzato e ora radicalmente concreto, forse gli bastano i capelli arrovesciati a coprire un volto stremato, ingrigito dalla contiguità innaturale di quel ghiaino su cui posa innaturalmente, forse quel che resta di un lembo di gonna già osservato al mercato, o a messa, per riconoscerla, “Maria!”. E allora, in uno strazio senza limite, con lo stravolgimento di sè medesimo, del proprio connotato di uomo di borgata incapace di accettare quell’estetica orribile di una terra lorda di sangue e di brutale carneficina, non riconoscendo più i tratti di un paesaggio altrimenti e fin lì protettivo, garante, non può trattenere l’altro urlo, l’altra constatazione, distruttiva della cultura sociale, della consuetudine solidale di cui si sente, si sentiva fino a quel momento, propaggine chiara e geloso conservatore, “ chi ze stà che te ga bandonà!....senza scarpe nel fosso…soto tanta neve…co poca roba indosso ”…
Un urlo, il tentativo estremo di sapere da lei, da quel corpo maltrattato che nulla può dire, nemmeno piangere sulla propria sorte, invocazione senza risposta che, anche nel canto, si fa lieve fino a serrarsi in gola, “ chi ze stà che te ga copà? “, forse per non voler più altro osservare, niente più ammettere, abbandonandosi all’unica consolazione e difesa possibile, quella della ‘comunità buona’, della ‘ bona zente ’, della ‘ zente di montagna’, alla quale rivolge l’unica speranza accettabile in tanta distruzione, quella di restituire alla povera Maria la culla e il ricetto salvifico dal quale essa aveva ricevuto respiro vitale e certezza d’amore: “ compagnéla da so’ mama…compagnéla su in contrà ”. La preghiera infine, raccolta, modulata a fil di voce, come la più tenera delle carezze all’oggetto di quell’amore straziato: “ desso cantéghe…la ninanana…desso cantéghe…la ninanana… “.
Come sempre avviene nella poetica di Bepi De Marzi, anche quando i toni hanno l’apparenza di mosse burlesche, o la leggerezza sorniona dell’ammiccamento sensuale, perfino irriverente, il cerchio della vicenda cantata, e del vissuto in essa trasparente, si chiude intorno a forti imperterriti riferimenti valoriali e sociali, quelli di una società, minuta se vogliamo, forse epigona della lunga epopea contadina, e non solo del nostro veneto, per la quale gli appoggi su cui conoscere ( l’infanzia ), sperimentare ( la maturità storica e individuale ), fare sintesi ( del dato e dell’avuto esistenziale ) sono pochi e decisamente connotati, certezze insomma, percepibili anche dietro le luci e i rumori di una modernità che sembra lanciata ‘ oltre ’ quegli assimilati sentieri, verso una commistione di successi e guadagni, di vantaggi e agi altrove impensabili, ma pure di smarrimento etico e morale, di deviazione grave che sovente vorrebbe, e vi riesce, smantellare quegli stessi valori, a danno definitivo del diritto di tutti, dei più esposti particolarmente, di tante donne e tanti bambini recentemente, alla propria libertà personale, all’integrità fisica e culturale, a una comunità solidale che riduca le differenze e le separazioni gravi, tra individui e tra comparti sociali, recuperando e coltivando indefessamente, ostinatamente, l’intimità familiare ( intorno alla certezza materna ), l’attenzione e la reciprocità ( intorno alla ‘ contrà ’, alla borgata operosa e affidabile, a un concetto di comunità sociale e socievole, non distratta, non indifferente), la speranza e il diritto a una sopravvivenza che salvi noi stessi salvaguardando l’ambiente naturale, le sue acque, i suoi animali, le creature tutte intorno a noi umani, così fragili eppure arroganti nel procedere nella comune vicenda storica, per quel poco che ci è dato di incidervi, giorno dopo giorno.
Amore e tenacia, nell’agire e nel suggerire, chiamare, esortare, mai sospeso ma ora, in un De Marzi ricco di una lunga densa saggezza, in una instancabile passione culturale e civica, di nuovo forte, anche enfatica, quasi un qualcosa che fa pensare ad un lascito filosofico e spirituale al quale egli tiene molto, e che sembra davvero, anche con un fare musica denso, ispirato, illimitato quasi nel suo inseguire con le note e le parole la sintesi necessaria di tutto un percorso esistenziale e culturale, egli cerchi, con qualche angoscia, pur attutita dalla leggiadrìa del tessuto armonico e comunicativo, di ‘ affidare ’, perché rimanga e resista quel suo messaggio: in fondo una dichiarazione d’amore per la vita e la bellezza di quanto esiste attorno a tutti noi, e il richiamo vibrato, l’urlo appunto, ad agire, in ogni modo, perché tutto ciò sopravviva a quanto di negativo questa stessa umana vicissitudine penosamente, inconsapevolmente, colpevolmente anche, va progettando e producendo, fino ad oscurarla, non poche volte, la speranza.
Sergio Piovesan
UN’AVE MARIA CANTATA AI PIEDI DELLA PALA DELL’ASSUNTA DI TIZIANO
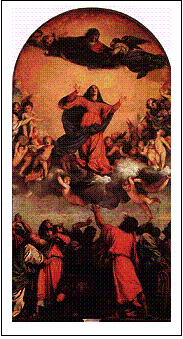 “Santa
Maria, Madre di Dio … “
ed ecco, in queste poche parole, che iniziano la seconda parte dell’AVE
MARIA, la glorificazione e la santificazione della Vergine.
“Santa
Maria, Madre di Dio … “
ed ecco, in queste poche parole, che iniziano la seconda parte dell’AVE
MARIA, la glorificazione e la santificazione della Vergine.
Una preghiera che moltissimi musicisti hanno voluto significare con le note e che può assumere aspetti diversi, vuoi per l’interpretazione del canto, vuoi per il luogo in cui questa preghiera viene cantata.
Ed uno dei luoghi che, senz’altro, avvicina al concetto di glorificazione e santificazione della Vergine, è l’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venezia, dove spicca la magnifica pala dell’ASSUNTA del Tiziano, un’opera che suscita, in chi la osserva, un’intensa commozione.
Trovarsi, poi, a cantare, ma anche solo ad ascoltare, un’AVE MARIA in quel luogo è, ovviamente, ancora più emozionante.
«Fratelli carissimi questo che noi vediamo dipinto dal nostro grande concittadino, il devoto Tiziano, è uno dei grandi miracoli del Signore. Con l’assunzione in cielo della sua santa madre noi miriamo qui gli apostoli, uomini grandi, semplici, potenti, scelti da Gesù fra i pescatori. Ed ecco, voi li vedete appena si è mosso il turbine meraviglioso, che sono tutti in piedi, con le braccia levate al cielo e par che gridino: “Oh, Maria, madre nostra, perché ci lasci?” E mentre la Vergine sale in cielo a incontrare il figlio martire, per la redenzione dei nostri peccati, gli apostoli orfani piangono e implorano… ».
Con queste parole Fra Germano da Casale, Padre Guardiano e committente, per conto dell’ordine dei Francescani, presentava al popolo veneziano, il 18 marzo 1518, la pala d’altare dell’ ASSUNTA, che Tiziano Vecellio, appena ventiseienne, dipinse in due anni; era la sua prima importante opera pubblica che, come raccontano le cronache di allora, sconvolse il pubblico veneziano, abituato ad una pittura più statica e fredda.
Questa pala ha indubbiamente decretato il successo di Tiziano a Venezia. Secondo fonti attendibili, alla scopertura della tela avrebbe assistito un emissario dell'imperatore Carlo V, il quale intimò ad un frate di volerlo acquistare nel caso essi non fossero stati soddisfatti dell'opera. Al contrario, l'acclamazione popolare, proprio il giorno dell’inaugurazione, costrinse anche i frati più scettici nei confronti del talento dell'artista, ad ammettere la sua bravura.
Nella sua struttura la pala appare divisa in tre fasce: in basso, come venne evidenziato dal padre Guardiano, il gruppo degli Apostoli meravigliati, tutti protesi verso l'alto in vari atteggiamenti.
San Pietro, colto dal fatto miracoloso, s’inginocchia, ma resta con le mani e la testa rivolti verso l’alto; alla sua destra San Giovanni, con la mano sinistra sul petto, è in contemplazione; Sant’Andrea, vestito di rosso, è proteso verso il cielo, mentre dietro a San Pietro, Paolo rassicura il sempre dubbioso Tommaso e gli addita Maria.
Gli altri, tutti in una contemplazione quasi di meraviglia e di stupore, sembra proprio che dicano “ … prega per noi peccatori”. Al centro la Vergine, con lo sguardo verso l'alto, sale lentamente al cielo e schiere di angeli le vengono incontro suonando e cantando la gloria di Dio.
C'é un grande movimento attorno a lei, che veste i colori dell'iconografia classica: rosso, per indicare la piena umanità e azzurro, per indicare la divinità, il colore dell'infinito, della spiritualità, di ciò che va oltre l'umano.
È il movimento la caratteristica, nuova per allora, che fece apparire l’ ASSUNTA, illuminata dalle torce, in tutto il suo splendore tanto che vi furono esclamazioni del tipo “Magnifico!”, “Gran fatto!”, “Par proprio vero!”.
Non fu un quadro semplice da dipingere, vuoi per le misure (cm.680 x 360), vuoi per l’illuminazione, che veniva, e viene, dal retro, alla quale sarebbe stato esposto.
Si conosce anche il “marangon”, il “barba Fighi”, che preparò la tavola con ben ventuno assi orizzontali, evidentemente di legno buono e ben stagionato, visto che a quasi cinquecento anni, pur con i vari restauri, si può ammirare la pala in tutta la sua magnificenza.
Domenica 6 gennaio 2008 saremo in concerto proprio ai piedi di questa pala, ed allora sono sicuro che, non solo noi coristi, ma anche il pubblico presente, si emozionerà nell’ascoltare l’AVE MARIA e nel godere contemporaneamente dei segni, delle figure e dei colori dell’ ASSUNTA.
Sergio Piovesan
Ci jè belle
Nel precedente numero di Marmoléda”, precisamente nell’articolo “Coralità alpina: cos’è?”, affermavo, fra l’altro, “ … Ma per fortuna non tutti gli alpini sono di questo stampo, ed allora il già citato Renato Amedeo Buselli, del quale condivido tutto l’ intervento, risponde: “… Pertanto se un coro desidera cantare “funicolì funicolà” e “La Madunina” le canti pure e perché no? anche canzoni arabe, basta che piacciano. Sono perfettamente d’accordo con il direttore del coro ANA della sezione di Milano Massimo Marchesotti, il quale dice che un coro alpino o non alpino deve cantare e l’impegno dei coristi e del direttore è far cantare e cantare… bene. …”
Di recente il “Marmolada” ha “lavorato” seguendo questi criteri ed inserendo, quindi, nel proprio repertorio un canto in lingua portoghese dedicato ai bambini brasiliani “Vamos Construir” (vedi il numero di “Marmoléda” di novembre / dicembre 2006).
E, non ancora conclusa la calorosa accettazione di questo canto, il complesso veneziano ha voluto proseguire nei canti non propriamente “alpini”; ecco allora “Ci jè belle” nell’armonizzazione di Flaminio Gervasi.
Per quanto riguarda la sua provenienza geografica, almeno per quanto riguarda il ritornello, in tutta Italia, è la zona molisana-pugliese. “ Ci jè belle 'u primm'ammore, / 'u seconde è chiù megghie angore! “ questo è il testo del ritornello che, tradotto, dice così: “Quant’è bello il primo amore, il secondo è meglio ancora!”.
L’abbiamo sentito innumerevoli volte da diversi cantanti in televisione. Ma le strofe, le numerose strofe, chi le conosce? La caratteristica del testo raccolto da Gervasi, testo di numerose strofe che, come appare chiaro leggendole, non sono connesse l’una con l’altra, è appunto quella di non avere ne capo ne coda. È una canzone del tipo di “Quaranta canzoni quaranta”, popolare canzone veneziana.
Difficilmente una strofa prosegue logicamente con la seguente, anche perché si tratta di strofe brevi ed interrotte sempre dal ritornello.
Si può definire “scanzonato”, ma anche allegro, e, forse, è un assieme di pezzi diversi di vari canti popolari: un “potpourri”, questo è il termine esatto, proprio perché così si definiscono le composizioni musicali, anche vocali, risultanti dalla riunione di pezzi eterogenei o anche di frammenti di un'opera collegati da brevi passaggi modulanti; corrisponde all'italiano centone e ai termini, usati soprattutto nella musica per banda e in quella per orchestrina o pianoforte, di sunto, fantasia.
Ma lasciamo spazio al testo ed alla relativa traduzione.
'U vi, 'u vi, 'u vi, mo se ne vene,
c'la sigaretta 'n mocca
ve facenne 'u sceme!
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Sott'a 'u arve delle cilze russe
Matalena se tenge 'u musse.
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Marì, Marì, Marì, sciamm' a fe' na riss',
facimmece 'nu balle senza la cammis!
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Abbascio la marina si venne 'u pesce
e tu uagno cun me non la vue furnesce?
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Te si fatta 'na vesta a ianc,
quande cammine fa dinghe 'n danc!
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Te si fatta 'na vesta gialle
cu li soldi du marescialle!
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Marì, Mari, Marì, sciamm' a fe' na riss',
facimmece 'nu balle senza la cammiss!
Lalà, lalà, lalà...
Ci jè belle 'u primm'ammore,
'u seconde è chiù megghie angore!
Traduzione
Lo vedi, lo vedi, ecco che viene
con la sigaretta in bocca, facendo il cascamorto.
(scemo)
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Sotto l’albero delle more rosse (il gelso)
Maddalena si tinge la faccia.
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Maria, Maria, andiamo a divertirci (a ridere),
facciamoci un ballo senza la camicia!
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Giù alla marina si vende il pesce,
ma tu, ragazzo, con me non la vuoi piantare.
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Ti sei fatta un vestito bianco,
quando cammini fa dingh’e danc!
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Ti sei fatta un vestito giallo,
con i soldi del Maresciallo!
Quant’è bello il primo amore,
il secondo è meglio ancora!
Le ninnananne sono,
senz'altro, i primi canti che ogni essere umano ha potuto ascoltare ed
apprezzare soprattutto perché servivano, e servono ancora, a tranquillizzare i
piccoli nei loro primi anni di vita. Tutti le abbiamo ascoltate ed anche
cantate; alcune sono costruite specificamente per le mamme, ma non tutte;
alcune sono "generiche" e altre, soprattutto quelle d'autore e più
recenti, sono proprio per i papà, magari perché l'autore è un maschio, ma anche
perché, nelle ultime generazioni, le usanze sono mutate: anche gli
uomini, papà e nonni, partecipano, più che in antico, a tutte le responsabilità
della vita famigliare, anche a quelle ritenute solo sulle spalle del mondo
femminile.
Forse
il primo di questi autori, almeno per quanto a mia conoscenza e relativamente
alla tipologia da me più conosciuta, è stato Bepi De
Marzi con "Adesso dormi"
e
con "Intorno a la cuna". Se nel primo l'invito a
dormire può essere considerato un po' "interessato": Desso
te canto la nana, / ti, dormi un pochetin; / lassa
che mi co' la mama / se staga un po' visin.(1),
nel secondo, invece, è la felicità a prendere il sopravvento, la felicità della
mamma, del papà e degli amici "alpini": To
mama zè contenta, /
contenti ze i alpini,/ e tuti gà bambini, / che pianze da
cunar(2).
Ma
la ninnananna del repertorio che preferisco è la sarda
Dormi
pitzinnu
Dormi
bambino, testo di Secondo Soddu e musica di
Gianni Garau.
Oltre
ad essere una bellissima armonia, ha un testo molto poetico ed il verso che più
mi ha colpito è il secondo, che dice: "... dormi ca
babbu ti tene sa manu..." (" ... dormi che il babbo
ti tiene la mano... "). In effetti, mentre tutte le
raffigurazioni, alle quali accennavo all'inizio, individuano la madre in
qualità di attore principale, questa vede, accanto al bambino, il papà che lo
rassicura tenendo la piccola mano fra le sue. A volte, ai bambini -come anche
ai miei nipoti- piace addormentarsi con il racconto di una storia ed il babbo è
lì pronto ad accontentarli:
"...
Isculta fitzu sas novellas mias.
/ Babbu a ti raccontare semper
prontu. ..." ("...Ascolta,
figlio, le favole / che babbo è sempre pronto a raccontarti ...").
Ma
in questo canto il babbo va oltre i desiderata del figlio e continua, mentre il
bimbo dorme, a parlare ed a suggerirgli consigli che saranno utili quando il piccolo s'affaccerà alla vita.
Ecco il testo originale del canto:
Dormi pitzinnu cun sonnos de oro.
Dormi ca babbu ti tene sa manu;
de mamma tua ses semper in coro
bellu che frore, che frore 'e beranu.
Ninna nanna pitzinnu cantu podes
e cantu podes a sonnu profundu;
pro non b’ider sas penas de su mundu
pro ca b'hat zente
mala e falsas lodes.
Isculta fizzu sas novellas mias.
Babbu a ti raccontare semper prontu.
Cando t'ischidas t'has a render contu.
Chi m'has a narrer rejone tenias.
Appena chi t'acciaras a sa janna
...ninna nanna pitzinnu
ninna nanna...(3)
NOTE
Traduzione letterale:
1 - Ora ti
canto la ninnananna / tu dormi un pochino; / lascia che io e la mamma / si stia
un po' vicini.
2 -
La mamma è contenta, / contenti sono gli alpini / e tutti hanno bambini che
piangono, da cullare.
3
-
Dormi piccino fa sogni d'oro / dormi mentre babbo ti tiene
la mano / di tua madre sei sempre nel cuore / bello come un fiore, come un
fiore di primavera.
Fai
la nanna piccolo quanto puoi / e quanto più puoi d'un sonno profondo / per non
vedere le sofferenze del mondo / perché vi è gente cattiva e adulatrice.
Ascolta,
figlio, le favole / che babbo è sempre pronto a raccontarti. / Quando ti
sveglierai ti renderai conto. / Allora mi dirai "Avevi ragione".
/Appena ti affacci alla porta (della vita). / ...ninna nanna piccolo ninna
nanna.
Dove sei stato mio bell'alpino
Nella versione cantata dal Coro Marmolada, e accreditata pure nel repertorio della Sat trentina per l’armonizzazione curata da Antonio Pedrotti, il testo è dei più semplici, e non proprio agevolmente – se non per la presenza del termine ‘ alpino ’, altro e fondamentale sintagma della letteratura musicale di cui stiamo occupandoci – potrebbe un appassionato meno habitué riconoscere il ‘come’ e il ‘dove’ di quel colore che cambia sul viso del soldatino (?) e poi, per l’universale taumaturgia dell’amore, torna ad un tenore rasserenante: “ Dove sei stato, mio bell’alpino / che ti ga cambià colore? / L’è stata l’aria del Trentino / che mi ha cambià / colore. / I tuoi colori ritorneranno / questa sera, a far l’amore.”
Effettivamente, a voler esagerare, quest’alpino potrebbe anche starsene in una caserma del Trentino, o ad una esercitazione, tanta è la certezza con cui la morosa attende il suo ritorno, e senza riferimento ad alcunché di drammatico. Ma tant’è, i testi popolari intensivamente utilizzano, nel loro nascere e trasformarsi in relazione a contingenze e contesti diversi sottintesi o semplificazioni, allusioni o riutilizzazioni di scritture e musiche preesistenti, e l’effetto emotivo-musicale inventato dalla bravura di Pedrotti ci mette tutto ciò che eventualmente manchi.
Che si tratti però, con buona approssimazione, di una semplificazione effettiva di uno o più testi precedenti ( o prevalenti ), nei quali senz’altro emerge l’appartenenza del canto alla tradizione dei canti alpini ‘ di guerra’, è suggerito autorevolmente dal testo riportato nell’ormai noto libro di Virgilio Savona e Michele Straniero, così ( Alpini, 15/18 ): “ Dove sei stato / mio bell’alpino.../… che ti ha cangià colore? / L’è stata l’aria / dell’Ortigara / che mi ha cangià colore…/… è stato il fumo della mitraglia / …”. Il resto come nell’altra versione.
Tutto più conseguente, qui, e meglio rappresentativo dell’attitudine ‘iconografica’ attribuibile ai canti ‘ di guerra’, nel senso che ‘ Ortigara’ è parola da sola sufficiente a tratteggiare un intero terribile sanguinoso teatro di guerra.
“ In quei giorni primaverili del 1917 i piani dell'esercito italiano non prevedevano solamente l'avanzata sul fronte isontino, ma anche un nuovo piano offensivo nella zona dell'Altopiano di Asiago. Nonostante la controffensiva dell'estate precedente infatti, questa ampia zona di montagna era ancora parzialmente occupata dagli austro-ungarici, le cui posizioni sulle cime meridionali del Trentino davano un grande vantaggio strategico.
Venne perciò formata una nuova armata (la Sesta) agli ordini del generale Ettore Mambretti, il quale avrebbe guidato i 200mila uomini alla conquista del Monte Ortigara, 2105 metri, all'estremità orientale dell'altopiano, tra il Veneto ed il Trentino.
L'azione, considerata una delle più importanti dell'intero conflitto, venne organizzata per la metà di giugno ma da subito fu bersagliata dalla sfortuna e dai contrattempi. La controffensiva austro-ungarica sul Flondar aveva reso necessario anticipare l'attacco. In tutta fretta Mambretti organizzò le prime linee ma, proprio quando stava per essere dato l'ordine (7 giugno) piogge torrenziali impedirono l'inizio delle operazioni, e il giorno seguente una mina destinata alla linea austro-ungarica esplose in anticipo uccidendo in un solo istante 230 soldati italiani.
Mambretti, inspiegabilmente, decise di non
aspettare e il 10 giugno lanciò l'assalto all'Ortigara. Le divisioni
partirono verso le pareti scoscese della montagna mentre 430 cannoni e
220 lanciabombe iniziarono a colpire le trincee asburgiche, ma le nuvole
basse impedivano di avere una buona visuale, cosicché i soldati si
trovarono bloccati sul fianco della montagna e si trasformarono in
facili bersagli.
Il 25 giugno, dopo due settimane di combattimenti durissimi, i soldati
asburgici respinsero definitivamente gli assalti della Sesta Armata con
l'utilizzo di
lanciafiamme e di
gas.
La Battaglia dell'Ortigara divenne così una delle pagine più drammatiche della Grande Guerra: in 16 giorni gli italiani persero più di 25 mila uomini e alcuni battaglioni persero oltre il 70% degli effettivi ”.
Ovviamente la bellezza della musica che accompagna il canto, e una buona esecuzione, rendono giustizia ad un testo monco e indubbiamente generico, al limite del fraintendimento del suo presupposto celebrativo.
In questo caso, come spesso nei canti di questo genere, l’unico indizio di un’emozione forte, che però trattiene pudicamente l’angoscia e la paura, per compassione del soldatino amato o per non esistere nella semplice fanciulla ( o mamma o moglie…) il coraggio di fare cenno alla guerra che inghiotte il giovane uomo, sta nella promessa di un ritorno felice, del recupero di quei colori in un viso rasserenato, quasi come la mamma che al bambino riottoso davanti alla siringa della vaccinazione promette in premio l’abbraccio più tenero, e la ripresa del libero gioco che l’attende a casa, come sempre, nell’abituale imperdibile serenità familiare.
Non altro può dire e fare, di fronte al grande macello, la donna innamorata di quel soldato: non imprecazioni, non protesta ‘politica’, non ricorso alle autorità’ superiori’. Non altro, se non abbracciarlo con tutta la forza di cui è capace, nascondendo il viso incapace di fingere sulla sua spalla, e affidarsi alla ( buona) sorte.
Sergio Piovesan
E MI ME NE SO ‘NDAO (Peregrinazioni lagunari)
Non sono molti i canti popolari arrivati fino a noi e provenienti dall'area veneziana. Infatti a Venezia, dove la classe dominante ha imposto anche al popolo la propria cultura, vi è stata, soprattutto negli ultimi secoli della Repubblica di San Marco, una preponderanza della musica "dotta" o di autore sulla musica popolare.
Non mancavano le stamperie dove poter riprodurre gli spartiti che poi invadevano l'Italia e l'Europa, tanto che in altre regioni ritroviamo ancor oggi canzoni, scritte a Venezia da autori noti, riprese e modificate, soprattutto nel testo e nel dialetto, da altre popolazioni.
A Venezia, invece, vuoi per la particolarità del luogo, vuoi per il contatto continuo che il popolo, o meglio alcune categorie dello stesso, aveva con altre forme di cultura, i canti cosiddetti popolari non trovarono terreno fertile e quindi non si radicarono, non furono tramandati e di conseguenza caddero nel dimenticatoio.
Non così invece accadde nell'immediata periferia, nel vicino estuario, sulle isole che circondano Venezia e sulla gronda lagunare. Per questo motivo oggi alcuni canti lagunari vengono fatti passare per canti veneziani, come il caso appunto di "E mi me ne so 'ndao" che si conosce anche col secondo titolo di "Peregrinazioni lagunarie" e la cui origine risale al XVII secolo.
E` questo un canto di una polivocalità particolare comune all'area adriatica, nel tratto che va dall'Abruzzo all'Istria, dove viene chiamato rispettivamente "canto a vatoccu" (vatoccu sarebbe il batacchio della campana) e "canto a la longa" (canto da lontano). Le due definizioni individuano bene la caratteristica del canto che è appunto una "botta e risposta" in quanto ad una strofa cantata da un barcaiolo, risponde, magari in lontananza, un altro barcaiolo, dalla barca o dalla riva.
Era questo un tipico modo di cantare del popolo della laguna e di Venezia, o meglio, più che di canti si trattava di cantilene, magari su testi famosi quali le strofe de "La Gerusalemme Liberata", come riporta Elio Zorzi nel libro "Osterie Veneziane", Filippi Editore 1967.
La riscoperta di questo canto e la sua popolarità in Venezia sono dovute ad una studiosa di canto popolare veneziano, Luisa Ronchini, bergamasca trapiantata in laguna, nel 1965. La sua prima divulgazione in campo nazionale fu nel 1970 quando la RAI presentò un documentario sui "Tiepolo" dei quali in quell'anno furono allestite mostre favolose nella Villa Manin di Passariano (Ud) e, per l'incisione, a Udine. Il canto in questione era la sigla iniziale del documentario che si apriva con la visione di un sandalo (barca tipica) che, scivolando sulle piatte acque della laguna, attraversando i posti più suggestivi, arrivava a Venezia ed in questo suo peregrinare la barca era immersa in una luce particolare, quella luce che proprio i Tiepolo, ma prima di loro anche altri pittori veneziani, che noi oggi chiamiamo vedutisti, seppero rappresentare così bene nelle loro opere d'arte.
E la particolare melodia di "E mi me ne so 'ndao" suggerisce agli ascoltatori, magari con un po' di fantasia, proprio l'idea di quella particolare luce, difficile da descrivere e che si può ammirare, e della quale si può anche godere, trovandosi immersi negli spazi che sembrano infiniti della laguna.
Pochi anni dopo il Coro Marmolada rielaborò con molta semplicità la melodia caratterizzandola con una voce solista baritonale, non triste, ma velatamente malinconica e nostalgica, sostenuta da un accompagnamento muto del coro.
A volte, al posto di una sola voce, le strofe vengono eseguite in alternanza da due solisti, ambedue baritoni ma con timbro diverso, ritornando così al canto una delle sue caratteristiche antiche.
Il testo è un itinerario nostalgico-romantico attraverso la laguna veneziana e tocca luoghi facilmente individuabili ed altri meno. Quella che segue è una traduzione libera con la precisazione dei luoghi.
"E io me ne sono andato dove facevano i bicchieri (Murano), giocando (o suonando) la spinetta ed altri giochi. (La spinetta potrebbe essere un gioco oppure lo strumento musicale). Ho delle focacce di quelle di Marghera; ho camminato per terra fino a Fusina (località sulla gronda lagunare dopo Marghera dove sfociava il Brenta). Passando dal trasto alla sentina, su una barca da caccia (in veneziano "sciopon" da schioppo), andavo di gran carriera alla Giudecca. Ho percorso la secca (parti di laguna in secco durante la bassa marea) e tutta la pescheria (Rialto); ho volto la poppa all'indietro verso i due castelli (zone fortificate a difesa dell'ingresso del porto di Lido, forse corrispondenti all'attuale Forte di S.Andrea e ad un altro nella prospiciente zona di San Nicolò di Lido). Ho visto l'orto degli Ebrei (il cimitero Israelitico al Lido) con tutta l'isola delle Vignole (di fronte al Lido), e dalle Vignole sono tornato indietro. Ho camminato per tutto ed ho incontrato un buranello (abitante dell'isola di Burano nella Laguna Nord) che aveva un bel cestello e me l'ha mostrato. Ed io me ne sono andato dove facevano le scodelle (?), suonando la spinetta alle donne belle".
Solista: Giovanni Manzato
detto Barcherote
Registrazione in studio 1978
Solista: Renato De Giovanni
detto Gufo
Registrazione presso il
Teatro Sociale di Biella
Nov. 2006
Sergio Piovesan
Su un testo ed una melodia di Mansueto Pedrotti (1873-1926), Arturo Benedetti Michelangeli, con il suo solito estro e la sua consolidata bravura, ha prodotto un'armonizzazione che tiene testa ad altre considerate più "impegnate".
In dialetto trentino (forse l'autore è anche lui della stirpe dei Pedrotti della SAT) il canto vuole rappresentare dei momenti di tranquillità e di serenità all'interno di una famiglia, in un periodo a cavallo fra '800 e '900.
Il protagonista è il focolare che, da sempre, è considerato il simbolo della famiglia e, come viene descritto dall'autore, è uno di quei focolari dei quali oggi rimangono, purtroppo, solo pochi esemplari. Tutto l'ambiente è destinato a questa funzione ed è circondato da una panca di legno su tre lati; al centro arde sempre un fuoco, tenuto sempre basso per risparmiare la legna; il soffitto non è orizzontale ma, dalla sommità di ogni parete, si alza e converge, a forma di piramide, verso un punto più alto dove inizia la canna fumaria; e questo soffitto, che è poi una cappa, è tutto nero da anni di fumo.
Accanto al fuoco, o sopra di esso, si trova sempre qualche tegame dove cucina lentamente e "borbottando" qualcosa, forse una minestra a base di prodotti della campagna.
Tutt'attorno, seduti sulla panca, i componenti la famiglia parlano e ricordano i momenti allegri, ma anche quelli tristi, della loro vita e di coloro che li hanno preceduti. Ma c'è anche che tenta un canto e chi, invece, resta come ipnotizzato dalla fiamma.
Il fuoco, ad un certo momento, cala d'intensità e, allora, qualcuno pensa a ravvivarlo e ad aggiungere un ciocco provocando così il formarsi di tante faville che, simili a piccole comete, s'innalzano verso il cielo attraverso la cappa annerita dal fumo. Ma c'è anche chi non perde l'occasione di prendere una bottiglia di vino da bere in compagnia.
Ogni strofa è alternata da un ritornello che, completamente diverso nel ritmo, tiene in sospeso gli ascoltatori perché le sue parole sembrano invocare una minestra che continua a bollire e che non è mai pronta.
Questo elemento della minestra, forse troppo poca per i numerosi membri, e, probabilmente, anche piatto unico, può ingannarci sul tipo di famiglia che, appunto per questi elementi se valutati con metro odierno, potrebbe essere ritenuta povera. Ma se pensiamo qual'era il tenore di vita, specialmente nelle campagne ed in montagna solo cinquant'anni fa, anche le famiglie benestanti non scialacquavano certamente ed il piatto unico di minestra era cosa abituale nei giorni feriali. Se poi consideriamo anche la bottiglia di vino, non molti potevano permetterselo, allora si può dedurre che il focolare ("fogher", "fogolar", "fogoler") si trova in una casa non povera.
Pensieri e ricordi personali.
Quando presento, ma soprattutto quando, come corista, eseguo questo canto, mi tornano alla mente i ricordi di serate trascorse attorno al fuoco seduto sulla panca del focolare della casa di mia moglie, a Raveo, in Carnia. Sono ricordi che risalgono ad estati prima del 1976 (anno del terremoto in Friuli) quando nelle famiglie, in certe famiglie, la persona anziana veniva tenuta ancora in grande considerazione. Si realizzava così quello che dice un proverbio friulano ("Il cioc vieri ten donje al fuc" "Il ceppo vecchio tiene vicino al fuoco") dove la persona anziana, il "patriarca", il ceppo vecchio, teneva riuniti tutti i membri della famiglia, sposati o meno.
In quelle sere, vecchi e giovani, stavano seduti attorno al focolare a discutere di tante cose, ma la serata diventava più interessante se i protagonisti erano gli anziani che ricordavano, cercando di tramandare, i riti e le usanze della gente di Carnia, oppure che rivivevano episodi della vita della casa e dei suoi abitanti anche nel contesto delle vicende paesane.
E mentre si parlava c'era chi lavorava ad uncinetto, chi sferruzzava echi, dopo aver approntato la "macchina" della polenta, girava il mestolo per ottenere, dopo i regolamentari 3/4 d'ora, un'ottima polenta fumante di 2 Kg., insaporita al modo giusto dal fumo e da qualche favilla che, invece di salire verso il camino, si era amalgamata con la farina.
Oggi quel focolare esiste ancora, anche se con qualche piccola modifica effettuata nella ricostruzione successiva al terremoto; non esiste più, invece, quell'atmosfera degli anni passati, vuoi perché molti protagonisti di allora sono scomparsi, ma anche perché, essendo passata una generazione, è cambiato il modo di agire, di vivere e di pensare della gente.
Sono rimasti i bei ricordi.
“Era sera di un giorno di festa, la mia bella mi stava accanto, mi diceva ‘io t’amo tanto’ …/ … i tuoi occhi son neri son belli / i tuoi capelli sono di oro …/… Dammi un ricciol dei tuoi capelli / che li serbo per tua memoria” …..
Qui l’avvio del canto pare davvero non curarsi degli affanni dell’esperienza di guerra. Prevalgono i toni idilliaci, di un paesano smisurato romanticismo, soprattutto in quel ricciolo portato con sé dall’amante quale ricordo, pagana sempliciotta reliquia cui rivolgere il pensiero d’amore, o della sua lontananza. E intorno, di nuovo, i sintagmi allusivi al frammento di serenità esistenziale, alla pausa dal lavoro feriale, al silenzio ritrovato della prima sera, alla tanto ambita presenza di una fanciulla, bella e vivace quanto innamorata e sincera…
Vengono a mente per un’associazione spontanea altri acquarelli deliziosi regalati alla penna e alla bacchetta di scrittori e musicisti da tale speciale convergenza di fortunate percezioni ambientali e psicologiche ( anche ricorrendo, con rispetto e ammirazione, allo splendore sobrio e ovattato della Sera del dì di festa di Giacomo Leopardi : “ Dolce e chiara è la notte e senza vento, / e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / posa la luna, e di lontan rivela / serena ogni montagna. O donna mia,… /… tu dormi, che t’accolse agevol sonno / nelle tue chete stanze; e non ti morde / cura nessuna…”, o, dello stesso autore, al patetico contemplare di A Silvia : “ sonavan le quiete / stanze, e le vie dintorno, / al tuo perpetuo canto,… / … era il maggio odoroso: e tu solevi / così menare il giorno. / Io gli studi leggiadri / talor lasciando e le sudate carte,… /… porgea gli orecchi al suon della tua voce, / ed alla man veloce / che percorrea la faticosa tela…”). Con la considerazione, ovvia, della diversità dei contesti, e del relativo feeling che traspare tra gli innamorati, ma l’utile evidenza di quanta poesia e letteratura ‘ leggera ’ vengano dalla tradizione classica.
Ecco allora, per cenni, l’estensione di tale poesia ‘minore’: a cominciare dai mormorii incantevoli del Canto de not ‘n montagna ( “ La sera là sui prai de la montagna / che se gà el bosco nero sotto i piè / e gh’è n’mucio de stele / ‘n tel seren… / … sluse ‘l foc fòr de l’us a ogni baita / ‘ntorno ‘ntorno gh’è / ‘n bon odor de fen…” ), o dai crepitii sommessi di Entorno al foch ( “ Se smorza ‘na fiamèla, / se ‘npiza ‘n toch de zoca, / … e se sta lì a vardar… / … se pensa a la morosa / a nossa pòra mama / se ‘npiza ‘n’altra fiama / che la va drita al cor…”), o ancora dal brillìo sensuale, appena velato di pudore, della Brasolàda ( “ Soto la luna / la strada de montagna se strapèga: / la par ‘na lunga bava de lumèga / e i sassi i xe d’argento. In alto, solo / ghe brila el ciciolar d’un usignolo. / Impìssa el fogo e séntete lì rente, / la boca rossa, e i oci, i oci, / no li ricordo. Te digo solamente: / te do el me còre, tienlo sui zenòci…”), o infine dalla vasta elegia di Vien morettina vien ( “ Vien morettina vien / in campagna a voltar el fen. / Quand ch’el fen sarà ben voltà / noi godremo la libertà / l’aria pura in mezzo al prà. / In mezzo al prà e in mezzo ai fior / morettina farem l’amor…”).
Gli elementi dell’abbandono all’ambiente naturale complice e carezzevole ci son tutti, così come l’ammissione tranquilla degli amori incolpevoli di quei giovani, anche in Era sera, se non che, qui, il fantasma del buio che cancellerà le tinte morbide dei tramonti, nella borgata da abbandonare e nell’immaginazione che chissà per quanto dolorosamente la sostituirà, sbuca dall’idillio, oscuramente, nascondendo al lettore volto e ghigno minaccioso, l’annuncio del male soverchiante che s’avverte premere sui loro gesti e sui loro pensieri, della guerra, ancora.
I capelli neri e i riccioli d’oro dell’amata sono il talismano di una salvezza necessaria contro la disperazione, che è bestemmia nel piccolo devoto borgo, mentre lo sguardo vibrante del giovane soldato, levato alto sul capo dell’amata a scrutare l’orizzonte vale l’augurio, anzi, la previsione trascendente della vittoria: la vittoria, sì, eroicamente evocata a coprire la tristezza del distacco, gridata a se stesso per l’inevitabile onorevole adesione al sermone patriottico, o anche al convincimento della redenzione nazionale vicina.
Michele Peguri
Bernardino Bernardi
Premessa musicale
In certi giorni d’inverno guardando da Venezia verso nord si coglie un nitido riflesso dei monti innevati sull’acqua lagunare. E’ un semplice specchiarsi d’elementi, ma le tinte che l’acqua e il cielo assumono, nello scorrere della giornata, arricchiscono questo gioco di riflessi d’infinite sfumature e vibrazioni. È una visione che mi ha spesso accompagnato e penso che aiuti a comprendere l’amore singolare che lega l’uomo del mare, di Venezia, alla montagna.
Questi due mondi, evidentemente non così lontani, visto che la natura ci permette di coglierli in un’unica dimensione, sono l’ambiente di questo moderno testamento del capitano, composto nel 1997 da Massimo de Bernart su testo di Ugo Pomarici in memoria dell’amico Massimo Gemin.
È una canta moderna, un azione-narrazione immersa nel simbolico: la grande barca raccoglie le ultime volontà e le memorie scivolando a tempo di barcarola per giungere su l’altra riva. Le reminescenze non sono la guerra o le trincee, ma la natura montana, le passeggiate, i veci scarponi, do moschetoni, un libro da cantar, lo zaino che lo scalatore vuole con sé nell’ultima dimora. E poi i canti, divenuti ora echi del profondo, appaiono rifrazioni che appena individuate si smaterializzano: Belle rose du printemps, Signore delle Cime, Stelutis Alpinis, Al cjante el gjal e altri ritornelli si riverberano in modo caleidoscopico. Tutto ciò mentre la grande barca si dissolve a poco a poco come inghiottita da un fondale sonoro statico a effetto di bordone.
Musicalmente il brano è una rappresentazione a più piani, fatto abituale nell’arte musicale, ma senz’altro originale nel repertorio del popolare. L’esperienza della politonalità in Bèla Bartok (cultore e profondo conoscitore del folklore magiaro) è senz’altro un riferimento, ma di certo il mondo e la poetica di Gustav Mahler (dove il popolare divenne pure materia d’indagine ma con altri obiettivi) può rappresentare una forma di mediazione con il lavoro compositivo di Massimo de Bernart. Come la raffigurazione tra il reale e il ricordo, simboleggiata in modo unico dall’artista boemo si esprime in una stratificazione polifonica, dove richiami alpini e di ländler appaiono in modo improvviso sovrapponendosi al “presente musicale” (si pensi alla Prima sinfonia), in questo brano i ricordi più incisivi, i canti, risuonano distraendoci dal concreto. Il concetto di tempo perde i contorni oggettivi elevandosi a dimensione intima, quasi onirica.
Prima dell’addio l’uomo della laguna guarda gli amati monti raccomandandosi “...e ricordème mi”: e ci piace pensare che quelle crode innevate si tuffino realmente nell’acqua unendo in un unica infinita distesa i ponti e i monti.
Racconto
Il testo di Gran Dio deme 'na Barca è una poesia di Ugo Pomarici, già corista degli anni '60, che ha anche ispirato la linea melodica, poi musicata ed armonizzata da Massimo de Bernart, suo amico di gioventù, allora studente di conservatorio e poi diventato direttore d’orchestra, in memoria di Massimo Gemin, pure lui ex corista del Marmolada.
È una preghiera da parte di colui che, sentendo che è arrivata l'ora, si rivolge a Dio e chiede di poter andare sull'altra riva con una barca per poter navigare, una barca armata con una grande vela rossa, che possa fare da bandiera, e con un’altrettanto grande vela nera, in segno di dolore. Su questa barca, nell'ora della prova desidererebbe salire a prora, vestito di un mantello, in testa un cappello con la "penna", e lo zaino, pronto per salire la montagna, con dentro corda, chiodi, moschettoni, ed infine, per rallegrar lo spirito un libro di canti. Per completare i suoi desideri, desidererebbe ancora un mazzo di fiori sbocciati in primavera ed un sacchetto di terra. Infine, consapevole di aver vissuto una intensa vita terrena piena di ricordi e di soddisfazioni, si permette ancora di chiedere altre cose per quando sarà salito sulla barca: un forte vento in modo che la barca possa staccarsi facilmente da riva, e, quando giungerà in mezzo al mar che affondi pure, ma piano-piano, fra sighi dei rondoni, e contemporaneamente, ricordandosi di lui, di smorzare canti e suoni. Un ultimo desiderio, rivolgendosi agli amici: Nel cuor tegnì memoria / De mi cressuo tra i ponti / Innamorà dei monti / Sepolto in mezzo al mar.
E' un canto molto bello, piacevole all'ascolto, orecchiabile anche, ma, a parte qualche accordo in dissonanza, tipico della musica Jazz, al primo impatto abbiamo incontrato qualche complicazione: cantiamo senza l'accompagnamento strumentale e, pertanto, mentre stai cantando una soave barcarola, nella parte in cui il testo presenta un forte vento mentre la barca affonda piano-piano, l'armonizzatore, nella sua ispirazione, immagina dei dolci e soavi sogni che si materializzano in canti di montagna, quei canti della gioventù immagazzinati nella sua memoria. C'è stata, come dicevo sopra, qualche complicazione (corale ben s'intende) al primo impatto. Immaginate di essere calmi e tranquilli e di canticchiare qualche motivo, come quando ti stai radendo la barba, e qualcuno vi venga a cantare all'orecchio un'altra canzone; contemporaneamente un altro esegue un'altra canzone e, subito, ne parte un'altra e poi ancora un'altra. Così, mentre il coro canta a quattro voci quella che può sembrare una soave barcarola, alla tua destra un altro corista ti canta Belle rose du printemps, alla tua sinistra, un altro accenna a Que fais tui la bas. Nella stessa battuta musicale, mentre questi due solisti cantano, il coro continua con la sua armonia: mentre la barca fonda. Ma non è finita: nella battuta successiva altri due solisti cantano Dio del cielo Signore delle cime ed altri ancora Mamma mia vienimi incontro, e Se tu vens cà su ta cretis; ma non è finita! Ed ecco Al cjante el gjal, Quand nous revenons des champs, nous chantons, poi ancora Belle rose du printemps; ed intanto il coro continua con la barcarola: Mentre la barca fonda e più avanti … tra sighi de rondoni ..., ... se smorza canti e soni ... per finire con ... e ricordeme mi.
Questa complicazione corale, sulla partitura, è in dodici battute su cinquantatre; dulcis in fundo, le ultime otto battute sono per coro a sei voci.
Durante le prove ho fatto un paragone con il poema sinfonico La Moldava. di Smetana nel quale l'autore esprime, fra l'altro, il gocciolio della neve che si scioglie, poi il gorgoglio del ruscello, la corrente più marcata del torrente, ed ancora l'impetuosità dell'acqua che scorre, il fiume ingrossato, le turbolenze della corrente ma anche la calma del fiume.
L'apprendimento del brano, come si capisce bene da questa mia esposizione, è stato, senz'altro, una fatica corale, soprattutto per me e per chi come me deve tenere una nota sempre uguale per dodici battute con attorno tutto quell'ambaradan! Ma anche per i solisti non è stato semplice anche perché le varie melodie si intersecano.
Sono state necessarie numerose prove, però, ne sono sicuro, pur se difficile anche al primo ascolto, avrà il successo meritato.
Sergio Piovesan
IL CANTO DEI BATTIPALI
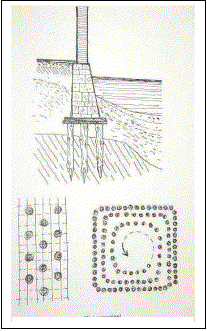 Il
più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole”
per la segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco
delle barche, sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei
pesci e dei mitili.
Il
più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole”
per la segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco
delle barche, sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei
pesci e dei mitili.
Ma il palo è stato, da sempre, un elemento essenziale dell’edilizia e dell’urbanistica lagunari e veneziane. Il terreno sul quale è sorta Venezia è del tutto particolare: sotto la terra emersa troviamo un primo strato di fango (riporto alluvionale) ed un successivo strato compatto di argilla e sabbia, chiamato “caranto”. Quindi, per costruire edifici nella nostra città, è sempre stato necessario dapprima solidificare la zona piantando dei pali di legno appuntiti, in genere di larice e di rovere, corti e nodosi, fino a raggiungere il “caranto”. Le fondazioni degli edifici veneziani sono formate da pali di legno che sostengono uno zatterone di tavole e su queste si elevano le fondazioni di blocchi di pietra d’Istria.
La disposizione dei pali veniva effettuata con un allineamento multiplo, lungo la striscia di terreno sopra la quale si dovevano elevare i muri (vedi Fig. n.1); se invece lo strato di “caranto” si trovava in profondità ed i pali, in tutto od in parte, non arrivavano a conficcarvisi, allora la sottofondazione veniva costruita per costipamento. In tal caso i pali venivano piantati su tutta la superficie sopra la quale doveva poggiare l’edificio, prima chiudendo il perimetro con una fitta palificazione e procedendo poi, con disegno a spirale, verso il centro (vedi Fig. n.1). Questo procedimento veniva usato quando l’edificio da sostenere era molto pesante come, ad esempio, i campanili o la Chiesa della Salute sotto la quale, si dice, siano conficcati centomila pali.
Il “Ritmo dei battipali” è quindi un “canto di lavoro” che era utilizzato per ritmare il lavoro. La sua nascita e la sua “vita”, ma anche la sua “fine”, sono connesse all’esistenza di quel particolare lavoro. Infatti le trasformazioni introdotte nelle tecniche del lavoro manuale, soprattutto negli ultimi cento anni, hanno fatto sì che scomparissero anche i canti che, tradizionalmente, accompagnavano ed aiutavano, i lavoratori. Oggi i pali, sia quelli in laguna per delimitare i canali, sia quelli per le costruzioni, sono conficcati o costruiti direttamente sul posto da macchinari; i primi, ancora di legno, vengono infissi con pesi che s'abbattono sulla loro sommità dopo essere stati issati da un motore, mentre i secondi, di cemento armato, sono colati e costruiti sul posto.
Per questo il “Ritmo dei battipali”, che il “Marmolada” propone al Suo Pubblico, vuole restare, senza alcun rimpianto, la testimonianza di un passato e di una civiltà colmi di glorie e di fasti ma, anche, di tanti sacrifici e fatiche.
I primi
studiosi di “canto popolare” o d'etnomusicologia -e siamo nel XIX
secolo- individuano il pezzo sia come ritmo, ma anche come canto, canzone o cantilena; forse, “ritmo” é il termine più
appropriato, visto che doveva aiutare, ritmandole, l’alzata, con le
braccia, e la successiva caduta del maglio, o mazzapicchio, sulla
testa del palo.
come canto, canzone o cantilena; forse, “ritmo” é il termine più
appropriato, visto che doveva aiutare, ritmandole, l’alzata, con le
braccia, e la successiva caduta del maglio, o mazzapicchio, sulla
testa del palo.
Uno dei
primi studiosi, G. Pullé, scrive di questo canto: “...Al momento
pertanto che più fervea ne’ lontani tempi l’opera del fabbricare questa
mirabil città, doveva la laguna veneta risuonar tutta all’intorno di
quella m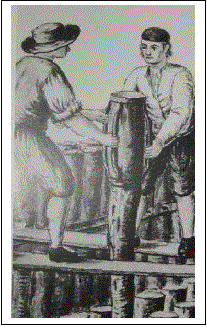 onotona
salmodia che i batti-pali intuonavano, e che noi udiamo ancora
oggidì laddove si gittano le fondamenta di qualche nuova
fabbrica. Le canzoni dei batti-pali son varie, ma tutte però
convengono ad
un dipresso negli stessi concetti, talché molto fra loro
s'assomigliano; ed uguale poi per tutte é la musica, la quale ha un
suono triste, monotono e finisce
onotona
salmodia che i batti-pali intuonavano, e che noi udiamo ancora
oggidì laddove si gittano le fondamenta di qualche nuova
fabbrica. Le canzoni dei batti-pali son varie, ma tutte però
convengono ad
un dipresso negli stessi concetti, talché molto fra loro
s'assomigliano; ed uguale poi per tutte é la musica, la quale ha un
suono triste, monotono e finisce
 costantemente
in un ritornello che somiglia ad un grido prolungato...”.
costantemente
in un ritornello che somiglia ad un grido prolungato...”.
Lo stesso studioso, riferendosi ai testi, ebbe l’impressione, in un primo momento, che gli stessi fossero stati frutto di improvvisazione, ma poi, avendo udito altrove le stesse parole, si convinse che quei canti, pur lunghi, erano veramente canti tradizionali tramandati, “...da chi meglio e da chi peggio...” a memoria.
Esistono diverse versioni del testo, composto da frasi che non hanno alcun significato compiuto, che non raccontano alcuna vicenda, ma che, pur prendendo spunto dalla storia e dagli emblemi della Serenissima e pur ricordando la fede e la religione, avevano come unico scopo quello di ritmare il lavoro.
Vi s'invoca Dio, Cristo e la Madonna ma, anche, si sente inneggiare al Leone di San Marco, quello con la spada al posto del Vangelo [1]; non mancano i ricordi del glorioso Arsenale né per la “bela piaza che xe a San Marco” e neppure l’odio per i pagani “cani de mori” o “el turco cane”. A volte si trovano degli sconfinamenti che potrebbero definirsi triviali se non fossero bonari e privi di malizia. Il tutto è quindi un assieme di sacro e profano, di nostalgico e positivo, d'avventura e di fierezza, un miscuglio di doti e di debolezze che furono poi quelle del popolo della Serenissima.
La prima registrazione[2], e la successiva trascrizione (vedi Fig. 3) di questo canto avvenne nel 1954 a Pellestrina (Venezia) da parte di Alan Lomax[3], mentre il testo, ed anche l’andamento musicale, ai quali si riferisce la nostra esecuzione, sono tratti da “I canti popolari italiani” di R. Leydi (1973).
Lo sviluppo della linea melodica, rappresentato nella successiva figura 4, é invece parte di una lezione registrata dal musicista Luigi Nono a Venezia, in una data non precisata, compresa fra il 1962 ed il 1965; e ciò ad ennesima conferma di come anche famosi musicisti abbiano studiato il cosiddetto “canto popolare” e ad esso si siano, a volte, ispirati. Quello che ascolterete nell’esecuzione del “Marmolada”, non è il canto come era eseguito dai battipali durante il loro lavoro, ma è un pezzo elaborato ed armonizzato a quattro voci maschili da Giorgio Vacchi, musicista e direttore del Coro Stelutis di Bologna. Questa armonizzazione prevede una introduzione musicale, che vuole essere descrittiva dell’ambiente lagunare, ed una parte di due solisti, ritmati dall’accompagnamento del coro, che, nell’emissione delle voci, esprimono la fatica.
NOTE
[1] Nella iconografia tradizionale il leone di San Marco, quando la Serenissima era in guerra, veniva raffigurato o con il Vangelo chiuso o con la spada in pugno.
[2] Una trascrizione del solo testo, da parte di Ludovico Foscari, si trova negli “estratti” di ATENEO VENETO, Anno CXXXIII, Volume 129 n.4-5-6 Aprile-Maggio-Giugno, 1942.
[3] Etnomusicologo di fama mondiale che ha effettuato ricerche principalmente negli Stati Uniti ed in tutta Europa.
Bibliografia
- Civiltà veneziana di Perocco-Salvadori
- Canti popolari italiani di Leydi, Edizioni Mondadori 1979
- I canti del mare di V. Savona, 1980
Solisti: Rolando Basso e
Paolo Biondo
Registrazione presso il
Teatro Sociale di Biella
Novembre 2006
Registrazione presso la Chiesa dei SS.Gervasio e Protasio
in Mestre-Carpenedo
20 dicembre 2003
Sergio Piovesan
Vi racconto un canto (o meglio due): “Il Golico” e “Joska la rossa”.
Premessa
Nel precedente numero di “Marmoléda”, in questa stessa rubrica, presentavo “Le voci di Nikolajewka”. Oggi seguito con lo stesso autore (Bepi De Marzi) e, collegandomi al precedente, tratterò due canti, anche questi ispirati all’ultima guerra mondiale della quale quest’anno ricorre il 60° anniversario della fine e della vittoria degli alleati sul nazismo e sul fascismo.
Qualcuno potrà pensare “ … che barba! Ancora cantano la guerra! Sarebbe ora che questi cori cambiassero repertori! … ecc., ecc. (sempre su questo tono)” . Se posso essere d’accordo sulla varietà di un repertorio corale –ed il nostro repertorio ad ogni concerto è vario- non credo, invece, sia necessario abbandonare i brani ispirati alle vicende della guerra; ed il motivo è molto semplice: NON DIMENTICARE.
È proprio così! L’uomo è portato a dimenticare le vicende tristi, i momenti “brutti”, e questo, forse, per un bisogno esistenziale e per proseguire con una vita migliore. Ma facendo così, spesso, nasconde o modifica vicende che hanno fatto la storia ed in questo modo corre il pericolo di rinnovarle. Allora è proprio necessario ricordare per non dimenticare e per richiamarlo alla memoria delle generazioni più giovani. Ed anche il canto può servire.
Personalmente mi dispiace che nel nostro tipo di canto non vi siano pezzi (o almeno io non ne conosco) che raccontino l’orrore dei campi di sterminio nazisti perché, purtroppo, sembra che i sentimenti antisemiti stiano risorgendo e non solo fra gli esaltati che frequentano gli stadi, ma anche, e sono episodi recenti, in qualche ateneo di prestigio (Torino, Firenze). E la classe dirigente sta zitta!
Forse non tutti se ne accorgono, ma è in atto uno strisciante e pericoloso revisionismo storico.
Allora … ricordiamo!
Il Golico
Gli Alpini, soprattutto quelli della Divisione Julia, partono per un fronte, quello greco, per una guerra che i governanti di allora si illudevano fosse poco più di una passeggiata; “… spezzeremo le reni alla Grecia …” era lo slogan dei capi fascisti.
La Julia, che già era stanziata in Albania, iniziò la sua tragedia il 26 ottobre 1940 con l’attacco ordinato dal Comando Supremo in una stagione autunnale che, per l’arrivo delle piogge e delle prime nevi, non sembra quella opportuna per intraprendere una guerra. Per quanto riguarda l’organizzazione, basti pensare che già il 1° novembre gli alpini della Julia avevano già terminato la riserva di viveri. Scarseggiavano pure le munizioni e la copertura aerea promessa non si fece vedere. Dall’inizio dell’offensiva vera e propria (28/10/1940) all’11 novembre le perdite della divisione ammontarono già a 1674 uomini, di cui 40 ufficiali. La resistenza greca, esercito e partigiani, bloccò sui monti, ai confini con l'Albania, le truppe italiane e l'inverno completò l'opera. Divenne una guerra di posizione.
Il Golico è un monte (vedi foto), nei pressi del fiume Voiussa, fiume reso famoso da un altro canto ("Il ponte di Perati"), il fiume che “… s’è fatto rosso del sangue deglia alpini …”; il Golico fu più volte preso e perduto, soprattutto nel periodo 7/3/1941-18/3/1941, e ciò con numerose perdite fra gli alpini dei Battaglioni Tolmezzo, Gemona e Cividale, della Julia, ed anche del Btg. Susa della Taurinense. Il solo Btg Cividale il giorno 18 marzo ebbe 40 morti e 240 feriti.
Il testo, anche se d’autore, segue la tradizione di tutti i canti alpini e, quindi, non è un testo che esalta la guerra, anzi tutt'altro. Infatti l'alpino, conscio che qualsiasi azione potrebbe essere l'ultima, rivolge un pensiero alla madre e prega la Madonna di dare alla madre, che perderà il figlio, la forza di poter piangere senza disperazione.
Joska la rossa
Anche questo canto è legato alla seconda guerra mondiale. Gli alpini non avevano fatto a tempo a tornare dalla Grecia che, l’anno dopo si trovarono in partenza per un altro fronte a rinforzo di altre truppe del nostro esercito già su quel fronte dal 1941. Siamo nell’estate del 1942 ed il paese invaso è la Russia che, fin dai tempi di Napoleone, ha un famoso generale, "il generale inverno". E sarà anche il grande gelo dell'inverno russo e l'equipaggiamento non adatto dei nostri soldati che faranno soccombere gli alpini.
Il canto di Bepi De Marzi richiama la classica melodia russa, quella che, al suono della balalaica, invita alle movimentate danze popolari di quel paese. E questa volta i protagonisti della danza sono gli alpini delle Divisioni “Cuneense”, “Tridentina” e “Julia”, alpini che la Storia vede impegnati in una guerra, insensata come lo sono tutte le guerre, una guerra voluta da chi comandava, una guerra oltretutto mal preparata e finita in tragedia. Partirono in 55.000, questo era la forza del Corpo d’Armata Alpino facente parte dell’A.R.M.I.R.: 34170 furono i morti ed i dispersi, 9410 i feriti ed i congelati!
Gli alpini, anche se nemici ed invasori, si comportarono umanamente con la popolazione civile ed il
testo racconta una storia, certamente inventata, divenuta una poesia, ma che, senz'altro, è stata ispirata al racconto di qualche reduce. E appunto perché poesia, o meglio “musica poetica”, riesce a focalizzare la gioia ed il dolore, l’amore e l’odio, il perdono e la vendetta, la vita e la morte.
Ma la vera protagonista di questo canto è la donna russa, impersonata da una ragazza, Joska, che ha compassione di questi uomini lontani migliaia di chilometri dalle loro case, uomini che, nel momento del bisogno, non possono avere vicine le loro donne, la mamma, la moglie, la "morosa" e le sorelle.
Ed allora Joska si sostituisce a queste donne per alleviare la malinconia, la solitudine ed il dolore degli alpini.
Alla fine sarà ancora Joska a dar loro pietosa sepoltura nella fredda terra russa.
Sergio Piovesan
Joska, la balalaika e l'acqua alta
Eravamo euforici salendo in pullman quella sera, o meglio, quella mattina, perché erano già le due. Eravamo euforici e ne avevamo il motivo; e non era a causa delle libagioni con il "durello". Ritornavamo a Venezia dopo aver partecipato ad una rassegna corale con I Crodaioli di Bepi De Marzi in casa loro, nella "tana del lupo", al Teatro Mattarello di Arzignano.
Eravamo euforici anche se il tempo atmosferico era di quelli che si suole chiamare "tempo da lupi".
Avevamo eseguito i canti in programma con suprema attenzione alla direzione di Lucio e, soprattutto, con tanto sentimento, con ispirazione ed anche il maestro era particolarmente ispirato; questo forse perché avevamo davanti un personaggio che era esploso proprio in quegli anni nel mondo della musica corale per i suoi nuovi canti, e noi del "Marmolada" avevamo messo in programma proprio quei canti.
Di norma, quando riceviamo gli applausi riusciamo a percepire se si tratta di applausi di convenienza o se il brano che abbiamo eseguito è arrivato al cuore dei presenti.
Eravamo euforici perché quella sera avevamo "scosso" anche i coristi di Bepi che riscoprirono i canti del loro maestro nelle interpretazioni di Lucio e del suo Coro Marmolada.
Forse quella sera l'impegno di noi tutti, Lucio in primis, fu al massimo, ma quando fu la volta di "Joska la rossa", uno dei canti più belli di Bepi ed il cui testo è di Carlo Geminiani, ci fu qualcosa di magico: i "forte" ed i "piano" del canto eseguiti con maestria, i tempi, forse non quelli da spartito, ma della testa di Lucio, così come lui li sentiva avevano imposto al canto un particolare significato; mancava il finale, quello che, come nelle altre strofe , fa: "Joska, Joska, Joska ....". E fu proprio nel finale che Lucio, furbescamente e intelligentemente, aveva inserito una variazione, un accompagnamento "strumentale" o, più precisamente, l'imitazione vocale del suono della balalaika, popolare strumento della musica russa. L'esecutore era Franco Cocito, tenore primo e solista, con una voce limpida e sottile che pareva proprio il pizzicato delle corde della balalaika. Una variazione che piacque molto all'autore, che, anche dopo anni, lo ricorda quando parla o scrive del Coro Marmolada e di Lucio Finco; l'ultima volta fu al concerto del sessantesimo al Malibran quando, fra l'altro, ricordò appunto "... e Franco Cocito che suonava la balalaika"!
Diciamo pure che fu un successo e per questo eravamo euforici anche durante il viaggio di ritorno. Pioveva a dirotto, faceva caldo, quel caldo umido classico dello scirocco; ed il vento era forte.
Dopo un'ora circa di viaggio arrivammo a Piazzale Roma e lì tutta l'allegria passò di colpo. Mi dimenticavo: la data era, ormai, il 4 novembre del 1966, le tre del mattino; avvicinandosi ai pontili notammo subito l'insolita pendenza delle passerelle. Mai vista un'acqua così alta! L'unico mezzo che funzionava era il vaporetto della linea 1 che percorreva il Canal Grande; alcuni si avviarono a piedi ed altri in vaporetto; i primi si trovarono subito nell'acqua, mentre gli altri come scendevano al pontile più vicino alla loro abitazione non sapevano cosa fare: erano isolati. Alla fine tutti andarono a mollo ed anch'io e gli altri due, che abitavamo al Lido, un pezzettino, in Piazzale S.M. Elisabetta, lo dovemmo fare con i tacchi delle scarpe in acqua.
Ma eravamo ugualmente euforici!
"La bergère des Aravis" o "Les plaisirs sont doux"
Due titoli e diverse provenienze
Nel 1965, quando il Coro Marmolada riprese con maggior vigore l'attività anche a seguito di un consistente afflusso di nuovi coristi, Lucio Finco predispose un repertorio di canti vario e, quindi, non solo di derivazione S.A.T.
Uno di questi fu "La bergère des Aravis" nell'armonizzazione a tre voci maschili di L.E. Ferraria, tratto da una pubblicazione datata che proponeva canti "valdostani". Il testo era di tre strofe, come riportato in nota [1] .
Il brano rimase in repertorio per alcuni anni e poi venne abbandonato vuoi per gli inserimenti di canti d'autore e di nuove armonizzazioni tutti di musicisti dai quali prese forza quel movimento che prese il nome di "canti di ispirazione popolare" (De Marzi, P. Bon, G. Malatesta ed altri), ma anche perché un'armonizzazione a tre voci sembrava un po' "limitata".
Pur se inteso come canto valdostano non si riusciva, allora, ad individuare cosa significasse il termine "Aravis": luogo geografico, nome di qualche popolazione o altro? Passò qualche anno e finalmente, in occasione di una delle dieci tournées a Ginevra ed in Savoia, mentre ci recavamo ad Annecy per un concerto vedemmo un'indicazione stradale per il "Massif des Aravis". Avevamo scoperto da dove veniva il canto che comunque -anche se non più in repertorio- restava fra quei canti che venivano intonati nelle occasioni più varie e non ufficiali.
Nel 1993 Gianni Malatesta ci fece conoscere una sua armonizzazione a quattro voci, che come titolo aveva le parole del primo verso, "Les plaisirs sont doux" e lo eseguimmo per la prima volta, nello stesso anno, nella regione d'origine, in Savoia, il 17 dicembre a Chambery, il 18 nel Castello di Annecy, proprio a pochi chilometri dalla regione montuosa propaggine della catena del M.Bianco, ed il 19 ad Cluses.
Quindi non più un canto valdostano, ma della Savoia.
Lo spartito di Malatesta riportava, però, solo due strofe, le prime due, escludendo la terza e lasciando quindi il canto ... in sospeso. Lucio Finco non ci pensò su troppo e, anche su mio suggerimento che già avevo il compito di presentare i canti durante i concerti, aggiunse subito anche la terza strofa.
Il brano, come si può evidenziare dal testo, è una poesia d'amore nella quale viene esplicitamente descritto un amore profondamente sensuale con un invito a godere della gioventù e ad approfittare della stessa perché un domani non ci sarà più; un testo nello spirito di "Quant’è bella giovinezza, / che si fugge tuttavia! / chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c’è certezza."
Anche Malatesta -nello spartito- lo indica come un canto valdostano e quindi classificabile come "pastorella", componimento poetico, di forma dialogica, diffuso in particolare nella letteratura provenzale e nella letteratura francese medievale in lingua d'oc, dove veniva musicata e cantata.
Altre notizie lo individuano come originario dei "paesi baschi", [2] le regioni meridionali della Francia che confinano con la Spagna e localizzate nei Pirenei, ma anche della zona della catena del Jura situata a nord delle Alpi in Francia, Svizzera e Germania.
Però il testo non è né in lingua d'oc né in lingua basca, ma francese e, forse, è dovuto a qualche poeta raffinato. Questa teoria viene supportata da una notizia che ho trovato in internet e che attribuirebbe il testo a Carlo I d'Orléans (1394-1465) che viene ricordato come compositore poetico con più di cinquecento opere, scritte soprattutto durante i suoi venticinque anni come prigioniero di guerra in Inghilterra.
In queste mie recenti ricerche ho scoperto una quarta strofa che riporto in nota [3] e che conclude con un suggerimento alla giovinetta a non svolazzare troppo di fiore in fiore!
[1] Les plaisirs sont doux / d’être près de vous, la belle.
Je soupire à vos genoux / je brûle d’amour pour vous!
Les plaisirs sont doux, demoiselle, / d’être près de vous!
Peut-on voir les yeux, / sans être amoureux, la belle?
Ils sont doux et gracieux, / ils sont tout remplis de feu.
Peut-on voir les yeux, demoiselle, / sans être amoureux?
Profitez du temps / de vos dix-huit ans, la belle.
Car il deviendra un temps / où vous serez sans amants.
Profitez du temps, demoiselle, / de vos dix-huit ans!
Traduzione
È un dolce piacere / esserevi vicino, bella.
Io sospiro alle tue ginocchia / e brucio d'amore per te.
I piaceri sono dolci, signorina, / per esserevi vicino!
Posso vedervi gli occhi / senza amarvi, bella.
Essi sono dolci e graziosi, / e tutti pieni di fuoco.
Posso vedervi gli occhi, signorina, / senza amarvi!
Godetevi / i vostri diciotto anni, bella.
Verrà il momento / che sarete senza amanti.
Godetevi i vostri diciotto anni, / signorina!
[3]
Plus d'un seul galant,
C'est compromettant, la belle,
Il faut choisir l'un d'entre eux,
Plus d'un seul galant, demoiselle
C'est compromettant.
Più di un innamorato
è compromettente, bella,
devi scegliere uno di loro,
e dare l'addio agli altri.
Più di un innamorato, signorina
è compromettente!
Paolo Pietrobon
L’immagine evocata dal titolo, efficace nella resa dialettale, odora di un’attualità ironica e disarmante, forse sarcastica per certe retoriche di moda oggi (le bombe intelligenti…). Essa impone sulle trincee esauste (magnar pane smarso, dormire par tera /nissun se ricorda / nissùni che scrive /nissun che tien nota / chi more e chi vive), intasate di cadaveri e pregne di un terrore capace di indurre un’assuefazione allucinata per qualsiasi evento possa ancora abbattersi su una sofferenza già grande (silenzio sul fronte. Qualcun ne prepara / un bel funerale, con banda e con bara), il guizzo malefico e lo schianto di una violenza definitiva, incarnata nel ferro e nel fuoco, tale da cancellare, con le vite dei poveri soldati, ogni pensiero, ipotesi, accorgimento.
E sovrappone ai sentimenti e alle relazioni umane, fin prima custodite nelle poche lettere arrivate dalla famiglia, tenute gelosamente nel tascone della giubba e riviste sera dopo sera, dopo la quotidiana devastazione (ecco el fis-cio, / l’ariva, la viene. / Doman sarà festa, vestive par bene ), lo spasimo per una brutalità illimitata, quella sofferenza troppo grande, addirittura la rassegnazione a una morte liberatoria, fino a stipulare un’inconscia intesa con quella bomba che colpirà senza ragione né discriminazione, liberando quadri grotteschi e funerei di banchetto, (Ossst/regheta sorela de fogo / parecime i goti che vegno anca mi! / sorela de fogo / che spolpo imbriago mi voio morir )....di una festa per la quale converrà l’ ‘addobbo appropriato’, le cui tinte alla fine corrispondono a quelle di tanti “formali e regolamentari” riti di commiato per l’ennesimo militare strappato alla vita.
Affresco terribile, universale, al quale l’accezione popolare del linguaggio e la struttura aderente del tessuto melodico aggiungono valore e autorevolezza.
Sergio Piovesan
Nel mondo agricolo sono esistiti, da sempre, dei momenti rituali ciclici che si svolgevano nello scorrere del calendario e legati alla successione degli eventi naturali; con l'avvento del cristianesimo è lo svolgersi della vita di Cristo a sovrapporsi.
Si tratta quindi di momenti rituali che iniziano con il solstizio d'inverno -ed è quello che al momento c'interessa- per proseguire con gli altri riti del resto dell'anno.
Uno di questi riti era il canto della "Chiarastella", di origini antichissime, che veniva eseguito per la questua di fine anno nelle campagne venete, ma che si ritrova in tutt'Italia e propagato, poi, anche altrove.
I protagonisti erano, in genere, persone adulte che, solo successivamente, furono sostituiti da bambini e ragazzetti.
I versi del canto erano ispirati al Natale, dal viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme alla nascita ed all'Epifania, con il contorno di angeli, pastori, comete e magi.
Non si tratta, però, di un unico canto, ma di "edizioni" diverse, nei tempi, nello spazio e nel linguaggio, dovute ad interpretazioni dei testi sacri, magari storpiati, creando, così, dei lemmi che oggi ci sembrano incomprensibili, con differenziazioni sensibili da una borgata ad un'altra.
Cosa sia poi la "chiarastella", o "ciarastela", anche questo dà adito ad interpretazioni diverse in quanto c'è chi la individua nella stella cometa e chi, invece, nella stella costruita con listelli di legno e carta, con all'interno una candela, ed issata su un'asta alla testa del gruppo di questuanti.
L'edizione che esegue il "Marmolada" è quella raccolta ed armonizzata da Gianni Malatesta, un'edizione padovana, che inizia con "Semo qui co 'na gran stela" indicando nella seconda interpretazione quale sia la stella; continua, quindi, con il perché siano lì, cioè
"... per doràre Maria e Gesù,
per portare la novèla
che xé nato el Redentor".
Le strofe di questa edizione sono ben otto e, musicalmente, tutte uguali; per questo motivo, il Coro Marmolada ne esegue solo alcune ritenute più significative, ed anche indispensabili, nel contesto del racconto della Natività. (vedi testo in nota) [1]
La seconda strofa vuole raccontare il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, fra boschi e grotte in una stagione invernale.
Si arriva quindi alla nascita del Salvatore e, nell'ultima strofa, si vede, come appare in molti dipinti, l'adorazione dei pastori con gioia ("... i faxéa alegria ...") cantando "Gloria in excelsis Dei" che, nel canto popolare, viene storpiato in "... in acésis Dei".
Il canto della "Ciarastela", come si diceva prima, era espressione del mondo contadino e, quindi, non conosciuto e non cantato nel mondo cittadino, se non negli ultimi decenni come espressione corale e di ripresa delle tradizioni. Per questo motivo, il sottoscritto, vissuto sempre a Venezia, non ha esperienze di questa tradizione e, pertanto, vi rimanda più sotto all'articolo dell'amico Giovanni Lucio, cavarzerano, che ricorda la "Ciarastela" della sua giovinezza.
NOTE
[1] Il testo de “La Ciara stela” armonizzata da Gianni Malatesta nell’interpretazione del Coro Marmolada
Semo qua co 'na gran stela
per doràre Maria e Gesù,
per portare la novéla
che xé nato el Redentor.
Caminando giorno e note
come fresca xé la stagion,
par i boschi e par le grote
senza vedar la procession.
Arivài a la capana
Madre Maria se lamentò,
la ghe dixe al so amato sposo
“mi so stanca de caminar”.
Co' fu stata mesa note
madre Maria si risvegliò,
si svegliò con gran splendore:
jèra nato el Salvator!
I pastori faxéa alegria
al divino Salvator
i cantava "in acésis Dei",
i cantava de vero cuor.
Registrazione effettuata presso la Chiesa dei SS.Francesco e Chiara a Marghera - Dicembre 2011
La “Ciara stéa”: ricordi ed emozioni
I ricordi del canto della Ciara stela sono, per ragioni anagrafiche, un po' lontani nel tempo, un po' sbiaditi come si dice, tuttavia non del tutto annullati e recuperabili, magari a frammenti, nel vasto prato della nostalgia del passato dove tutto ci sembra essere stato migliore, più bello ed invece è solo perché quel luo- go, quel tempo si chiama giovinezza (non quella che volevano ricantare al prossimo festival della canzone di San Remo).
Allora: la costruzione della stella.
Per prima cosa bisognava procurare dei listelli di buon legno da consegnare a chi, provvisto anche dei necessari attrezzi, fosse in grado di costruirne il telaio a cinque punte.
Non era impresa da poco perché dove- va essere abbastanza grande ma leggera, in quanto la si portava in giro per le strade fissata su di un asse verticale per almeno un paio d'ore ogni sera e per una decina di sere, ma allo stesso tempo doveva essere robusta e fatta ad arte specialmente nella zona centrale dove convergono le basi dei triangoli delle cinque punte e dove le pareti dovevano avere fra di loro una precisa distanza perché lì all'interno si collocava poi il supporto per il cero che doveva illuminare la stella.
Anche se, a dire il vero, negli ultimi tempi il cero era stato sostituito da una torcia a batterie collegata con un filo ad un interruttore (un pereto) che teneva in tasca chi portava la stella; così non si rischiava più che le pareti di carta bruciassero o che la cera del grosso lumino colasse a forarla e, peraltro, la si accendeva solo quando si raggiungeva l'abitazione dove ci si fermava a cantare.
La carta era rigorosamente di colore rosso ed era “carta veina”, che si comprava, partecipando al costo in parti uguali, in quantità superiore allo stretto necessario perché poteva comunque accadere che si bruciasse o strappasse e perché con quella che rimaneva dopo il periodo natalizio, qualcuno si costruiva, in primavera, l'aquilone (el bacaeà) da liberare nel cielo al primo spirare di brezza.
Ovviamente la colla necessaria a fissa- re fra loro i vari ritagli di carta e la stessa sul telaio assieme a qualche “brocheta” (puntina da disegno), la colla, era fatta con “fiore” (farina doppio zero) e acqua.
In possesso della stella, ci si incontrava in quattro-cinque non appena faceva buio e si valutava dove andare, evitando la zona centrale del paese dove abita- vano le famiglie più benestanti ma con tendenza a snobbare i cantori della “Ciara stéa”, nelle borgate, da raggiungere camminando su strade bianche e prive di illuminazione, dove vivevano i meno abbienti ma più sensibili e generosi.
Bisognava inoltre tener conto di dove andavano o erano già andati altri gruppi con la loro ciara stéa.
Era quindi anche una questione di concorrenza.
E bisognava saper “toccare” l'animo, la sensibilità di chi ci ascoltava, ovvia- mente in funzione di ciò che alla fine ne avremmo ricavato; spesso niente ...
E allora, ricordo, qualche sera il gruppo si arricchiva di un suonatore dilettante di spineta (armonica a bocca) o di fisarmonica.
Il testo e l'armonia del canto variavano in funzione della zona del paese dove si andava.
Mi spiego: Cavarzere, dove ho vissuto la mia gioventù, è al limite della provincia di Venezia e confina con le provincie di Rovigo e Padova.
A volte quindi si cantava pure noi la versione padovana, quella riproposta dal maestro Malatesta col suo coro “Tre Pini” ed ora entrata a far parte anche del repertorio del “Marmolada”.
Non ricordo la versione rodigina.
Ricordo però che, specialmente nella versione cavarzerana della “ciara stéa” (per noi non ciara stela) e forse più che in quella padovana, le parole apparivano storpiate ed i versi sgangherati, anche se non privi di nesso logico.
Eccone la dimostrazione, questo cantavamo:
“E' la note di Natale,
una messa vorei cantar.
Canta canta rosa in fiore,
che xe nato el nostro Signor.
El xe nato in una stala,
fra il bue e l'asinel.
La pareva na gran sala,
preparata par se e par lù.
Poverella in questa cà,
ghe domando la carità. (due volte)
Non c'è pani non c'è fuoco,
non c'è fuoco per riscaldar.
La sua mama poverella,
non sapeva più cosa far.
La si leva il velo in testa
per poterlo ricoprir.
La pareva na gran festa
preparata par se par lù.
Poverella ecc.
E si cantava spesso a squarciagola per farci sentire da chi se ne stava rinchiuso in casa e magari già a letto (non c'era la televisione), e per superare nelle borgate di periferia l'abbaiare dei cani.
Alla fine, senza più voce, piedi e mani indolenziti dal freddo si tornava a casa.
Assieme a tanti “grassie putei, bone feste anca a voialtri”, poteva anche accadere che ci si dividevano poche lire.
Ma ci venivano offerte pure delle salsicce, dei “museti” (cotechini) - qualcuno nelle frazioni aveva da poco tempo “copà el porseo” (ucciso il maiale per uso domestico) - e del vino e magari qualche bossolà di pane cotto nel forno a legna. Queste cose le mettevamo in una sporta di paglia per portarle poi a casa di qualcuno del gruppo, in custodia dei suoi genitori fino alla fine dell'anno quando ci si riuniva per una cena in attesa del nuovo anno.
Poi tutto è cambiato, velocemente.
E' arrivato il benessere. E se ne sono andati i presepi dalle case sostituiti dagli alberi di Natale, il canto della ciara stéa nelle strade sostituita da “Tu scendi dalle stelle”, “Bianco Natale” e altre cante note in tutto il mondo e tutte cantate in chiesa, al riparo dal freddo, magari a più voci, magari pure a voci miste: maschi e femmine, con un pubblico silenzioso, pervaso di mistica attenzione.
Ma l'assenza delle voci della ciara stéa nelle strade del paese e delle borgate spogliava il tempo del Natale, almeno per me, di gran parte dell'emozione e della sacralità della ricorrenza di un grande avvenimento.
E' vero che si cantava per ricevere delle offerte, ma il canto era “partecipato”, perché cantavamo la nostra condizione umana.
Anche noi avevamo poco da mangiare, le case male o affatto riscaldate e avevamo poco di che vestirci.
Allora, nessun rimpianto, ovviamente, dello stato di indigenza, solo la nostalgia di un'atmosfera del tutto particolare, forse solo nostalgia della giovinezza, certamente del canto della ciara stéa.
Attorno agli anni settanta però, il canto della ciara stela l'ho ritrovato a Caz- zago, frazione del comune di Pianiga (VE), dove mi ero trasferito con la famiglia e dove un gruppo di parrocchiani ancora lo ripropone ogni anno di via in via reggendo, ahimè, una stella di polistirolo rivestita di carta argentata e raccogliendo offerte in denaro per le necessità della parrocchia e offerte di altro genere consumate poi in una cena conviviale.
Ho fatto parte del gruppo (prima che la stella diventasse di polistirolo) e, anche se versi e melodia non erano quelli della ciara stéa cavarzerana, quella che cantavo da ragazzo, ho rivissuto passate sensazioni, vecchie emozioni.
Che rivivo ora più intense che mai quando con gli amici del coro “Marmolada” canto:
Sémo qua co ‘na gran stèla
par dorare Maria e Gesù.
Par portare la novela …
Sergio Piovesan
Nei primi anni ‘50, all’inizio dell’attività del Coro Marmolada, entrò a far parte del nostro complesso un giovane che proveniva da Genova; aveva fatto parte del Coro Monte Cauriol, di quella città, studiava ingegneria e conosceva anche la musica. Stette poco a Venezia, perché, seguendo la famiglia, si trasferì altrove. Pur essendo stato una meteora nel "Marmolada", tuttavia lasciò il segno, o meglio, lasciò qualcosa che, ancor oggi, fa parte del repertorio del coro: si tratta dello spartito, scritto a matita, di un canto in patois, di una sola strofa, che lui aveva armonizzato. Un pezzo molto bello con un’armonizzazione semplice ma di molto effetto, dal sapore di musica antica, che sembra voler trasmettere le sensazioni delle alte vette. Il giovane di allora, oggi pensionato e residente in Germania, è Enzo Fantini che ha anche collaborato con noi di "Marmoléda", con alcuni articoli di ricordi e di esperienze musicali.
Il canto, però, aveva un unico difetto e cioè quello di essere molto breve perché formato da una sola strofa. Nel 1966 Lucio Finco decise di metterla in repertorio facendo completare il testo con un’altra strofa inventata da due giovani coristi di allora, Massimo Gemin ed Ugo Pomarici. (1)
"La laine des motons" può essere definito come un "canto di lavoro", perché presenta un particolare lavoro, quello dei tosatori di pecore che, nella seconda strofa "apocrifa", trovano un momento di gioia nel danzare, con leggiadre fanciulle, al dolce suono del violino.
Si sapeva che apparteneva all’area francofona ma non se ne conosceva l’esatta provenienza, anche perché non è stato mai trovato nei repertori di altri cori italiani; neppure Enzo Fantini aveva saputo fornire qualche notizia in più.
Il coro l’ha eseguito in concerto anche a Ginevra, in Savoia e nel Delfinato, ma anche in questi luoghi sembrava sconosciuto. E questo fino a qualche mese fa quando Enzo mi inviò fotocopia del testo e dello spartito di questo canto, tratto da un libro edito a Parigi ed intitolato "Jeunesse qui chante - Chansons anciennes harmonisèes", dove si scopre che le strofe sono molte di più (2) e che la regione di provenienza è l’Alvernia, nel Massiccio Centrale, regione ad economia, anche oggi, essenzialmente agricola, dove l’allevamento del bestiame, in particolare quello ovino, è una delle attività principali.
Naturalmente questa novità mi incuriosì ed allora utilizzando la "rete" (internet) ho cercato notizie nel "mondo digitale".
Interessando i siti italiani ho scoperto che il Coro Monte Cauriol è l’unico, oltre al Marmolada, ad eseguire questo canto, però con armonizzazione diversa. (3)
Sono passato quindi ai siti in lingua francese e qui ho fatto altre scoperte interessanti.
In primo luogo ho trovato conferma a quanto indicato nel libro francese e cioè che la sua provenienza è proprio l’Alvernia ed il testo è lo stesso. Ma in quasi tutti i siti è definito non come canto di lavoro ma come un allegro canto per bambini, quasi una filastrocca per accompagnare qualche gioco.
Ho trovato anche un’edizione con la sola prima strofa.
Ma forse la notizia più curiosa è quella che in molti siti, sempre in lingua francese, ho scoperto che "La laine des moutons" viene definito come "canto popolare canadese"(4). Naturalmente si riferisce alla parte francofona di questo stato ed il testo è lo stesso di quello proveniente dall’Alvernia.
Come si sa, però, i canti popolari, nel tempo, vengono anche modificati ed integrati prendendo da altri e questo è il caso di un’edizione, sempre sui siti francesi, in cui, alle originali prime tre strofe, se ne aggiungono altre, con metrica diversa, che raccontano di un lupo che prende quindici pecore alla pastora; intervengono quindi tre cavalieri che salvano le pecore e che, naturalmente, insidiano la pastora. Questa, però, resiste in quanto ha già chi l’ama. Come si può ben vedere, ... tutto il mondo è paese!!!
E concludo evidenziando un altra edizione completamente modificata, con lo stesso titolo ma con un testo completamente diverso che parla di guerre, armamenti, razzismo, bombe e di donne dell’Afghanistan.
NOTE:
(
1) "Au douce son du violon / o jeune-fille o jeune-fille, / au douce son du violon / o jeune-fille dançons, /dançons, dançons ...."(2) Le strofe sono sei: " La laine des moutons, / c’est nous chi la tondaine. / La laine des moutons, / c’est nous qui la tondons, / tondons, tondons, / la laine des moutaines, / la laine des moutons." Le altre strofe rispettano la stessa struttura modificando in ognuna il verbo:
" ... C’est nous qui la lavaine ....
... C’est nous qui la cardaine ...
... C’est nous qui la filaine ...
... C’est nous qui la vendaine ...
... C’est nous qui la chantaine ... "
(3) Armonizzazione Monte Cauriol
(4) Questa notizia conferma la teoria secondo la quale i canti popolari passano da un paese all’altro, da una vallata all’altra, da una regione all’altra, scavalcando anche gli oceani. A volte si perde anche il luogo di nascita del canto stesso.
“ La mia bela la mi aspeta / ma io devo andare a la guera / chi sa quando che tornerò....lo ardada a la finestra...la mia bela aspeterà...il nemico è la in vedetta / o montagne tute bèle / Valcamonica del mio cuor”....Ancora la speranza che cozza contro il richiamo alle armi che tutto copre, costringe all’incertezza, al dubbio...e, improvvisa, la folgorazione di un evento prevedibile e per molti, prima, già funesto: il nemico ad aspettare sul confine, lui pure con la medesima angoscia e rassegnazione che solo può estinguersi con l’annientamento dell’altro. Così non rimane che l’appello affettivo, la speranza sottile in un destino rispettoso di quell’amore di un piccolo uomo per la sua valle, per convincersi di ritrovare l’apparizione rassicurante dei giorni di pace, quando, finito il lavoro, lei aspetta sul davanzale, tra cespi vivaci di garofani, il passaggio dell’amato. Il paesaggio intimo della persona legata ai sentimenti essenziali sovrasta, pur non potendoli esorcizzare, ogni fragore di battaglia, qualsiasi parvenza (che non mancò certamente in chi teneva il timone della tremenda esperienza) di patriottismo di maniera. Rimane la rassegnazione, forse inconsapevolmente anticipatrice di un concetto di patria che solo successivamente altre generazioni avrebbero coscientemente interiorizzato ed apprezzato. A quale prezzo! Anche questo va ricordato.
Sergio Piovesan
Le voci di Nikolajewka
Verso la fine degli anni ’60, all’apparire nel mondo corale di Bepi De Marzi, anche il Coro Marmolada, fra i primi, volle sperimentare la nuova coralità che esprimeva quest’autore che rappresentava, in quel momento, la novità, e quindi lo svecchiamento, nel nostro modo di cantare.
Ed ecco, allora, dopo il più famoso Signore delle cime ed altre, il gruppo di “poesie in musica” ispirate all’epopea alpina della seconda guerra mondiale: Il Golico (campagna di Grecia), L’ultima notte, Joska e Le voci di Nikolajewka (campagna di Russia); le ultime tre trovarono sollecitazione dal libro di Giulio Bedeschi “Centomila gavette di ghiaccio”, uscito proprio in quegli anni, che portava a conoscenza del grande pubblico le vicende ed i drammi umani degli alpini a seguito della sciagurata avventura bellica voluta dal governo fascista di allora.
Nikolajewka è la località spersa nella vasta pianura russa, dove scorre il fiume Don, divenuta famosa per la battaglia disperata ingaggiata dagli uomini della “Tridentina”, unitamente a quelli d’altre unità combattenti alpine, per uscire dall’accerchiamento che l’esercito sovietico aveva creato attorno a queste truppe e ad altri quarantamila sbandati sia dell’armata italiana sia delle forze alleate (tedeschi, ungheresi e rumeni).
Il 26
gennaio 1943, con 30° gradi sotto zero, dopo giorni di ritirata sempre
incalzati dalle truppe e dai partigiani russi, con equipaggiamento
“standard”, cioè che andava bene sia in Africa sia in Russia, e con armi
inadeguate
(arma individuale era il moschetto mod.1891), gli alpini, quasi con un
atto disperato, urlando e brandendo i fucili a mo’ di clava dopo aver
terminato le munizioni, incitati del loro comandante, il generale
Riverberi, che dall’alto di un carro armato tedesco, a più riprese,
urlava “Avanti Tridentina!”, riuscirono a rompere l’accerchiamento
prendendo di sorpresa i russi che rimasero sbigottiti di tanta irruenza.
sbigottiti di tanta irruenza.
Ma la vittoria non fu incruenta! Gli alpini, che già erano stati decimati nelle settimane precedenti dal meglio equipaggiato ed armato esercito sovietico, ma, soprattutto, dal grande gelo dell’inverno russo, lasciarono migliaia di morti e di feriti sulla neve della piana di Nikolajewka che precedeva il terrapieno della ferrovia oltre la quale si apriva la via del ritorno a casa.
Le voci di Nokolajewka non contiene un testo, ma solo una parola, Nikolajewka, che scandisce la musica di questo canto con una melodia minimamente ispirata alla musica popolare russa, una melodia che, sembrando provenire da lontano, ricorda dapprima il miraggio della salvezza che per molti, invece, termina con le urla di chi è senza speranza; sono quindi le voci della disperazione che ci vogliono ricordare quanto la guerra sia crudele, brutale e disumana, qualsiasi guerra, anche quella che oggi è considerata “giusta”. Non esistono guerre di questo tipo! Fu, quella che termino 60 anni fa, una guerra che sconvolse il mondo e che procurò immani sofferenze ai soldati, alle popolazioni civili ed alle comunità ebraiche.
E noi cantiamo Le voci di Nokolajewka, e lo canteremo sempre invitando il pubblico ad ascoltare il brano nello spirito del ricordo e come ammonimento per adoperarsi tutti affinché non vi siano altre “Nikolajewke”.
Le voci di Nikolajewka
La musica avvolge un’intera epopea di uomini, si libera anche della parola, in un unico vortice sonoro che a me riporta l’enfasi etnica dei cori della tragedia greca, gli strappi e gli unisoni di un’arpa cosmica, dell’eco di noi, creature indisponibili allo smarrimento di un destino non limitato alla storia contingente.
“Nicolajèvka”, epica tremenda, tragedia di un popolo di alpini oppresso dalle atrocità di una guerra idiota, inchiodati dal ghiaccio dell’inverno russo alla fame e alla dissoluzione per freddo, azzannati, passo su passo, dalla controffensiva russa, che non poteva distinguere tra quegli uomini d’onore e chi li aveva scaraventati in un’aggressione perversa; un salto nel vuoto oltre il quale potesse avverarsi il sogno della sopravvivenza: tutto racchiuso nel rincorrersi senza fine di quella sola parola, di quell’urlo dietro il quale scagliare tutta la forza residua, e la disperazione, per trovare un varco, perché tutto il dolore e tutta l’amarezza erano state provate, fino all’ultimo fiato…
Nicolajèvka! Nicolajèvka!....Nicolajèvka!....
In canti come questo si ritrovano le ispirazioni e le attitudini per un canto corale di ispirazione popolare “modernamente” suggestivo, per la discontinuità della melodia e dei contesti armonici e per l’aggiornata poetica dei testi, i quali trattano di guerra, ma alludendovi in senso universalistico, e sono collegati a un “risentimento interiore” di essa post-risorgimentale e post-unitario, formatosi negli anni della “guerra fredda” e del ricorso sempre più frequente a strategie ed organizzazioni belliciste di carattere globale, in sostanza alla sensazione drammatica del fatto che, oggi, qualsiasi politica di guerra assume un carattere di oscuramento e negazione della speranza di vita per intere generazioni, su scala planetaria.
Non rimangono forse del primo tremendo olocausto nucleare, simbolicamente e moralmente, due semplici parole? Hiroshima…Nagashaki!
Le voci di Nicolajevka, ove la musica, quasi universo materico che avvolge e sublima un’intera epopea di uomini, si libera anche della parola, riproponendo in un’armonia integrale, in un unico ed unitario vortice sonoro che a me riporta il pathos e l’enfasi etnica dei cori della tragedia greca, gli strappi e gli unisoni di un’arpa cosmica, dell’eco di noi, creature indisponibili allo smarrimento di un destino non limitato alla storia contingente, nel grande processionale delle umane epiche, alla corte di Omero e degli eroi simili a dei.
“Nicolajevka”, dunque, per finire: un’epica tremenda, la tragedia di un popolo di alpini accerchiato e quasi annientato dalle atroci sofferenze di una guerra idiota e mal governata, inchiodati dal ghiaccio dell’inverno russo alla fame e alla dissoluzione per freddo, azzannati passo su passo del Calvario di una disperata fuga dalla controffensiva russa che non poteva distinguere tra quegli uomini d’onore e chi li aveva scaraventati in un’aggressione perversa, un salto nel vuoto oltre il quale potesse avverarsi il sogno della sopravvivenza, del ritorno alla vita: tutto racchiuso nel rincorrersi senza fine, nella canzone, di quella sola parola, di quell’urlo immane dietro il quale scagliare tutta la forza residua, e la disperazione, per trovare un varco, ad ogni costo, perché tutto il dolore e tutta l’amarezza erano state provate, fino all’ultimo fiato, oltre le mille parole di una folla di morenti, oltre l’assurdo. Nicolajevka! Nicolajevka!....Nicolajevka!....
Quando la canzone d’ispirazione popolare attinge alla "profezia"
L’occasione: Quando uscirà questo articolo avremo ancora a mente la grande adunata nazionale degli alpini di Treviso, 12, 13, 14 maggio. Centinaia di migliaia di baldi e simpatici ‘combattenti di pace’, portatori di inattaccabili valori morali e patriottici, con lo sguardo alto sulle sorti del mondo intero ove sono tanti di loro impegnati, così come lo furono i ‘ veci ’ in tante drammatiche pagine di storia. Per riferirmi a tutto questo ho scelto di commentare, oltre il dato meramente tecnico, una canzone altamente simbolica del ‘valore alpino’, di una delle stagioni più cruente e tragiche di tale arma, quella scatenata dalla follia della guerra mussoliniana, a braccetto con il delirio omicida hitleriano, e di una fanatica assurda allucinazione di potere senza limiti né contraddittorio, a costo di milioni di morti e dello sterminio parzialmente riuscito di un intero popolo, quello ebreo.
Il momento storico
Da un intervento sulla Stampa del 23 gennaio 1963 di Nuto Revelli, che fu ufficiale alpino del Tirano in quella ritirata e poi partigiano: «Tutti eravamo più o meno congelati. Il nostro equipaggiamento, già disastroso all'inizio della ritirata, era ridotto a brandelli. Durante gli otto giorni di marcia, quasi tutti avevano gettato gli scarponi di tipo "standard", uguali per la Russia come per l'Africa, perché i piedi congelati gonfiavano, e li avevano sostituiti con strisce o involti di coperte. C'era anche gente scalza o con i piedi fasciati di paglia. Sotto i cappotti con l'interno di pelliccia indossavamo divise di falsa lana, dura come spilli. Gli unici indumenti caldi erano le calze e le maglie che c'eravamo portati da casa nostra al momento della partenza dall'Italia…
Nella notte fra il 25 e il 26 gennaio ( 1943 ), la temperatura riprese a scendere, sui 30° sottozero. Io dormivo in un'isba alla periferia di Nikitowka, verso Arnautowo. Eravamo una trentina, accatastati uno sull'altro…. Verso l'una sentimmo gli scoppi vicini, come di bombe a mano. Qualcuno disse che c'era l'allarme, ma eravamo disfatti e nessuno ebbe la forza di alzarsi. In quel momento era iniziata la battaglia per Nikolajewka…. Lo scontro durò violentissimo sino alla tarda mattinata. Gli ufficiali andarono all'assalto alla testa dei loro alpini, con le armi che per il gelo si inceppavano.
Mentre si combatteva sotto il tiro degli anticarro e delle mitragliere russe cercando di superare il terrapieno, il generale Nasci ordinò di gettare in avanti tutto il peso della sterminata colonna degli sbandati. Migliaia di uomini, in uno spaventoso groviglio di slitte e muli, rotolarono urlando verso il trincerone della ferrovia. Alla testa erano i generali Reverberi e Giulio Martinat, capo di Stato Maggiore del Corpo d'Armata Alpino. Con loro erano i capitani Giovan Battista Stucchi e Giuseppe Novello e altri ufficiali.
Le perdite italiane furono altissime, ma nonostante ciò la battaglia rappresentò un successo poiché le truppe superstiti, pur decimate e completamente disorganizzate, riuscirono a raggiungere Shebekino il 31 gennaio 1943, località al di fuori della "tenaglia" russa. Il 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata, il Corpo d'Armata Alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolaevka si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 7.500 feriti o congelati. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o catturati. Migliaia di soldati vennero presi prigionieri durante la ritirata e radunati dai sovietici in vari campi.
Nicolajewka
La ‘sacca’ dell’ultima speranza di sopravvivenza. Un’epica tremenda, la tragedia di un popolo di alpini accerchiato e quasi annientato dalle atroci sofferenze di una guerra idiota e mal governata, inchiodati dal ghiaccio dell’inverno russo alla fame e alla dissoluzione per freddo, azzannati passo su passo del Calvario di una disperata fuga dalla controffensiva russa che non poteva distinguere tra quegli uomini d’onore e chi li aveva scaraventati in un’aggressione perversa, un salto nel vuoto oltre il quale potesse avverarsi il sogno della sopravvivenza, del ritorno alla vita: tutto racchiuso nel rincorrersi senza fine, nella canzone, di quella sola parola, di quell’urlo immane dietro il quale scagliare tutta la forza residua, e la disperazione, per trovare un varco, ad ogni costo, perché tutto il dolore e tutta l’amarezza erano state provate, fino all’ultimo fiato, oltre le mille parole di una folla di morenti, oltre l’assurdo. Nicolajevka! Nicolajevka!....Nicolajevka!....
Le voci di Nicolajevka, ove la musica, quasi universo materico che avvolge e sublima un’intera epopea di uomini, si libera anche della parola, riproponendo in un’armonia integrale, in un unico ed unitario vortice sonoro che a me riporta il pathos e l’enfasi etnica dei cori della tragedia greca, gli strappi e gli unisoni di un’arpa cosmica, dell’eco di noi, creature indisponibili allo smarrimento di un destino non limitato alla storia contingente, nel grande processionale delle umane epiche, alla corte di Omero e degli eroi simili a dei.
In canti come questo si ritrovano le ispirazioni e le attitudini per un canto corale di ispirazione popolare “modernamente” suggestivo, per la discontinuità della melodia e dei contesti armonici e per l’aggiornata poetica dei testi, i quali trattano di guerra, ma alludendovi in senso universalistico, e sono collegati a un “risentimento interiore” di essa post-risorgimentale e post-unitario, formatosi negli anni della “guerra fredda” e del ricorso sempre più frequente a strategie ed organizzazioni belliciste di carattere globale, in sostanza alla sensazione drammatica del fatto che, oggi, qualsiasi politica di guerra assume un carattere di oscuramento e negazione della speranza di vita per intere generazioni, su scala planetaria.
Non rimangono forse del primo tremendo olocausto nucleare, simbolicamente e moralmente, due semplici parole? Hiroshima…Nagashaki!
Anche se la storia non sembra riuscire buona maestra, magistra vitae ci spingevano a credere, a replicare nella relazione sociale, per riconoscerci buoni discepoli del buon insegnamento. Nella debolezza diffusa delle democrazie di un secolo che aveva saputo – e ne mostrava vanto - non ripiombare in una guerra deleteria, la terza guerra di un mondo che pare troppo spesso votato all’autodistruzione, rinascono le teorie definitive, indiscutibili; personaggi pronti al rischio-limite occupano volitivamente gli schermi e le voci della pubblica informazione, dell’immaginifico sociale; parate militari dalle geometrie farneticanti, dalle rinnovate autarchiche enfasi declamatorie, di triste vicina memoria, occupano senza pudore lo spazio collettivo dell’informazione, smentiscono il ricordo delle recenti carneficine; e ovunque in un mondo lacerato e sconnesso da nuove e vecchie ingiustizie sociali, da protagonisti settari autoproclamatisi tribuni di vementi irriducibili proclami di nuove verità a loro stessi riconducibili, a prescindere dalla fatica del dialogo e della possibile cooperazione, si allarga pericolosamente il ricorso ai metodi della contrapposizione violenta, radicalmente.
( Testo di C. Geminiani – Musica di B. De Marzi )
Ancora una rivisitazione di un canto che racconta gli alpini, ma con gli accenti e le risonanze morali e storiche di un evento e di un’esperienza universali.
Notte e guerra, oscurità e maledizione, silenzio e sentimento, preghiera, orrore di un sacrificio imposto ( quasi sempre dagli uomini, in fondo ) e rassegnazione consapevole di un’umanità scagliata dalla storia al pericolo estremo, all’annullamento del proprio diritto alla vita, ad un ‘ tempo buono ’.
Non si muore di notte sulle rotte mediterranee dell’esodo millenario, oggi? Non si muore e si uccide, anche per difesa, come tutte le altre volte, in decine di teatri di guerra? E via così, con facile elencazione…
Eppure anche su tutto ciò torna il Natale, tutti i Natali, comunque si sappiano risuscitare nelle contrade del pianeta. Eppure l’umano rincorre in sè la sembianza del grande ‘spirito’, della sperabile armonia civica e civile, di un contesto pacificato e pacifico che, in ogni modo, un po’ giustifichi le fatiche, le sconfitte, le coraggiose avventure di chi tale ‘ natale’ abbia onestamente, intelligentemente preparato, a cominciare da se stesso.
E ancora la magia etica e poetica di Carlo Geminiani e Bepi De Marzi.
"... La notte di Natale calò sulla distesa bianca; era patetica e struggente come solo i soldati in trincea la sentono, lontani da ogni bene, dispersi nel silenzio, prossimi alle stelle… ” (Giulio Bedeschi); “ ….Il campanile scocca / le undici lentamente. / La neve! – ecco una stalla! – Avrà posto per due? / - Che freddo! Siamo a sosta – Ma quanta neve, quanta! / Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue… / Maria già trascolora, divinamente affranta…. / Il campanile scocca / la mezzanotte santa… ” (Guido Gozzano, ‘La notte santa’); “ ….Pur tu, solinga, eterna peregrina, / che sì pensosa sei, tu forse intendi, / questo viver terreno, / il patir nostro, il sospirar, che sia; / che sia questo morir, questo supremo / scolorar del sembiante, /e perir dalla terra, e venir meno / ad ogni usata, amante compagnia…” (Giacomo Leopardi, ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’)….
Universali, innumerevoli gli accenti con cui abbiamo cantato alla luna, e alla notte, che le fa da abito, impenetrabile e scintillante all’occhieggiare delle stelle, e i messaggi, le emozioni ad essa affidate nel silenzio di tutto attorno, a cominciare dalle mai bastanti notti dedicate da Penelope allo sfacelo della tela diurna per l’angoscia dell’attesa del suo Ulisse, per finire con le notti di Rafael in ‘Per chi suona la campana’, il gitano dei partigiani antifranchisti arrampicato sull’albero per la guardia alla postazione montana, incantato dallo splendore tranquillo di donna luna.
Non diversamente dovette essere, almeno per qualche istante e nonostante il fragore distruttivo imposto dalla circostanza, per i nostri soldati scaraventati e dispersi nella steppa ghiacciata della Russia nel Gennaio del 1943. Fin troppo facile farsene un’idea: il candore tacito della neve, uno spazio infinito, tale da dilatare senza confini le solitudini, le nostalgie insistenti dei tocchi di un campanile natìo, del calore dell’augurio natalizio sulla piazza del paese troppo lontano, della commozione palese per l’avanzarsi sul presepe di pastori e timide pecore, e di quella greppia, pur simbolica, del riparo cercato disperatamente per il piccolo dio che deve nascere: greppia, cuna, grembo, come la più tetra trincea, nel freddo e nel buio, come per Lui, quando l’annegare in quel giaciglio stinto offre l’unica speranza di salvezza. Nel Gennaio, prima dell’ultimo ‘folle’ impeto liberatorio di Nikolajevka (1), ma in tante altre notti, anche dei Natali vissuti laggiù, senza alternativa…
E nemmeno per altri uomini, di ogni zolla del pianeta, non soldati, né eroi avventurosi, ma uomini ‘normali’, uomini in viaggio, nel viaggio più comune e più faticoso, altrove greve, di tanti inevitati esistenziali accidenti, qui pure per lo sguardo indagatore di un pastore errante, forse, lui, senza stella che lo guidi.
Così mi pare adeguato il tentativo di cogliere, come sempre va fatto, il sottostrato, la profondità dell’invenzione poetica e musicale dell’ennesimo umanissimo bozzetto tracciato da Geminiani e De Marzi attorno alla vicenda limite di quei soldati, in quella loro notte, in quella decisione senza alternative, sfondare domani o perire, per un atto impervio e oscillante, tra ciò che – poi, sui libri o nei racconti dei superstiti – verrà osannato quale eroismo e altro che, lì e in quelle ultime ore, meglio assomigliò a una disperata illimitata sofferenza da accettare, tanto quanto la violenza necessaria, e residuale in quelle condizioni, per uno spiraglio di salvezza ( “ … Eppure alcuni sono riusciti a salvarsi, certo a un prezzo greve … dopo avere conosciuto i confini infiniti della violenza e della morte […] per una conclusione mostruosa ma che appartiene alla nostra storia…e rende il peso spaventoso della rinuncia e della viltà…” ( Carlo Bo, ‘Centomila gavette di ghiaccio’, Presentazione).
Quale viltà? Quella degli ordini diramati alle stazioni di arrivo dei sopravvissuti, ove una marcescente ragion di stato consente e pretende si faccia strame di quegli sciagurati eroi di una vicenda patetica e terribile nelle sue conseguenze: “…gli alpini erano scesi, toccavano il suolo con i cenci dei piedi e fissavano la terra con occhiate sospettose…
- In vettura! Chiudere i vetri dei finestrini! Nessuno esce più, alle stazioni è vietato affacciarsi!
- Non siamo bestie! Aprite, aprite! – gridavano gli alpini riabbassando i vetri e scuotendo invano le maniglie… - Siamo gli alpini! – gridavano…
- La popolazione non vi deve vedere: è l’ordine…che alpini o non alpini! Ma vi vedete? – urlò allora ai rinchiusi il ferroviere; - vi accorgete sì o no, Cristo, che fate schifo?...” (Giulio Bedeschi, ‘Centomila gavette di ghiaccio’).
Così, ora, meglio ci appaga il fluire piano del canto - e l’irrompere forte dei ‘crescendi’ negli attimi concessi alla rassegnazione greve o alla speranza risuscitata del ritorno -, e del suo tessuto, di oculata e struggente armonia: “ Era la notte bianca di Natale / ed era l’ultima notte degli alpini; / silenzioso come frullo d’ale / c’era il fuoco grande nei camini. / Nella pianura grande e sconfinata / e lungo il fiume - parea come un lamento - / una nenia triste e desolata / che piangeva sull’alito del vento. / Cammina cammina /la casa è lontana / la morte è vicina e c’è una campana/ che suona, che suona:/ Din don, dan... / … Tutto ora tace. A illuminar la neve / neppure s’alza l’ombra di una voce / lo zaino è divenuto un peso greve;/ ora l’arma s’è mutata in croce… / … Lungo le piste sporche e insanguinate / son mille e mille croci degli alpini, / cantate piano, non li disturbate, / ora dormono il sonno dei bambini. / Cammina cammina / la guerra è lontana / la casa è vicina / e c’è una campana / che suona, ma piano: / Din, don, dan...”.
Per non dire del commovente recitato che, in un profondo baritonale, s’accompagna al fluire delle note: “Mormorando, stremata, / centomila voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, / avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigioverde. / Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. / Gli alpini vanno come angeli bianchi / e ad ogni passo coprono una fossa”.
Il frullo d’ali del fuoco crepitante, nell’isba provvidenziale, messo a bruciare quel che resta dello sciancato carriaggio… la deformazione, e fraintendimento consolante, del frusciare dell’acqua nel fiume, e il soffio del vento, quasi a dar suono a un flauto colloquiale… la casa (salvezza) e la morte (destino ampiamente prevedibile) in un canto e controcanto drammatici, nelle emozioni senza limite, pur nella stanchezza infinita, dell’anima e del corpo… un’ombra che sembra voce, quella di un fantasma? Di un altro che cade?... e l’arma, così pesante eppur amica, essa pure ora croce, allusione confortante, quando sosta ritta nel ghiaccio a te accanto… Quel delicatissimo, amante sussurro a non destare quegli alpini abbandonati nella neve, inerti e interamente indifesi, come bambini nel sonno… e l’ultimo spaventoso equivoco, quei ragazzi, e padri di famiglia, e instancabili conduttori di mulo, e valorosi ufficiali… a cader giù, crudamente, spietatamente, quasi angeli essi stessi, bianchi angeli purificati dalla morte immeritata, a regalare una parvenza di protezione, una carezza ultima agli altri come loro, nelle mille fosse, in attesa….
(1)
“L'ultima battaglia della nostra ritirata di Russia, la battaglia della
disperazione e della salvezza per sfondare lo sbarramento sovietico a
Nikolajewka, iniziò all'una di notte del 26 gennaio 1943”
(Nuto
Revelli, La Stampa, 23 gennaio 1963).
Sergio Piovesan
Si sa, siamo in un periodo in cui c’è chi contesta anche l’evidenza o chi vuole fare del revisionismo storico. Ed allora portiamoci anche noi su questo binario, o meglio su un binario simile, dove la materia trattata è, senz’altro, più leggera, e più consona al nostro modo di vedere e di sentire.
Entriamo nel modo delle favole che, fin da piccoli, ci hanno affascinato. Ma visto che, volenti o nolenti, siamo passati, crescendo, anche attraverso il periodo della contestazione “sessantottesca” proviamo a riscoprire, o a rivedere, una delle più famose fiabe, non solo italiane, ma mondiale.
La revisione, se così vogliamo chiamarla, forse farà rivoltare nella tomba quel Carlo Lorenzini, il Collodi, che, nel lontano 1881, iniziò a pubblicare, sul “Giornale per bambini”, la “Storia di un burattino” che, due anni dopo, raccolto in un volume, divenne “Le avventure di Pinocchio”.
Il riferimento al ’68 di cui sopra non è fuori luogo perché l’autore del testo e della musica, Alessandro Baggiani(1) , anche se nel 1968 era nato da poco, ha girato di 180° quella che possiamo definire la “morale” del burattino che, dopo le avventure che tutti conosciamo, diventa un bravo bambino.
È nato così un canto, dal testo molto ironico e contestatore, nel quale il protagonista è un burattino che non vuole assolutamente diventare “un bambino in carne e ossa”; e per farlo, contrariamente al vero Pinocchio, dice la verità. “Non ho voglia di studiare… ” afferma all’inizio e non prova neppure ad andare a scuola perché “ … il cervello mio è di legno“. Nasce tutto dal fatto che il suo “ …. babbo, poverino, non voleva restar solo. … “ e lui, anche con un cervello di legno, comprende le esigenze paterne, ma, evidentemente, non può e non vuole assecondarlo.
Sincero al massimo questo burattino ed anche determinato tanto che ce ne ha anche per la fata alla quale dice chiaro e tondo: “Io non voglio diventare -fata la faresti grossa- un bambino in carne e ossa.”. Non è un burattino al quale crescerà il naso! Veramente un bel carattere “tosto”!
Questo canto, che abbiamo sentito per la prima volta, pochi mesi fa, a Firenze, ci è piaciuto ed è stato deciso di apprenderlo; fra breve lo presenteremo al pubblico e siamo sicuri che sarà gradito, oltre che per il testo (2) anche per la musica.
NOTE
1 Alessandro Buggiani (1965) è nel Coro Monte sagro di Carrara come baritono dal 1983 e lo dirige dal 1993. Autodidatta negli studi musicali ha studiato composizione privatamente con Andrea Nicoli. Compone musiche di scena per spettacoli teatrali e lavora come attore.
2 M'hanno fatto burattino!
Non ho voglia di studiare, / ma la colpa non è mia: / io c'avrei di molto ingegno, / ma il cervello mio è di legno.
M'hanno fatto burattino, / ma non sono mai contenti: / dopo tanto gran lavoro, / ora vogliono un bambino!
Non ci sto, io me la batto. / Esco fuori, vado in giro. / Io non voglio diventare / -fata la faresti grossa - / un bambino in carne e ossa!
Io non so che c'è di male / se vi grido il mio sdegno; / ad ognuno il proprio corpo / ed il il mio resta di legno.
M'hanno fatto burattino, / li ringrazio e son contento. / Se volevan qualcos'altro, / hanno perso il loro tempo.
Il mio babbo, poverino, / non voleva restar solo. / Lo capisco, ma non posso / diventare un bel bambino: / sono nato burattino.
M'hanno fatto burattino, /
me ne scappo lesto, lesto. / M'hanno fatto burattino, / ora burattino
resto! / Ora burattino resto! / Ora burattino resto!
M'hanno fatto burattino? / Ora burattino resto!
I canti dei soldati - Origini e curiosità
“Mamma mia vienimi incontro” oppure “Ti conterò le storie che nell’Africa passò”
Nelle mie ricerche, tanti anni fa, mi capitò tra le mani un libricino contenente aneddoti e squarci di diari di guerra; anzi il libro non era neanche completo: senza copertina, squinternato, stavo quasi per gettar lo. Con sorpresa, leggendo qua e là tra i rimasugli di alcune paginette, ti trovo con sorpresa la soluzione della domanda che sempre è stata alla base delle mie scelte dei canti da mettere in repertorio al Coro Marmolada: da dove proviene il canto? da chi e come è stato ispirato? in che periodo o collocazione storica è da collocarsi? tutte domande alle quali non sempre sono riuscito a dare risposta.
Il canto di cui trattasi lo conoscevo già. Era un brano non tanto noto tra i canti di guerra, poco cantato al confronto di "Monte Canino" o "Il Capitan della compagnia" o "Ta Pum" ecc. tutti legati alla grande guerra 1915-1918. Ed era con un andamento armonico molto diverso dai "classici": queste furono le mie elucubrazioni, improvvisamente chiarite. E ve lo racconto, vale la pena anche perché in seguito l'ho messo in repertorio.
Dal diario del sottotenente Bruno D'Agostini:
Ghinda, 14 Ottobre 1935
"... Caielli, della decima compagnia, ha organizzato intorno un coro a bassa voce. Cantavano così quelli del 1896. La canzone è triste, ma va bene per la marcia, di notte: con certi pesi sulle spalle e tanti chilometri davanti. Siamo in trasferimento da Ghinda a Nefasit. Gliel'ha insegnata suo nonno, reduce da Adua."
Sic! Penso non ci siano commenti ulteriori. Questa è storia, storia vera. E questo è il fascino del canto popolare.
Per i più interessati all'approfondimento, unisco il testo completo, assai illeterato nella sua originalità popolaresca, e la musica, trascritti dal sottotenente D'Agostini stesso, dimostrando così anche un'ottima conoscenza musicale. Grazie a lui il canto è arrivato, pur con qualche cambiamento-adattamento'(1), ai giorni nostri.
(1)Il verso "che ci vuole i fantaccini" è, probabilmente, stato variato nella guerra del 1935 in quanto l’unità del sottotenente D’Agostini era un’unità di fanteria.
C’è un episodio relativo alla battaglia di Adua (28-29 febbraio 1896) che, forse, può chiarire perché il verso è più logico con “alpini” che non con “fantaccini”.
Il generale Oreste Baratieri, che non era alpino (inizio la carriera militare come volontario nella “spedizione dei mille” e poi passò nei bersaglieri), era governatore dell’Eritrea e comandante supremo.
Era già stata proposta, da parte del governo italiano, la sostituzione di Baratieri con altro generale il quale aveva tergiversato, attendendo momenti più opportuni. Baratieri, probabilmente presentendo la sua sostituzione, forzò la mano, dopo aver sentito anche il suo Stato Maggiore, e ordinò alle truppe di attaccare gli abissini anche se, pur se con armamenti di qualità inferiore, numericamente superiori.
Durante la battaglia, nei pressi di Adua, le truppe italiane, pur se decimate, combatterono strenuamente. Il generale Baratieri notando il valore degli alpini li chiamò attorno a sé e, poiché essi fecero scudo con il proprio corpo sacrificandosi, si salvò.
Dei 945 uomini che componevano il 1° Btg.Alpini d’Africa ne tornarono in tutto 100 di cui un ufficiale ed un sottufficiale.
Il canto “Mamma mia vienimi incontro”, molto probabilmente, è un canto degli alpini che, nella successiva guerra coloniale, iniziata il 3 ottobre 1935, per riconquistare Adua ed allargare il dominio su Etiopia ed Abissinia, fu senz’altro, a mio parere, leggermente modificato; infatti sui monti non ci sono “i fantaccini”, ma gli alpini ed inoltre, come accennato sopra, Baratieri chiamò a sé proprio gli alpini.
E’ la storia di un ‘ vincitore ’, uomo comune travolto dalla guerra: universale la simbologia, sventura e predestinazione l’antefatto e l’effetto, fino al punto di ritenere vera disgrazia il fatto di essere stato ‘graziato’ ( ‘per disgrazia ritornò dal fronte’ ).
Uomo-soldato, come i tanti sempre chiamati a quella maledizione, forse, chissà, anche i moderni ‘rambo’ della guerra tecnologica e ‘professionale ’ in fondo a se stessi, nel pozzo privato delle emozioni incedibili? Sconvolto, letteralmente, dalla guerra dei ‘grandi’, oltreché – ma fu assai spesso conseguenza irresistibile - defraudato da quella dei ‘piccoli’ (la fragilità di chi rimane, anche una moglie innamorata), dal ‘ si salvi chi può.…poco importa come…. ’ generato dall’oscuramento della ragione e riversato impietosamente sulle creature ‘minori’ della più crudele lotta di sopravvivenza: le cento corna in fronte al posto dell’alloro al valore.
Ma prima, e insieme, l’ambiguità tristissima di quella donna, essa pure sconvolta, per la quale, nelle parole terribili perché candide del figlioletto alla porta, non si sa comprendere se tra i ‘mestieri’ necessari alla sopravvivenza esistano le voglie più riposte di uomini depredati loro pure, nella contestualità di uno strazio fisico e morale illimitato, della ‘continenza’ altrimenti ( nel tempo della pace, della razionalità, dell’umanità) dovuta a quella donna e in quella situazione …. ghe xe posto par tutti i congedati / qua i militar soldati / fan tappa note e dì …. Quando la stessa popolare domestica parlata, la voce consuetudinaria e rassicurante della borgata, per le altre occasioni complice e solidale, cede al demolitivo pregiudizio risuscitato surrettiziamente dalla guerra cattiva, e a quella fragile donna imputa, quasi a lei prima che all’evento, l’epiteto oltraggioso mormorato, a fior di labbra, a carico del marito-soldato: ‘cornuto’.
Ancora la donna colpevole più degli altri, la donna che doveva resistere, a prescindere, donna tra altre che nelle guerre, sul baratro dello smarrimento assoluto, di una notte che poteva essere l’ultima, di una disperazione debilitante di quei soldatini, loro sì da compatire…. aveva donato uno squarcio di tenerezza, o colto per sè un’intuizione di sopravvivenza.
Il bravo soldatino attende con il cuore in gola di vedere salvato lo spazio della felicità sufficiente, ne declina minuziosamente gli elementi cardinali, nel paesaggio e nelle presenze umane, ‘tre case e l’osteria, la ciesa col piovan’…. ‘la me muière, la me putèla’, le condizioni perché la vita sia ‘bella’, e la libertà esista, per lui almeno.
Il trauma della sostituzione, la perdita di un amore forzatamente esposto all’oblìo, la disintegrazione della speranza, dell’unico barlume che fu capace di ‘sospendere’ i fendenti della cieca violenza per quei ‘sinquani manco un mese’, hanno ora la forza di un fulmine annientatore all’apparire sulla porta illuminata di un bambino sconosciuto, angelo incolpevole nell’annuncio del dramma consumato, irrimediabile.
Ma non sopravviene alcuna violenza, nemmeno la recriminazione.
A soccorso del soldato rimane solamente il rientro nella propria cultura generativa, un po’ amore etico, un po’ compassione, e rassegnazione, con l’unica certezza del saper dare l’affetto elementare a chi può riceverne senza perciò costituire ‘contratto’, ‘promessa’, ‘pretesa possessoria’: a quel bambino, alla sorellina, anche quella donna smarrita, perché mamma di quei cuccioli, e donna amata, una volta per tutte. E addirittura la bugia sulla propria identità, per non costringere a ulteriori sofferenze, a prezzo di annullare se stesso e i propri sentimenti….. tanto, quella guerra li ha abituati a essere carne da macello, e poco meno di nulla.
A volerne fare simbolicamente uso, e speranza che vinca la brutalità dei nostri giorni - sui più piccoli, sui più sventurati, sulle troppe donne rese vittime del sussulto virile perverso, quello della sopraffazione, di un diritto inutile e improponibile al primato del ‘maschile’, o del più ‘forte’, a prescindere - quale lezione di umana generosa filosofia, di tensione all’universale perfetto, quello dell’amore e del suo oggetto, anche fuori e contro la storia contingente, promana dai versi della ‘povera’ canzone, del suo ritmo piano, del suo ripercorrere sui passi di un triste acciottolato l’ennesima vicenda della speranza e della disillusione, radicali entrambe, ma del rispetto insieme, della ‘compassione’, a costo della riduzione di quel diritto soggettivo alla rivalsa, all’imposizione, alla soppressione perfino dell’oggetto mancato del nostro desiderio d’amore, anche a costo di un’infelicità accessoria e debilitante.Sergio Piovesan
In occasione dei Concerti di Natale 2005, il “Marmolada” ha presentato un nuovo inserimento nel repertorio dei canti usuali in questa festività. Il suo titolo è: “Maria lavava”, titolo determinato, come succede spesso, dall’incipit del testo. Lo spartito dell’armonizzazione del Coro Monte Cauriol, cioè di Armando Corso direttore del coro stesso, indica come provenienza del canto la Toscana.
Avendo avuto occasione di ascoltare questa melodia con altre parole ho cercato di scoprire la vera provenienza di questo brano che, a dire il vero, è abbastanza conosciuto in tutta Italia.
Gran parte dei testi simili all’edizione che noi eseguiamo 1 li troviamo anche in altre regioni dell’Italia centrale con piccole varianti. Nella stessa Toscana c’è un’edizione 2 dove questo canto, con una strofa in più, usa dei termini più vicini al fiorentino ( ad es.: “ … ché fame aveva … “ usando il “ché” al posto del perché, oppure “ … del pane ‘un ce l’ho … “ dove “‘un” ha il significato di non.
È un canto, quello definito popolare, che su un antico motivo di chiesa (ne tratteremo più avanti), raffigura un canto di vita domestica della Sacra Famiglia non molto dissimile da quello che era il tenore di vita di moltissime altre famiglie, soprattutto contadine, di qualche secolo fa.
Lo stesso testo trovato nell’edizione di cui alla nota n. 2 è indicato, in internet, con il titolo di “Laude di Montefoscoli” dove Montefoscoli è un paese della provincia di Pisa. Un canto dal testo simile 3 assume invece il titolo “La notte di Natale”, sempre dall’inizio del primo verso.
C’è anche chi la chiama “Filastrocca di Natale” dove il testo è simile a quello di cui alla nota n. 3 ma inizia con “Stanotte a mezzanotte … “ quasi a voler precisare e sottolineare il momento dell’evento.
Anche in Sicilia troviamo un testo 4 legato a questo motivo il cui titolo è solamente “Filastrocca” dove, pur restando nell’ambito dei testi precedenti, questo è ancora più reale, soprattutto nell’ultimo verso.
Tutti i testi, che abbiamo visto essere abbastanza simili, essendo “popolari” “ … sono privi di misticismo e trascendenza mentre risultano in essi gli aspetti umani e terreni della vicende del Vangelo, sia che siano espressi in forma drammatica come nelle «Passioni», sia che lo siano nella forma lieta come in questo quadretto famigliare delle semplici e serene linee”. 5
Il motivo ed il testo originali sono da attribuire ad un santo napoletano, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), primogenito di una famiglia appartenente alla nobiltà napoletana. Riceve una solida istruzione, studia lingue classiche e moderne, la pittura e la musica. Compone un Duetto sulla Passione, un cantico natalizio, oggi ancora famoso in Italia, "Tu scendi dalle stelle", e numerosi altri inni. Termina gli studi universitari ottenendo il dottorato in diritto civile e canonico e comincia ad esercitare nel campo del diritto a soli 16 anni. A trent’anni viene ordinato sacerdote e poco dopo fonda la Congregazione dei Redentoristi.
Oltre al famoso canto natalizio di cui sopra, compose anche testo e musica del canto che, essendo divenuto poi famoso in tutto il nostro paese, diede origine alle diverse versioni di quello che noi chiamiamo “Maria lavava”. Ma in origine il titolo, sempre prendendo spunto dal primo verso, s’intitolava “Fermarono i cieli” del quale riporto in nota sola i primi versi 6 essendo il testo composto da numerose strofe.
E “Fermarono i cieli” è il titolo che viene riportato più spesso nei repertori dei vari cori, ma non sempre; infatti c’è chi si preoccupa di modificarlo chiamandolo, ad esempio, “Dormi dormi” scegliendo quindi “ … di intitolarla con l’incipit del ritornello, secondo una consuetudine popolare ormai consolidata” e riconoscendo, però, l’esattezza dell’altro titolo. Bisogna dire anche che non tutte le versioni di questo canto coincidono; a volte le strofe sono messe in posizioni diverse e questo è senz’altro dovuto a varie riscritture dei tempi passati. 7
L’edizione scelta dal “Marmolada” è quella armonizzata, come dicevo all’inizio, da Armando Corso che, forse perché attivo anche nel campo del jazz, 8 ha costruito, usando una serie di semitoni soprattutto nelle voci di accompagnamento (bassi e baritoni), un assieme di dissonanze di stampo moderno e piacevoli all’ascolto anche se non apprezzate da qualche “purista” del canto cosiddetto popolare.
Forse è stato un po’ difficile l’apprendimento e, sempre forse, anche l’ascolto da parte di un pubblico non introdotto da una presentazione adeguata. Comunque, e parlo delle esecuzioni attuate finora, il canto è sempre stato ben accettato ed apprezzato e, quindi, credo che la scelta di inserimento nel repertorio sia stata una scelta giusta.
NOTE
1
Maria lavava, / Giuseppe stendeva, / il Bimbo piangeva, / dal sonno che
aveva.
Stai zitto, Mio Figlio, / che adesso Ti piglio, / Ti piglio, Ti bacio /
la nanna Ti fo.
Dormi dormi, / fai la ninna nanna Figliol.
La neve sui monti / dal
cielo cadeva, / il Bimbo piangeva, / dal freddo che aveva.
Stai zitto, Mio Figlio, / che adesso Ti piglio, / Ti canto la ninna / la
nanna Ti fo.
Dormi dormi, / fai la ninna nanna Figliol.
2 Claudio Malcapi - “Canzoni toscane” – Libreria Editrice Fiorentina – 1981
3 La notte di Natale, / è nato
un bel bambino, / bianco, rosso /e tutto ricciolino.
La neve cadeva. / Cadeva giù dal cielo, / Maria col suo velo / Copriva
Gesù.
Maria lavava, / Giuseppe stendeva / Il Bimbo piangeva / Dal freddo che
aveva.
Sta zitto mio figlio / Che adesso ti piglio, / del latte ti do; / ma
pane non ho.
La neve cadeva, / Cadeva giù dal cielo, / Maria col suo velo / Copriva
Gesù!
4
Maria
lavava, / Giuseppi stinnía, / lu figghiu chiancía ( chi manciari vulía.
Zíttiti, figghiu, / chi ora ti pigghiu, / manciari `un ci nn`é, / ti
dugnu 'a nenné.
Testo che viene tradotto così:
Maria lavava, /
Giuseppe metteva i panni ad asciugare, / il bambino piangeva / perché
voleva mangiare.
Stai zitto, figlio, / ché ora ti prendo, / non c`é niente da mangiare, /
ti allatterò al seno.
5 cit. nota n.2
6 Fermarono i cieli la loro armonia, / cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina, la Vergine bella, / più vaga che stella, cantava così:
Dormi, dormi, / fa’ la ninna nanna, Gesù.
7” Maria contempla il SS.Bambinello” è un altro titolo di questo canto le cui strofe sono simili a “Fermarono i cieli” ma posizionate diversamente.
8 Armando Corso, oltre a dirigere il Coro Monte Cauriol di Genova, da lui fondato nel 1949, è attivo anche nel campo del jazz dal 1947. Ha inciso con Albert Nicolas, Bobby Hackett e vari complessi nazionali; ha suonato in numerosi concerti e festival in Italia e all'estero, con molti fra i maggiori jazzisti stranieri. Tra essi citiamo Max Kaminsky, Bud Freeman, Bill Coleman, Wild Bill Davison, Billy Butterfield, Eddie Miller, Oscar Klein, Bennie Morton, Louis Nelson e Joe Venuti.
Sergio Piovesan
"Montagnutis" è uno dei tanti canti friulani che vuole ricordare come questo popolo non si sia mai lasciato intimorire dalle difficoltà di vario genere (guerre, invasioni, carestie, terremoti, mancanza di lavoro) e quindi abbia risposto in ogni occasione positivamente legando le sue "fortune" all'esigenza di lavorare lontano da casa.
Questa volta il protagonista è colui che si trova in paesi stranieri; e stranieri possono essere sia quelli immediatamente oltre la propria valle come quelli molto più lontani, anche al di là degli oceani.
Se si ripercorre la storia dell'emigrazione friulana si riscontra che all'inizio si trattava quasi sempre di migrazioni stagionali e quindi in paesi relativamente vicini (Venezia, Austria, Ungheria) ed il genere di lavoro era legato in particolare all'edilizia, all'agricoltura ed alla silvicultura (boscaioli). Solo dopo l'unità d'Italia vi furono emigrazioni in posti più lontani vuoi per esigenze particolari (in Siberia per la costruzione della "Transiberiana" - v. il romanzo di Carlo Sgorlon "La conchiglia di Anataj") ed in questo caso partiva solo l'uomo con la speranza del ritorno, vuoi per emigrazioni oltre oceano, in particolare verso il Sud America, e, quindi, molto spesso, partiva l'intero gruppo familiare. Comunque nel cuore dell'emigrante friulano è sempre rimasto il paese natio al quale poter tornare, magari solo per riposarvi per sempre.
Questi sentimenti sono stati raccolti da me e da tutti i coristi nell'incontrare, durante le varie "tournées" all'estero compiute dal coro -soprattutto in Argentina-, emigranti friulani.
Il canto in questione nasce proprio con le prime emigrazioni, quelle al di là delle montagne di casa, e l'emigrante prega le montagne, e per questo usa un vezzeggiativo che, però, non ha molto significato traducendolo (montagnole, piccole montagne); e chiede loro di abbassarsi così lui potrà rivedere i luoghi cari, in particolare dove andava a "far l'amore".
Si rivolge anche alle stelle e, tramite loro, vuole mandare un saluto alla sua donna che ne attende il ritorno.
Come ne “ La tradotta ”, altro canto fondamentale della letteratura e della storia collegate alla Grande Guerra, anche in “ Monte Canino ” si avvertono il dolore e l’oscuro impersonale destino imposti dalla storia dei ‘grandi’ ai personaggi ‘minori’ della vicenda umana di popoli ‘scagliati’ l’uno contro l’altro: l’esodo di massa, il sacrificio senza prevedibile salvezza…
Dei grandi, prevalentemente, poiché le speranze irredentiste e ‘nazionali’ in senso propriamente politico appartenevano sostanzialmente a minoranze, se di comunità e popolo si parli, com’è giusto, anche in termini di numeri semplici, non limitandosi, per semplificazione o interessata appartenenza, alle élites accreditate di effettivo valore sociale e reputazione economica o istituzionale.
“ I soldati sedevano silenziosi, fumavano, guardavano dal finestrino; molti stavano addentando con polli e ciambelle, metodici nel tributo d’omaggio alla cucina materna; tenendo a mezz’aria una fetta d’arrosto o di salame casalingo, masticavano lentamente, guardando a occhi socchiusi la campagna placida. Da qualche vagone veniva la voce di piccoli gruppi che s’ostinavano a cantare vecchi ritornelli militari, ma senza entusiasmo…l’ordine di partenza era giunto improvviso, e per due giorni era stato tutto un correre, apprestare, affannarsi per un minimo d’equipaggiamento…”: così infatti Virgilio Savona e Michele Straniero, ricercatori di eccellenza nel nostro campo, presentano ‘La tradotta’, con parole che valgono senz’altro a incorniciare il contesto, e l’interiore soffocato risentimento, umano e storico, nei quali prende vigore e tensione emotiva il fatto, tutt’altro che limpido e rassicurante, della partenza di tanto popolo, di contadini in gran numero, giovanissimi, anche padri di famiglia, verso l’incognita somma, la guerra, per una patria spesso non del tutto compresa nel loro immaginario e nel loro povero ‘sapere’.
Vi si parla della vita dei soldati nella grande guerra, mesi in trincea, nella neve, con un freddo terribile e panni desolatamente insufficienti, la paura dell’assalto al buio, del colpo inevitabile del coltello dell’incursore, la fame, una solitudine aspra: raccontare tutto ciò è giusto e utile, è lo stesso testo a pretenderlo, semplicemente, per il bisogno di ottenere almeno la comprensione di chi al posto del ragazzo di trincea può riposare nella propria casa…
Ancora la speranza che cozza contro il clangore delle armi che tutto copre, costringe all’incertezza, senza che basti il richiamo all’eroismo ‘di corpo e d’arma’ ( dopo tre giorni di strada ferrata / ed altri due di duro cammino / siamo arrivati / sul Monte Canino …. se avete fame, guardate lontano / se avete sete, la tazza alla mano / che vi rinfresca la neve ci sarà ), e, improvvisa, la folgorazione di un evento prevedibile e per molti, prima, già funesto: il nemico ad aspettare sul confine, con la medesima angoscia e rassegnazione che solo può estinguersi con l’annientamento dell’altro, senza rimedio, inutile a quel punto ogni perché, ogni obiezione…
Non varrà, in quei momenti assoluti, della vita di uno a patto che si cancelli quella dell’altro, figlio di una povera sudata terra di fronte ad un altro come lui ma ‘dall’altra parte assegnatagli’, il mutuo riconoscimento del comune diritto alla vita e agli affetti fondamentali, non potrà valere, a prezzo della vita, il minimo istante di umana compassione, come straordinariamente in ‘altra’ canzone Fabrizio D’Andrè è riuscito a rappresentare, imprimendo in milioni di giovani del ‘ dopo ’ l’esigenza di un rifiuto morale assoluto della guerra in quanto tale:
“… ed arrivasti a varcar
la frontiera
in un bel giorno di primavera
e mentre marciavi con l'anima in spalle
vedesti un uomo in fondo alla valle
che aveva il tuo stesso identico umore
ma la divisa di un altro colore:
sparagli Piero , sparagli ora
e dopo un colpo sparagli ancora
fino a che tu non lo vedrai esangue
cadere in terra a coprire il suo sangue,
e se gli spari in fronte o nel cuore
soltanto il tempo avrà per morire
ma il tempo a me resterà per vedere
gli occhi di un uomo che muore,
e mentre gli usi questa premura
quello si volta , ti vede, ha paura
ed imbracciata l'artiglieria
non ti ricambia la cortesia:
cadesti in terra senza un lamento
e ti accorgesti in un solo momento
che il tempo non ti sarebbe bastato
a chiedere perdono per ogni peccato,
cadesti interra senza un lamento
e ti accorgesti in un solo momento
che la tua vita finiva quel giorno
e non ci sarebbe stato un ritorno …”
“ Non ti ricordi quel mese d’Aprile / quel lungo treno che andava al confine / e trasportava migliaia di alpini / su su, correte, è l’ora di partir ”… rimane solo il traguardare, con il cuore in sussulto, oltre il finestrino della tradotta, o la feritoia della garitta, laggiù, dove si apre la valle natìa, per convincersi di ritrovare l’apparizione rassicurante dei giorni di pace…
La prima lettura di quest’altro gioiello della coralità alpina d’autore, giocato dall’estro poetico di Bepi De Marzi sui temi musicali della ridondanza e della diversione, riconosce immediatamente le nuove icone rappresentative della buona mitologia dei soldati di montagna: l’andare per colonne e il frastuono incombente dei cannoneggiamenti su in alto, ove è prevedibile, quasi scontato per molti, il sacrificio estremo: “ Su la strada del Monte Pasubio / lenta sale una lunga colonna / l’è la marcia de chi non torna / de chi se ferma a morir lassù. / bomborombom bom…”. E le tragedie degli sfollati, poco raccontate perché assorbite nella rassegnazione delle popolazioni.
Ridondante quel rombo incessante, lontano a volte, altrimenti incombente, capace di travolgere borgate e paesi in valle e disperderli nell’allontanamento senza approdi prevedibili e rassicuranti: le poco raccontate tragedie degli sfollati, poco raccontate perché assorbite nella rassegnazione delle popolazioni e, in fondo, poco utili al rendiconto sincero di un’epopea doverosamente gloriosa. Rassegnazione e lontananza, sentimenti e angosce struggenti di chi osserva i lampi notturni dell’ ‘inferno’, al fronte, dove figli, fratelli e mariti stanno annaspando, con l’anima a pezzi, in un olocausto orribile, di fuoco, gas e baionette sempre pronte a squarciarti la gola.
Divergente, e incomprimibile, nell’iper-coscienza dell’onore militare più che nella consapevolezza di un evento ragionevolmente controllabile dal soldato-alpino, quindi per quella mitologia un soldato speciale, un ‘ ma ’, forse gridato nella marcia d’avvicinamento, e poi trasferito al ghigno disperato del corpo a corpo sul labbro della trincea – la propria o l’altrui poco importa –, quel ‘ ma gli alpini non hanno paura ’ che suona da riserva psichica assoluta per agire, quando non lo siano le pistole d’ordinanza di qualche ufficiale ‘bramoso di gloria’ puntate alla schiena del soldatino irrigidito dall’umana radicale paura, o il trangugiamento sconvolto di decisivi sorsi di grappa, quasi mai assenti al fronte…
In ogni caso con la conquista di un onore pulito e per nulla retorico, e della pietà di chi raccontò e racconta ciò che i tanti ossari dispersi nelle nostre regioni alpine ricorda doverosamente, e pretende dal visitatore un inchino profondo, rispetto e ‘compassione’, come oggi s’usa dire senza se e senza ma.
Vanno in colonna quei nostri soldati, scarpe e abbigliamento improbabili, infinita processione di ragazzi e padri di famiglia senza alternativa, sequenza puntiforme d’anime nei duri passi montani, allora, oggi luoghi paciosi del moderno viaggiatore, sovente ignaro passante o consumatore accanito di diavolerie tecnologiche – auto e mefitiche teorie di pullman fin sotto alle forcelle della sofferenza illimitata di quegli alpini, e del sacrificio di tantissimi di loro – scambiate per usuali bus di città.
Vanno e, sotto di loro, sentono i compagni scavare, “ soto i denti ghe ze ‘na miniera / ze i alpini che scava e spera / de ritornare a trovar l’amor…”: la guerra di mina, l’altra micidiale icona, la guerra sotterranea, gli uni sopra gli altri, anche più volte, a cercare nelle viscere della roccia una salvezza purchessia, con decine di migliaia di tonnellate insaccate in cunicoli e pozzi, e lo smantellamento di intere montagne, crateri immensi nei quali non serviva nemmeno seppellire le centinaia di morti, inghiottiti dalla terra che li aveva generati, ma per vivere, amare, crescere i figli…
Ma…ancora quel ma…sulla cima devastata dalle esplosioni e silente, funerea, allorché solo il vento rimane a vestire panni di un alcunché di vitale, percepibile alla carezza di un fiore, “ gli alpini non hanno paura ”, nonostante tutto, contro ogni logica di chi vive nella normalità delle convenienze e delle opportunità, di chi abbia – e anche grazie a loro abbiamo oggi – in sorte di non conoscere guerra, odio, dissoluzione di sé e del proprio vivere quotidiano. L’onore e l’arma ( i compagni di trincea più che tanta ufficialità ) sono salvi, devono essere salvi, perché elementi di una dignità che era parte del vivere valoriale e storico di quei contadini vestiti da soldato. Ciò, comprensibilmente dato che trattasi di canzone d’autore, sgorga dall’anima grata di un poeta e musicista a quei ‘ tosi ’, ma collima amorevolmente con le memorie loro, incise in diari e testimonianze, nelle balze montuose tuttora religiosamente tutelate e rispettate, almeno finché il sentimento onesto della storia vinca sulla dimenticanza degli ignavi o sul cinismo dei pavidi.
Nota 1: I ‘ denti ’ di cui qui si parla, secondo la lettura preferibile del testo, sono in realtà due acrocori rilevati nella cresta del Pasubio, italiano l’uno, austriaco l’altro, il primo dei quali fatto saltare dopo mesi di scavo sotterraneo, di orecchie sulla roccia viva a distinguere i movimenti nemici, della speranza angosciosa di recuperare il filo di una sopravvivenza nel caos dell’annientamento del nemico, ancora e sempre questo. Oggi, a memoria solenne di quegli spasimi, è l’intero comprensorio del Pasubio diventato monumento e ammonimento vasto, complesso, anche affascinante in un certo senso. “ La zona del Pasubio, dichiarata monumentale dal 1922, è delimitata da 30 cippi che ricordano i reparti che maggiormente si distinsero negli accaniti combattimenti. Vi si accede percorrendo vie fascinose ed austere: la strada degli Eroi, nel cui tratto a monte sono collocate le lapidi ricordo di 15 decorati di Medaglia d'Oro, tra cui quelle dei trentini Cesare Battisti, Damiano Chiesa e Fabio Filzi; la strada degli Scarubbi e, la più famosa via d’accesso al Pasubio, una delle maggiori opere belliche di tutto il conflitto, la Strada delle 52 gallerie, una mulattiera che permetteva all’esercito italiano il collegamento fra la base del monte e la zona alta al riparo dal tiro nemico. La realizzazione di mine e contromine fu molto intensa anche sulla Marmolada con l'applicazione di cariche nei tunnel scavati nel ghiaccio ”.
Nota 2. Con i drammi ‘sconfinati’, letteralmente, dell’oggi, dell’Europa sotto attacco, e di una ‘guerra mondiale’, la terza?, fatta di frammenti e presente già nei cumuli di detriti umani e strutturali, e di tante vittime innocenti, affatica e costringe al dubbio il nostro scrivere delle ‘ guerre grandi ’ del Novecento, commemorate così tanto forse per una scaramanzia sul futuro che pare infrangersi su interminabili follie e ipocrisie e problemi irrisolti dal consesso mondiale.
Ma tant’è: forse continuare a fare ciò che è bene ed utile fare nelle nostra dimensione umana e sociale è cosa giusta e necessaria, supponendo che i ‘grandi poteri’ rinsaviscano in tempo ( certo non come nella confessione dell’ex premier inglese Blair il quale, candido, ha offerto alle telecamere l’ammissione di una guerra all’Iraq intentata e disastrosamente compiuta senza le motivazioni addotte per imporne la necessità, anzi nella consapevolezza dell’inconsistenza di quelle ragioni). Ed inchinarci dolorosamente alla memoria delle vittime del terrorismo internazionale.
Costantino Nigra,[1] nella raccolta dei canti popolari piemontesi, nomina "Convegno notturno" un tipo di canto nel quale si assiste a richieste pressanti dell'innamorato alla sua bella per un incontro, e lo suddivide in tre sottotipi: il primo è quello in cui il convegno promesso non viene poi concesso, il secondo quello in cui il convegno promesso viene accordato ed il terzo quello in cui il convegno viene richiesto ma non è promesso né accordato.
"O Gigiota",[2] nell'armonizzazione ai Andrea Mascagni, appartiene sicuramente al secondo tipo di "Convegno notturno". È un canto della campagna emiliana, più precisamente del ferrarese, di intonazione garbatamente boccaccesca; la situazione descritta è un po' scabrosa, ma viene -nel contesto del racconto- decisamente sdrammatizzata.
"Gigiota" è un nome che si addice a questo canto; è un nome "corposo", sostanzioso, cioè un nome che rappresenta anche fisicamente questa bella ragazza, senz'altro formosa e appariscente, che attira le voglie dell'innamorato. Questi chiede una "licenza", una concessione, un permesso, e, quindi, per estensione, "libertà di fare" che si tramuta in sfrenatezza di costumi.
La Gigiota acconsente (non vi fu alcunché di "galeotto") ed ecco che a mezzanotte, quando tutta la casa è immersa nel sonno, un leggero segnale (" ... un bussetto alla porta, ...") induce la bella Gigiota ad andare ad aprire la porta per accogliere il suo amore. Forse i due, intimamente agitati ed esuberanti, svegliano i genitori che bruscamente intervengono e, al buio, si accorgono di qualcosa e chiedono ... " ... chi è quell'uomo che è a letto con te?". Ma Gigiota non si perde d'animo è trova subito una scusa: "L'è mia sorela, Caterinela, che l'è venuta a dormire con me.".
I canti di questo tipo che, come vedremo, non mancano nel genere "popolare", trattavano, anche se esplicitamente, argomenti d'amore e di sesso con garbo e semplicità, senza eccedere e senza degradare nello scurrile.
Ma non c'è solo la Gigiota! Sempre in Emilia troviamo la ... Pinota [3] al quale l'innamorato chiede una "grazia", termine assimilabile alla "licenza" del canto precedente. L'appuntamento viene fissato alle undici (non a mezzanotte) ... "... quando mamma e papà non c'è.". L'incontro non avviene in camera, ma fuori e la Pinota si presenta " ...deschèlza in camisola" (scalza ed in camicia da notte) anche se voleva rivestirsi. Il giovanotto non dà molta importanza all'abbigliamento della Pinota perché "... non importa che tu ti vesta, tanto nuda tu piaci a me.". Essere essenziale e deciso, questa è la caratteristica dell'innamorato di Pinota
Dall'Emilia attraversiamo gli Appennini e, in Toscana, troviamo un'altra Pinota; il testo è simile alla versione emiliana ma, nella prima strofa, l'innamorato non chiede una "licenza" o una "grazia": lui ... vuole, esige : "O Pinota, bella Pinota, vo' una notte dormire con te.".
La scoperta di questi canti gaudenti e boccacceschi,
 piccanti,
osé, non si ferma a queste due regioni. In Trentino troviamo "E
picchia picchia a la porticella"
[4]
dove, la porta viene aperta, con la mano, e "... co' la boca la me
dà un bacin", un bacino così forte da svegliare i genitori che
appaiono preoccupati di quello che dirà la gente; ma contrariamente agli
altri testi, nel finale, che potremo definire più moderno, la ragazza
conclude con "Ma lascia pure che il mondo dica, io voglio amare chi
ama me!" .
piccanti,
osé, non si ferma a queste due regioni. In Trentino troviamo "E
picchia picchia a la porticella"
[4]
dove, la porta viene aperta, con la mano, e "... co' la boca la me
dà un bacin", un bacino così forte da svegliare i genitori che
appaiono preoccupati di quello che dirà la gente; ma contrariamente agli
altri testi, nel finale, che potremo definire più moderno, la ragazza
conclude con "Ma lascia pure che il mondo dica, io voglio amare chi
ama me!" .
Un testo molto simile lo troviamo in Val Canobbina [5] dal titolo "E picchia, picchia" nell'armonizzazione di Armando Corso[6]. Rispetto all'edizione trentina questo ha una strofa in più che recita: "Io voglio amare quel giovanotto, che è stà sett'anni in prigion, ... prigion per me!" .
Il madrigale è una composizione musicale, in maggior parte per gruppi di
3-6 voci, originata in Italia, e diffusa in particolare tra Rinascimento
e Barocco e quindi in un arco di tempo che va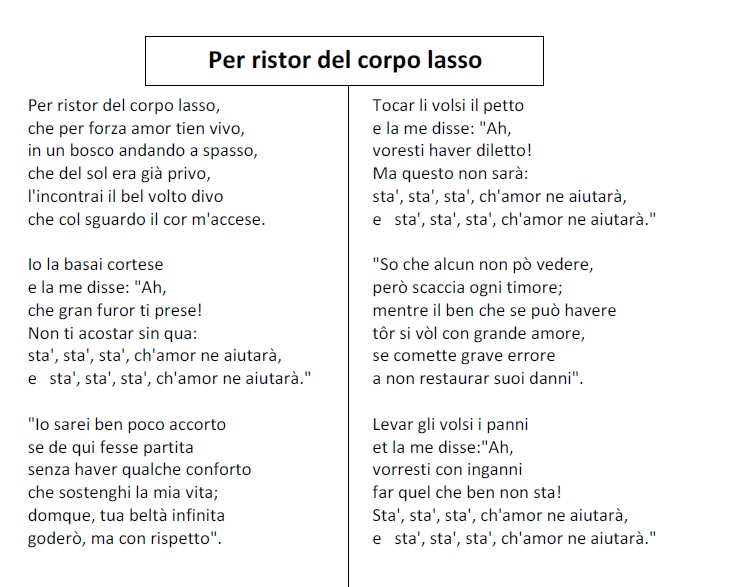 all'incirca dalla seconda metà del XIV secolo fino al XVI secolo. Una
teoria sulla etimologia della parola "madrigale" afferma che
questo termine viene dal latino "materialis" e che, opposto a
"spiritualis", prende il significato di "cose materiali o grosse".Canti
di cose materiali o grosse dove il termine "grosse" non lascia
dubbi sugli argomenti trattati dai testi: canti d'amore -non spirituale-
ma materiale, sensuale. Ma un'altra teoria ne ipotizza l'etimologia dal
latino volgare "mandria-mandrialis" in riferimento al contenuto
rustico e pastorale. Così canzoni gaudenti -in genere di autore anonimo,
ma non sempre- le troviamo nelle raccolte musicali dei secoli scorsi,
come il caso di "Per ristor del corpo lasso"
[7],
dove il testo (vedi a fianco) non dà adito ad
interpretazioni in quanto tutto è molto chiaro e dove la donzella prima
fa finta di non accettare le "avances" dell'intraprendente
messere, ma poi è ben contenta del godimento che segue.
all'incirca dalla seconda metà del XIV secolo fino al XVI secolo. Una
teoria sulla etimologia della parola "madrigale" afferma che
questo termine viene dal latino "materialis" e che, opposto a
"spiritualis", prende il significato di "cose materiali o grosse".Canti
di cose materiali o grosse dove il termine "grosse" non lascia
dubbi sugli argomenti trattati dai testi: canti d'amore -non spirituale-
ma materiale, sensuale. Ma un'altra teoria ne ipotizza l'etimologia dal
latino volgare "mandria-mandrialis" in riferimento al contenuto
rustico e pastorale. Così canzoni gaudenti -in genere di autore anonimo,
ma non sempre- le troviamo nelle raccolte musicali dei secoli scorsi,
come il caso di "Per ristor del corpo lasso"
[7],
dove il testo (vedi a fianco) non dà adito ad
interpretazioni in quanto tutto è molto chiaro e dove la donzella prima
fa finta di non accettare le "avances" dell'intraprendente
messere, ma poi è ben contenta del godimento che segue.
Non è proprio il caso di citare la locuzione latina "O tempora, o mores!"
[1] Costantino Nigra (1828-1907), uomo politico piemontese, ma anche filologo e poeta. Si dedicò alla raccolta dei canti popolari della sua regione e sull'argomento pubblicò "Canti popolari del Piemonte" (1888)
[2] O Gigiota, bela Gigiota, / una licenza vuria da te, / una licenza date vuria, / solo una notte a dormire con te.
Mezzanotte, un bussetto alla porta, / cara Gigiota venite ad aprir, / con una mano apri la porta / e con quell'altra accarezza il tuo amor.
O Gigiota, bela Gigiota, / chi è quell'uomo che è a letto con te? / L'è mia sorela, Caterinela, / che l'è venuta a dormire con me.
[3] "O Pinota" raccolta nel 1938 a Pian di Macia (BO) ed armonizzata da Giorgio Vacchi
[4] "E picchia, picchia a la porticella" (Valsugana) - Ricostruzione di Luigi Pigarelli.
[5] La Valle Cannobina è una valle del Piemonte, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Prende il nome da Cannobio (sul Lago Maggiore), il principale abitato che si trova al suo inizio.
[6] Armando Corso - vedi http://www.corocauriol.com
/armando.html
[7] "Apografo miscellaneo marciano" - Francesco Luisi - Edizioni Fondazione Levi - Venezia 1979 (Edizione critica integrale dei Manoscritti Marciani, 1795.1798).
"Apografo" = copia del manoscritto originale
Sergio Piovesan
O SANTA NOTTE
O SANTA NOTTE, uno dei canti natalizi del nostro repertorio, ha una storia interessante.
Il curato di Roquemaure, l’abbate Eugène Nicolas, nel quadro delle manifestazioni culturali e religiose che voleva organizzare per raccogliere dei contributi per la costruzione delle vetrate della chiesa di San Giovanni Battista, aveva chiesto ad un suo parrocchiano, commerciante di vini e poeta provenzale a tempo perso, di scrivere il testo di un canto di Natale. Siamo a metà dell’800, precisamente il 3 dicembre del 1847, e Placide Cappeau, così si chiamava il commerciante di vini, si trovava sulla diligenza di ritorno da Parigi, fra Mâcon e Digione; fu proprio in quel tratto di percorso che scrisse i versi di quello che intitolò Cantique de Noël. In quel momento l’autore non immaginava il successo che avrebbe avuto la sua poesia. Nel paese francese risiedeva, temporaneamente, un ingegnere parigino che seguiva i lavori di un ponte; con lui c’era la moglie Emily, cantante, che conosceva il compositore Adolph Adam(1) del quale aveva interpretato una delle sue opere in tre atti. Emily indirizzò queste strofe di Minuit Chrétiens, così chiamato successivamente dalle prime parole del testo, al musicista che, in pochi giorni le musicò. La cantante le interpretò per la prima volta alla messa di mezzanotte del 24 dicembre 1847 nella piccola chiesa di Roquemaure.
Questi i versi originali del canto, in lingua francese:
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple, à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur (bis)
De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'Enfant
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur (bis).
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La Terre est libre et le Ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît,
qu'il souffre et meurt.
Peuple, debout ! Chante ta délivrance.
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur (bis).
Fu subito un successo, anche se il compositore, autore di numerosa musica per l’opera ed il balletto, non ne ebbe sentore perché morì solo qualche anno dopo.
Negli anni successivi il brano approdò nel mondo anglosassone, dove divenne famosissimo, e lo è ancora oggi, con il titolo di "Oh Holy Night"; il testo venne modificato e questa versione divenne più famosa dell’originale, e ciò anche nel resto del mondo, tanto che pure la versione italiana, quella che noi eseguiamo, nell’armonizzazione di Gianni Malatesta, dal titolo appunto di Oh Santa Notte, è la libera traduzione(2) del testo inglese e non di quello francese.
NOTE
1) Adolphe Charles Adam (Parigi, 24 luglio 1803 – 3 maggio 1856) è stato un compo-sitore e critico musicale francese. Autore prolifico di composizioni per l'opera e il balletto, è famoso per i balletti Giselle (1844) e Le Corsaire (1856), l'opera Les Toréadors (nota anche con il titolo di Le toréador ou L'accord parfait (1849) e la sua canzone di Natale “Minuit Chrétiens” .
2) Oh santa notte, le stelle son splendenti,
in questa notte è nato Gesù.
A lungo giacque il mondo nell’errore
finché Egli apparve la luce a portar.
Un cantico di gioia e di speranza
riempie il cuore e nasce il nuovo giorno.
(Rit.) Gloria al Signore
in cielo e sulla terra,
oh notte divina, oh notte del Signor.
Natal, Natal, nato è Gesù.
Oh santa notte, la notte del Natale
un bimbo è nato il mondo a salvar.
In una fredda e buia mangiatoia
Iddio Signore per l’uomo s’incarnò.
A Lui offriamo con cuore generoso
la nostra vita, gioie e sofferenze.
Nato è Gesù divino redentore
(Rit.) Gloria
Egli ci disse di amarci l’un con l’altro,
la Sua legge è pace e amor.
Ogni persona sia nostro fratello,
nel Suo nome cessi ogni mal.
Di gioia un canto in coro eleviamo
e il Suo santo nome veneriamo.
Gloria al Signor, per sempre Lui preghiamo.
(Rit.) Gloria …
Registrazione effettuata presso la Chiesa di San Carlo a Mestre
Dicembre 2011
Sergio Piovesan
Il 12 maggio 1797 il doge di Venezia, Ludovico Manin, cedendo alle pressioni militari di Napoleone, nella seduta del Maggior Consiglio dichiarava la fine della Repubblica di Venezia dopo circa mille anni di vita, di storia e di vicende gloriose sotto i profili civile, militare, giuridico, economico, sociale ed artistico.
Anche se già da qualche tempo era iniziato il periodo di decadenza del Dogado e dei possedimenti che Venezia aveva sia nei mari orientali che nella terraferma, tuttavia con l'atto formale del 12 maggio, iniziò la vera decadenza della città soprattutto dal punto di vista economico.
I nuovi padroni, i francesi, e per essi Napoleone, oltre a portare a Parigi innumerevoli capolavori d'arte che nel corso dei secoli erano stati raccolti e creati a Venezia, fecero in modo che anche l'economia cittadina, basata essenzialmente sul commercio, crollasse. In questo modo Venezia, che da sempre aveva importato, scambiando, i beni primari necessari alla vita di ogni giorno, si trovo letteralmente alla fame. Famiglie che una volta, con le loro fortune, potevano anche armare navi per la difesa della città e delle rotte di navigazione, si trovarono nell'impossibilità di operare e si ridussero sul lastrico trascinando in questo sfortuna anche il popolo veneziano.
In quel periodo si può dire che iniziò anche l'esodo dei veneziani, per cercare nuove occasioni di lavoro, e fra queste vi era anche la guerra. Infatti Napoleone, nel suo sogno di conquista dell'Europa, aveva bisogno di uomini che combattessero per lui, magari sotto la spinta degli ideali nati dalla Rivoluzione Francese.
Ed ecco che allora molti giovani veneziani, vuoi per questi ideali, ma anche e soprattutto per la miseria, si trovavano a dover abbandonare la famiglia, la città e la donna amata per andare in guerra. E quella partenza era una "Partenza amara" in quanto a questi giovani restava soltanto la speranza di poter ritornare.
Il canto, che vuole rappresentare i sentimenti di questi giovani nel momento doloroso del distacco, e` di origine veneziana ma l'attuale testo ha subito delle trasformazioni dovute senz'altro all'appropriarsi del testo da parte di altre culture; infatti il lessico non e` propriamente veneziano e molte parole sono state italianizzate.
E un canto triste e questa tristezza viene contrassegnata in modo particolare anche dalla melodia e dall'armonizzazione, anche se il ritornello vivacizza musicalmente il pezzo.
Particolarmente significativa e` l'ultima strofa nella quale il giovane coscritto, non potendo portare con se` la sua Maria, nome molto comune questo a Venezia anche per la particolare religiosità` nei confronti della Madonna da parte del popolo lagunare (molte chiese sono state erette a Suo nome), la affida ai familiari pregandoli di averne riguardo perché l'amore verso la sua donna e` la molla che tiene in vita la speranza del ritorno.
"Partenza amara" e` un canto sconosciuto ai giovani d'oggi e fino a circa quaranta anni fa qualche vecchio lo cantava ancora sia a Venezia ma anche nelle zone del litorale (Treporti) ed a Chioggia.
Toni Dittura
Sergio Piovesan
Claudio Favret
Quando ero in seconda media ai Cavanis, per onorare la visita del Patriarca, abbiamo imparato una Santa Messa a quattro voci, naturalmente in latino. Quando l’ab- biamo cantata (in seicento), il Rio Terà Santa Agnese era gremito di gente, che sicuramente mai aveva sentito un volume di voci di quella portata.
Molti anni più tardi, nel 1962, in occasione del cinquantenario della ricostruzione del campanile di San Marco, duemila alunni veneziani, fra i quali quelli della classe quinta, nella quale io insegnavo, hanno cantato: Torre degli avi, faro di gloria di Benedetto Marcello. Lascio a voi immaginare scenario ed effetto sonoro.
Sempre in quel periodo ho avuto la fortuna di ascoltare il Dies irae, cantato dai Frati di San Francesco del Deserto, che a quei tempi erano ancora una dozzina. L’am- biente era sicuramente più raccolto, ma la solennità e la potenza di quel brano, unite al terribile significato di quelle parole latine, hanno scolpito nella mia mente delle immagini al cui ricordo mi viene ancora la pelle d’oca.
Ma mi è venuta anche poco fa, ascoltando il mio Coro, concedetemi di considerarlo ancora il mio Coro, nella sua prima esecuzione del Pater Noster di Igor Strawinsky nella Chiesa di Altobello, in Mestre.
Ho fatto questa lunga premessa, perché l’amico Sergio invita tutti i coristi ad esprimere un’opinione sulla profonda diversità di questo brano rispetto all’abituale repertorio proprio del Marmolada e di tutti i Cori che si definiscono Alpini o comunque popolari. Io francamente non sento alcun disagio, anzi penso che cimentarsi con il Gregoriano sia un’espe- rienza che tutti i cori dovrebbero provare. Allora forse si accorgerebbero che varie melodie, che noi riteniamo nuove, hanno le radici che attingono a quelle liturgiche, che altro non sono se non la profonda voglia, anzi la necessità di usare la voce non solo per intimo compiacimento, ma anche per rivolgersi agli altri, prima fra tutti la divinità, in modo corale, cioè religioso, dal momento che religione significa proprio unione
E per tornare al repertorio, non è forse vero che abbiamo cantato delle Ave Marie in sardo e in latino? E Lettere d’amore e Les plaisirs sont doux sono forse canti degli alpini?
Gran Dio dame ‘na barca ci ha fatto vedere la nostra Laguna, mentre nelle nostre menti avevamo lis cretis ... belle rose du printemps ...
E Bepi De Marzi ha scritto la sua più bella canzone ... e canterà più alto delle stelle ... pensando e facendoci pensare di ritrovarci in una immensa cattedrale, con le montagne per pareti e La Marmolada per altare.
Avrebbe potuto anche scriverla in Latino.
Durante una prova, pochi mesi fa, Claudio ci disse: Proviamo questo e, detto fatto, iniziò, con una voce, a cantare Pater noster qui es in coelis; la ripeté e provò subito con una voce. Tutti gli altri coristi ascoltavano, alcuni un po' scettici, bastava vedere le loro facce, altri incuriositi. Preparata una voce, nel giro di pochi minuti, impostò subito un'altra e, quindi, le mise assieme. Già a due voci si capiva subito che l'armonia era qualcosa di speciale ed anche gli scettici apparvero già meno scettici. Prima di passare alle altre due voci Claudio ci rivelò che si trattava del Pater noster di Igor Stravinskij(1) nell'adattamento per voci pari virili di Gianni Malatesta. Già questa informazione servì ad entusiasmare alcuni e a rassicurare gli altri. È chiaro che lo scetticismo faceva parte del pensiero di coloro che, più di altri, sono legati al classico modo di cantare dei cori detti oggi d'ispirazione popolare e che un canto in latino, di origine gregoriana, pur se sviluppato ed armonizzato da un musicista di chiara fama, poteva sembrare un qualcosa di fuori luogo. Ma, aggiunte le altre due voci e provate solo le prime battute a coro completo, tutti si convinsero di eseguire un brano importante, un brano armonicamente molto bello e questa convinzione aumentò aggiungendo altre battute. Nel giro di altre due prove riuscimmo a completarlo, almeno per quanto riguardava la lettura e l'apprendimento grezzo delle parti, non difficili. Quello che invece comprendemmo subito fu che non bastava aver appreso le parti, ma che serviva un'assimilazione dell'assieme e, soprattutto, seguire quella che era l'interpretazione che il maestro Claudio voleva dare. E questa è appunto la difficoltà del Pater noster.
Accennavo all'origine gregoriana e questo genere musicale, si serve della parola cantata nel rivolgersi alla divinità; tale fatto non è una prerogativa della sola Chiesa Cattolica, ma di tutte le religioni costituite. La melodia del canto gregoriano deriva dalla salmodia ebraica influenzata dalle arti greca(2) e romana.
Scriveva Cicerone Est autem in dicendo etiam quidam cantus obscurior - C'è nella parlata un certo qual canto piuttosto indefinito. Il canto, perciò, sarebbe la veste fonica del linguaggio durante le emozioni eccezionali della sfera estetica e sentimentale; l'uomo nel comunicare con l'extrasensibile, col divino, deve trovarsi posseduto da un profondo stato emotivo e, quindi, eleva la preghiera verbale alla sonorità del canto. Il testo latino ecclesiastico con i suoi accenti già di per sé è una melodia, melodia che, trascritta con i neumi, era quasi esclusivamente ad una voce; poi il papa San Gregorio Magno(3) codificò il genere musicale che prese appunto il suo nome.
Ora tutti i coristi sono soddisfatti di questo brano, pure se di tipo diverso da quelli del nostro solito repertorio, e, anche se già eseguito durante la liturgia in ricordo dei coristi andati avanti(4), lo presenteremo ufficialmente durante i prossimi concerti di Natale sicuri del successo: la buona e bella musica, di qualsiasi tipo, è sempre valida.
Sergio Piovesan
Martedì 6 novembre, in occasione della celebrazione liturgica in ricordo dei nostri maestri e di tutti i coristi del Marmolada andati avanti, abbiamo eseguito per la prima volta in pubblico l'ultima nostra fatica. Si tratta del celeberrimo Pater Noster di Igor Stravinsky.
Erano anni che avevo in animo di tentare di eseguire con il nostro coro un brano così impegnativo e così distante dalla classicità del nostro repertorio di canti di ispirazione popolare, ma, una serie di dubbi mi avevano sempre trattenuto dal farlo.
Il primo dubbio che mi assillava era su come avrebbero reagito i coristi a questa musicalità e sonorità così distanti dalla nostra tradizione, perché è assodato che se il nostro coro, non sente un brano, per quanto valido possa essere, non si riesce ad acquisirlo. Nel corso degli anni, e questo lo sanno bene tutti i coristi passati e presenti, è accaduto molte volte.
Un altro dubbio riguardava la capacità del coro, come diceva Lucio a proposito del Puer natus, a togliersi il cappello di alpino ed indossare mentalmente il saio che, tradotto in altre parole, sta a significare la capacità di cambiare totalmente gli schemi esecutivi ed interpretativi. Di non poco conto erano le difficoltà tecniche rappresentate in alcuni punti da dissonanze e successioni di accidenti musicali.
L'ultimo riguardava me stesso; sarei riuscito a tradurre attraverso la gestualità e le indicazioni tecniche tutto quanto necessario per eseguire in modo adeguato tale brano?
Ed una sera di fine maggio, quasi al termine della prova, ho lanciato il sasso. Ho proposto la lettura delle prime quattro battute del brano: Pater noster qui es in coelis dalle quali emerge immediatamente tutta la moderna musicalità del brano.
Direi che, quasi come per incanto, i coristi sono rimasti affascinati dalle sonorità e dalla musicalità del brano, e questo mi ha convinto a proseguire nello studio del brano.
La lettura e l'apprendimento del brano è stata molto veloce, sintomo questo di un notevole gradimento.
Conclusa l'acquisizione del brano, risultava fondamentale curarne l'esecuzione e l'interpretazione.
Ho spiegato ai coristi che Stravinsky possedeva una forte personalità ed uno stile molto originale legati alla capacità di reinterpretare e rielaborare la musica tradizionale.
In questo caso, il Pater noster tratto dalla tradizione gregoriana, pur essendo stato così modernamente rielaborato, a mio giudizio, andava eseguito rispettando la metrica del testo tipica del canto gregoriano con il massimo controllo dell'emissione sonora, la massima fusione tra le varie voci ed una dinamica musicale che non poteva rimanere vincolata nella metrica delle battute.
Abbiamo lavorato molto, ed alla fine ci siamo presentati al pubblico. Saremo riusciti nel nostro intento? Al nostro pubblico la risposta.
A conclusione di tutto quanto sopra voglio esprimere a tutti i coristi il mio ringraziamento per l'impegno e partecipazione dimostrata.
NOTE
(1) Igor' Fëdorovič Stravinskij nacque a Oranienbaum (oggi Lomonosov), nelle vicinanze di San Pietroburgo, in Russia, nel 1882. Morì a New York il 6 aprile 1971, a ottantotto anni. Per sua espressa richiesta, la sua tomba è vicina a quella del suo collaboratore di vecchia data, Diaghilev, a Venezia nell'isola di San Michele.
(2) Fino al 270 d.C. circa, il greco era la lingua ufficiale del culto cristiano. In epoca successiva il latino ebbe il sopravvento.
(3) Papa Gregorio Magno (540 - 604) sia con la rivoluzione musicale ed anche per molto altro trasformò la Chiesa da romana ad europea.
(4) 6 novembre 2012 presso la Chiesa di Altobello in Mestre.
Sergio Piovesan
Quest’anno la “Giovane Montagna” di Venezia celebra il suo 60° anniversario di fondazione e l’evento, al quale anche il Coro Marmolada partecipa, mi ha dato lo spunto per “raccontare” un canto che si addice proprio a chi ama la montagna, a chi, zaino in spalla, la frequenta e l’affronta.
Si tratta di “Rifugio bianco” un canto di Bepi De Marzi che nacque in occasione della dedicazione a Giovanni Tonini, suo amico, di un rifugio sulle montagne del Pinè, nel Trentino. Il testo, che si adatta ad una musica molto bella nella sua semplicità, si può definire una poesia come, d’altra parte, sono poesie tutti i componimenti di De Marzi.
Chi frequenta, o frequentava negli anni giovanili, la montagna ed i suoi rifugi, non può disconoscere che la prima strofa descrive un itinerario classico, quello che ognuno serba fra i propri ricordi più belli, che ci conduce ad un qualsiasi rifugio di montagna.
Anni addietro, quando “andare per rifugi” significava, in particolare per noi cittadini, dapprima prendere il treno, poi una corriera (allora non si chiamava ancora “pullmann”) e, quindi, lasciate le ultime casa del paese, iniziare la salita per una valle, il più delle volte molto chiusa, percorsa da un sentiero che, procedendo a zig-zag, s’inerpicava portandoci in quota.
Spesso si procedeva non vedendo neppure il cielo, tanto era fitto bosco di latifoglie. Poi, un po’ alla volta, la vegetazione cambiava: ai carpini, frassini e faggi seguivano pini, abeti e larici. Ecco, quasi all’improvviso, al termine del bosco, aprirsi un’ampia conca prativa, una valle multicolore per la presenza di numerosissimi fiori.
Era il momento di una sosta per un breve riposo e per ammirare il panorama. Tutt’attorno, oltre i prati, si vedevano le prime crode e le verticali pareti dolomitiche con le vette ancora innevate. Fra una cima ed un’altra una sella dove, ma era ancora lontana, una piccola casa, una casa bianca. Era quella la nostra meta, il rifugio.
L’aria che prima, alle quote sottostanti ed all’interno del bosco, risentiva ancora del caldo e dell’umidità, era ora più frizzante e ci ritemprava l’energie per proseguire la salita. Zaino in spalla, ogni tanto si alzava gli occhi verso l’alto per controllare dov’era il rifugio che, però, sembrava sempre lontano. Magari, per la conformazione del terreno, ogni tanto scompariva e, al riapparire, ci sembrava … più grande, più vicino.
Quando poi si faceva tardi -e qualche volta capitava- all’imbrunire, all’esterno della casa, s’accendeva una luce, quasi una stella a mostrarci il cammino.
E finalmente, eccoci arrivati! I prati che abbiamo attraversato ora sembra che continuino e si allarghino verso il cielo.
Ognuno di noi, nel ripercorrere mentalmente questi itinerari raggiunge il proprio rifugio ideale, magari il primo “conquistato” in giovinezza, quello che rimane, sempre e in ogni modo, il rifugio più bello.
Sergio Piovesan
Continuando col “raccontare” i canti del repertorio del “Marmolada” è la volta di un canto friulano, o meglio, carnico. E parlo di “Se jo vès di maridâmi” (Se dovessi sposarmi). E’ stato inserito in repertorio appositamente per la tournée argentina del 1988 e questo perché sapevamo che oltreoceano avremmo trovato molti friulani, cosa, che effettivamente, si dimostrò esatta.
E’ un canto popolare e l’edizione che noi cantiamo è stata armonizzata da Antonio Pedrotti ed eseguita per prima dal Coro della S.A.T. di Trento; per questo è diventato conosciuto anche fuori dai confini del Friuli.
Il motivo allegro accompagna un testo che non è altro che una serie di considerazioni che una ragazza carnica fa in vista di un possibile matrimonio.
Se jo vès di maridâmi,
un cialiâr no cjolares.
Al è bon dì bati suelis
ancje me mi batares.
Cun chei quatri ch’al guadagne
nol mantèn nàncje un polez.
Beneditis lis cjargnelìs
benedez i lor paìs.
Questo è il testo che, tradotto, dice pressappoco così:
“Se dovessi sposarmi, non prenderei un calzolaio. Lui è capace soltanto a battere suole e batterebbe anche me. Con quei quattro soldi che guadagna non mantiene neppure un pollo. Benedetti i carnici, benedetti i loro paesi.”.
Ma i canti popolari, quelli veramente popolari, hanno più versioni in quanto, nei secoli scorsi, i testi e le musiche, trasportati da un luogo ad un altro da viaggiatori e mercanti, venivano appresi e modificati con l’andare del tempo, adattandoli al momento, alle esigenze del linguaggio alle vicende paesane ed a tante altre cose.
Nell’estate del 1999, durante il mio soggiorno in Carnia, ho fatto un po’ il topo di biblioteca e, su pubblicazioni specializzate di qualche anno addietro, ho trovato ben cinque testi diversi raccolti in altrettanti paesi di vallate diverse.
Se nella nostra edizione i carnici sono benedetti, la ragazza di Piano d’Arta (Valle del But), invece, non vuole un conterraneo perché:
… lui al quinze la mignestre
siet, vot voltis cun tun vuès
(… lui condisce sette, otto volte la minestra con lo stesso osso). In effetti la ragazza riconosce la parsimonia della gente di montagna friulana, caratteristica questa dovuta senz’altro alle difficoltà di vita e di lavoro che, sempre, hanno contraddistinto questa regione.
Ma se andiamo ad Ampezzo, nella Valle del Tagliamento alla confluenza con il torrente Lumiei, proveniente dal lago di Sauris, il testo raccolto da Franco Escher nell’ottobre del 1933, dice:
… nò in Sauris nò larès:
‘a è la blava tant lontana,
si consuma piel e vuès.
(… no, non andrei a Sauris; là il fieno è tanto lontano che, per raccoglerlo, ci si consuma pelle e ossa.). Ed anche qui si riscontrano la difficoltà di campare e la fatica del lavoro.
Ma c’è anche chi la prende con allegria ed allora, a Priola, sempre raccolti da Franco Escher, i versi sono:
… vores cjoli un picinin;
vores fâj las braghessutes,
con tun brac’ di ragadin.
(… vorrei prendere un piccolino; vorrei fargli i calzoncini / con un braccio di tela).
Abbiamo quindi la versione di Paluzza (alta Valle del But),
… Un fi sôl no cjolarès;
lui mi mangjarès la dote,
poi mi mande a raspâ uès.
(… un figlio unico non prenderei; lui mi mangerebbe la dote, poi mi manderebbe a raspar ossi.), dove appunto“ fi sôl” significa figlio unico, quindi viziato; questi finirebbe col dilapidarle la dote per poi lasciarla in miseria.
Ed infine un’ultima edizione, della quale non viene riportata la provenienza, forse più moderna ed adattata alla città; infatti riprende l’edizione di Paluzza e sostituisce “un cjargnel” con “un student” che, e mi riferisco soprattutto agli studenti di una volta, erano sempre senza soldi.
Il canto, collegato alla partenza degli alpini veronesi richiamati alla guerra del 1915/18, fa parte di un gruppo di canzoni che furono cantate sempre, quando fu più acuto fu il problema della partenza per la guerra, anche se non appartiene al patrimonio dei canti alpini ma, inizialmente, dei volontari di Curtatone e Montanara,
nel 1848 della prima guerra d’indipendenza che vide i volontari toscani e napoletani impegnare gli austriaci così consentendo ai piemontesi di concentrarsi e vincere a Goito.
E del resto la coscrizione obbligatoria si fa sentire pesantemente in Italia fin al tempo della dominazione di Napoleone I, che per le sue numerose guerre aveva un gran bisogno di soldati. A quell’epoca infatti risalgono molti canti militari, tutti improntati a un’indiscussa obbedienza, al dolore del distacco da mogli e figli, con un modulo riferibile al notissimo incipit ‘Addio mia bella addio / che l’armata se ne va / e se non partissi anch’io / sarebbe una viltà….io non ti lascio sola / ma ti lascio un figlio ancor / sarà quel che ti consola / il figlio dell’amor’.
Raffigurazione classica: il soldato stringe fra le braccia e bacia la sua amata, con l’angoscia di chi avverte la vicinanza di un destino indecifrabile e ostile, dal quale potrebbero essere annullati gli elementi di un’umana felicità, quella di vedere la nascita del suo bimbo. Elemento questo dalla forte simbologia, per il riferimento agli assi cardinali dell’antica cultura popolare del paese: la donna moglie e madre, la donna che attende con rassegnata fiducia nel ‘buon dio’, e accanto a lei l’uomo, consapevole e orgoglioso della paternità, della continuità dell’essenziale ruolo sociale rivestito e, nella oscura circostanza, delegato alla moglie, inevitabilmente in nome del ‘dovere patriottico’, infranto il quale gliene verrebbe vergogna e danno:
“ Senti cara Nineta cosa m'è capità:
m'è capità 'na carta che sono richiamà.
Se sono richiamato bella non sta a zigar:
tra quattro o cinque mesi mi vegno congedà.
Senti cara Ninetta il treno a cifolar,
sali sulla tradotta alpin ti tocca andar ”
Interessante poi, ma consueta, la proliferazione di tali motivi e simbologie, variati i contesti storici, in numerosissimi testi delle principali raccolte, a dimostrazione appunto della loro natura comunque popolare, anche qualora essi fossero stati prodotto ‘ d’autore ’, ad esempio:
“… Perché piangi ragazzo mio / perché piangito mai tu? / Piangi forse perché tu vai in guerra? / che ghe andarò mi par ti… ////… Camillo è già partito / che l’era tanto belo / la piuma sul cappello / faceva innamorar…/…Ohimè che passa il treno! / Treno di artiglieria / lancjeri e fanteria / e ma il mio amore non c’è!...////… Varda che bela machina / con trentasei vagoni / drento ghe xé el me Toni / vestio da militar…/…Solo te racomando / quell’unico bambino / tientelo a te vicino / no starlo abandonar…////…Nell’ultimo vagone / c’è l’amor mio / col fazzoletto bianco / mi dà l’addio / col fazzoletto bianco / mi salutava / e con la bocca i baci / la mi mandava…”, non potendosi tralasciare i ‘classici’, come a dire ‘Monte Canino’ ( “ Non ti ricordi quel mese d’aprile / un lungo treno varcava i confini / che trasportavano migliaia degli alpini: / su, su, correte, è l’ora di partir!...”), o ‘La tradotta’ ( “ La tradotta che parte da Torino / a Milano non arriva più / ma la va diretta al Piave / cimitero della gioventù!...”), o infine ‘E col cifolo del vapore’ ( “E col cifolo del vapore / la partenza de lo mio amore / è la partenza de lo mio amore / chi sa quando ritornerà!...”).
Importante pure annotare i sintagmi, le icone ricorrenti in tali raffigurazioni.
Anche in ‘Senti cara Nineta’ troveremo il soldatino fiducioso per il moschetto e lo zaino cui quasi s’affida; la lunga fila dei vagoni con ragazzi-soldato affacciati a salutare con malcelata o incosciente allegria; gli anziani del paese, discosti alquanto, confusi tra l’orgoglio per quei ‘figli’ valorosi e, nel cuore, i presagi di una sventura ai loro occhi e nella loro memoria assai vicina; la morosa accanto alla vaporiera che sbuffa impaziente sui binari. Il tutto inciso nel treno che cìfola, sibila, zufola, fischia: tutti i paradigmi del richiamo emotivo al gruppo degli amici, alla borgata così pacifica e affidabile, all’intima parlata dialettale… (1).
Ma anche, nella letteratura popolare meno retorica, quella che della guerra racconta i profili sinceri senza veline forzosamente patriottiche, i treni colmi di feriti, azzoppati, ammalati definitivamente nel cuore e nella mente, come, in un differente
contesto ma per una cruda analogia, nella musica e nelle parole di Francesco De Gregori nella sua ‘Generale’:
“... Generale dietro la stazione
lo vedi il treno che portava al sole
non fa più fermate neanche per pisciare
si va dritti a casa senza più pensare
che la guerra è bella anche se fa male
che torneremo ancora a cantare …”
“ Una poesia cantata, dove si legge la drammaticità della guerra, sempre e drammaticamente attuale. Sembra di vederla la Tradotta col suo carico umano di feriti. Sembra di sentirla quella puzza di piedi e di sudore, mentre la locomotiva traina e scivola sbuffando sui binari e si allontana da quel tramonto, ancora troppo vicino, che s'illumina a tratti di spasimi di lampi colorati degli scoppi delle granate”(2).
In ‘Senti cara Ninéta’ l’impasto contiene tutto ciò, lo lascia intendere al di là della propria semplicità: netta, seppure sommessa, la rassegnazione al destino di chi può solo accettare, dell’amata, alla quale, inespresso per deferenza o dolore, rimarrà un tempo incommensurabile di incertezza, ma pure la certezza di fatiche cui corrispondere da sola, l’affanno del garantire comunque alla ‘famiglia’ la necessaria sopravvivenza, morale e materiale. Perché a lei innanzitutto, perché donna, ciò compete, indiscutibilmente, allora come, meno conflittualmente, ai nostri giorni.
Note:
1 - Le tradotte trasportavano al fronte i soldati, e dalle prime linee (dove si sparava) anche i feriti, militari in congedo o in licenza.
2 - Sulle tradotte i fanti cantavano le canzoni di sempre e da fuori si capiva che era una tradotta di ritorno dal fronte. Quelle che partivano erano invece silenziose, cupe, portavano i soldati, a migliaia, che ‘andavano a morire’.
La Prima Guerra Mondiale pure si concluse a bordo di un treno. L'armistizio, tra l’Impero Tedesco e le forze alleate, venne firmato, l’11 Novembre 1918, a bordo della carrozza 2419 dell'Orient Express, in sosta presso Compiègne.
Ancora un treno, nel 1921, attraversa il Friuli, il Veneto e il Trentino per giungere a Roma il 4 novembre, il giorno della vittoria: vi viaggia la bara del Milite Ignoto, scelta tra i caduti senza nome dei vari fronti di guerra, che verrà tumulata nell’Altare della Patria….( Tratto da “ forum.moldweb.eu > vivere in Italia > Storie di vita vissuta ”).
Sergio Piovesan
Son barcarol
Per un coro come il nostro1, nato nel 1949, il repertorio del Coro del S.A.T.2 è stato, ed è, importante e, quindi, molti dei canti che eseguiamo fanno parte di quel repertorio che prende il nome di “canti di montagna”. Cosa siano i “canti di montagna” se n’è discusso tanto ed ancora se ne discuterà, ma che “Son barcarol” sia uno di questi, direi che è difficile da dimostrare.
Il canto, armonizzato da Antonio Pedrotti3, viene definito come originario della Valsugana dove, tuttavia, barche e mare non si trovano. Della stessa zona vi è anche “Barcariolin de Trento”.
Ma non è solo il Trentino ad appropriarsi di un “canto di mare”: in Lombardia troviamo “Lena mia, son barcarolo”, e così via. Il tutto deriva dal fatto che, nei tempi andati, le musiche ed i canti popolari, trasmessi solo oralmente, passavano da un luogo ad un altro e, nel nuovo luogo, se il canto piaceva, rimaneva e diventava patrimonio musicale e canoro di quella zona.
Nel nostro caso “Son barcarol” –ma non è detto che il titolo sia solo questo e vedremo più avanti- nato senz’altro in riva al mare, passò dalla zona d’origine ad altri luoghi.
A Venezia, dove barche, barcaioli e mare non mancano, il canto si trova con il titolo “Nina mia son barcherolo” (o barcarolo) ed il testo è simile a quello trentino e/o lombardo. Un titolo uguale lo troviamo anche in zona istriana e triestina, ma definire dove effettivamente sia nato è difficile e, quindi, per definizione, affermiamo che l’area dell’alto Adriatico è la zona d’origine.
Il testo, riassunto in poche parole, racconta dell’invito di un barcaiolo ad una fanciulla a salire sulla sua barca e questo invito viene rivolto con tutte le assicurazioni; ma la conclusione, come si può immaginare, è … il disonore della fanciulla.
All’inizio il barcaiolo, che negli altri canti popolari di questo genere diventa il cavaliere, il signore o il cacciatore, per irretire la fanciulla (a volte è la pastorella) si presenta come “gentil galante”; è questa una figura che troviamo in tanti altri canti popolari classificati come “pastorelle” o “villanelle”4 ed il “gentil galante” si presenta sempre bello, ossequioso, elegante, gentile, ma, questa presenza è tutta apparenza.
La figura del “gentil galante” è caratteristica soprattutto dei canti di origine piemontese e del nord Italia in genere.
Il testo dell’area adriatica, invece di “… son gentile son galante … “ ci riporta “… son de l’arte e son galante …”; il termine “galante” sussiste ancora, mentre troviamo questo “son de l’arte” che rassicura in quanto “… è del mestiere” e, cioè, è un vero barcaiolo. Questa caratteristica è sicuramente veneziana in quanto, nella Serenissima, ogni lavorante doveva essere iscritto alla corporazione o arte o scuola. Tornando al canto, questo termine era quasi un’assicurazione.
Il testo dell’edizione trentina è il seguente:
“Son barcarol, son barcarolo / son gentile son galante / su la mia barca se vuoi venire / anderemo in alto mar.
In alto mar che noi saremo / un bel fuoco accenderemo / e qualche cosa cucineremo / a l'usanza del barcarol.
O bimba mia non aver paura / se la notte la si fa scura / che se la notte la si fa scura / doppio amore ti porterò.”
Il testo veneziano è simile nelle prime due strofe; con variazioni in qualche termine, mentre la terza strofa è diversa e recita così: “Barcaiolo mio caro, / barcariol menime via / che voglio ‘ndar da la mama mia / a contarghe del disonor.”
NOTE
1 Coro Marmolada di Venezia
2 Coro della S.A.T. (Società Alpinisti Tridentini) di Trento
3 Antonio Pedrotti (Trento, 1901 – 1975) è stato un compositore, direttore d'orchestra e direttore di coro italiano.
4 “Pastorelle” o “villanelle” – Antichi canti d’amore , derivanti dai madrigali, in ambiente agreste/pastorale.
Sergio Piovesan
Da pochi giorni mi trovavo presso la caserma “Chiarle” della Scuola Militare Alpina di Aosta per la seconda parte del 27° Corso AUC. Era una domenica mattina del luglio 1961 e le due compagnie di allievi si trovavano schierate nel cortile della caserma dove era celebrata la Santa Messa; all’elevazione, dopo l’usuale squillo di tromba, un gracidio, classico dei dischi a 78 giri, proveniente dall’altoparlante anticipò un improvviso “Se tu vens cassù ta’ cretis … ”, il primo verso di un canto che io, fin da bambino, avevo appreso da mia madre. Era “Stelutis alpinis” il canto che, tradizionalmente, viene eseguito durante le Messe delle truppe alpine e che mi accompagnò per il resto della “naia”. Subito dopo quella Messa ci fu chi lanciò l’idea di formare un coro, soprattutto per l’accompagnamento della liturgia. Naturalmente anch’io vi partecipai e, dopo 15 giorni il coro del 27° Corso AUC della Scuola Militare Alpina sostituì il disco ormai consunto. Da allora “Stelutis alpinis” mi ha continuato ad accompagnare anche, e soprattutto, nei miei ultimi quarant’anni come corista del “Marmolada”.
“Stelutis alpinis” fu scritto e composto da Arturo Zardini (1869-1923) nel periodo della Prima Guerra Mondiale, quando l’autore, un maestro di Pontebba, paese che allora si trovava sul confine italo-austriaco (l’abitato dall’altra parte del fiume che segnava la linea di demarcazione si chiamava Pontafel), si trovava profugo a Firenze. Forse proprio in Piazza della Signoria, leggendo sul giornale le notizie delle stragi che avvenivano al fronte, lo Zardini, commosso e rattristato da quelle vicende, trasse l’ispirazione del testo e della musica.
È quindi un canto d’autore ma che, da molti è ritenuto di origine popolare, caratteristica questa dei canti che, nel testo e nella musica, raggiungono livelli di alta poesia e che, per questo motivo, diventano patrimonio di tutto il popolo. Da subito fu fatto proprio dagli Alpini sia friulani sia di altre regioni ed ancora oggi, all’età di quasi novant’anni, rimane il canto simbolo delle truppe alpine, ma anche di tutto il popolo friulano.
Con questa composizione la poesia e la forza dell’autore si sono manifestate nella loro pienezza raggiungendo l’apice, in un commovente sincretismo e tutte le umane sofferenze si sono compendiate con toccante espressività. Non sono necessarie molte parole: ci basta pensare al brivido che ci percorre nel cantare e nell’ascoltare «..Se tu vens cassù ta' cretis...», brivido che si trasforma in emozione violenta, da serrarci la gola.
È un compendio di sofferenze, di dedizioni, di intimità, di affetti, di certezze. Non più canto, non villotta, ma preghiera profonda e, nello stesso tempo, semplice ed umana, come semplice ed umano era ed è lo spirito di Zardini.
Per i friulani “Stelutis alpinis” è sì il canto dell’Alpino morto, ma è anche considerato quasi un inno, un inno al Friuli, un inno per quella terra che ha vissuto altre sofferenze: un’altra guerra, invasioni straniere, lotte fratricide e dolorose emigrazioni.
Esaminando il testo (vedi in calce) non si può far a meno di notare il largo uso dei diminutivi, o meglio dei vezzeggiativi, caratteristica abituale nel linguaggio scritto e parlato dei friulani; “stelutis”, “crosute”, “arbute” e “bussadute” non vanno tradotti con i relativi diminutivi in italiano anche perché, oltre a ridicolizzare il testo, non hanno proprio quel significato. È una forma che si può definire affettuosa nella descrizione di oggetti ed azioni e, forse, è meglio tradurli con una perifrasi.
“Stelùte” (al plurale “stelùtis”) viene indicato nel Vocabolario Friulano (Pirona) come diminutivo, spesso come espressione affettiva, di “stele” (stella); lo stesso lemma manda a vedere “stèle alpine” che fra i sinonimi prevede anche “stele” soltanto; inoltre è citato come esempio il verso dello Zardini. La parola “crosute” è il diminutivo, sempre in forma affettiva, di “crôs”, croce, mentre “arbute” lo è di “arbe”, cioè erba, che però ha una forma più usata in “jarbe” col relativo diminutivo in “jarbute.
Infine, per concludere con i diminutivi, o come meglio indicato, con i vezzeggiativi o espressioni affettive, “bussadùte” si collega a “bussàde” (sostantivo femminile), bacio, che può anche essere tradotto con il sostantivo maschile “bùs”, in realtà poco usato.
Un altro termine interessante da esaminare è “cretis”; è il plurale di “crète” che vuol dire rupe, ma anche roccia, macigno, pendio roccioso, cresta o cima nuda di montagna. Se “crète” è un sostantivo femminile troviamo anche “crèt”, sostantivo maschile, con lo stesso significato. Sinonimo di “crète” è anche “cròde” che si avvicina al significato di croda cioè cima rocciosa appuntita tipica delle Dolomiti.
Un termine che nel verso prende un significato esteso è “duàr”. Letteralmente significa “dormo” (in questo caso si tratta di sonno eterno) e la forma infinita è “duarmî”, ma anche “durmî”.
Altri potrebbero essere i termini da esaminare ma, per non annoiare il lettore, penso che quelli sopra citati siano sufficienti ed i più interessanti soprattutto per una maggiore comprensione del testo poetico, che invito a leggere con attenzione sia in friulano e sia nelle due traduzioni.
Purtroppo, come accade per i canti che diventano famosi, c’è sempre qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, pensando, con una discreta dose di superbia, di migliorare l’opera; nel nostro caso c’è stato chi ha pensato che il bellissimo testo di Zardini avesse bisogno di strofe in più ed ecco quindi un’aggiunta apocrifa che riporto per sola documentazione.
Ma 'ne dì quant che la vuere / a' sara un lontan ricùard / tal to cûr, dulà ch'al jere / stele e amôr, dut sara muart. / Restarà par me che stele / che 'l miò sanc a là nudrit / par che lusi simpri biele / su l'Italie a l'infinit.
(Ma un giorno quando la guerra sarà un ricordo lontano, nel tuo cuore, dove c’erano la stella alpina e l’amore, tutto sarà morto. Per me resterà quella stella, che il mio sangue ha nutrito, perché luccichi sempre bella sull’Italia all’infinito.)
Molti credono quest’ultime strofe originali e questo si può riscontrare anche su siti internet fra i quali alcuni addirittura di Sezioni dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini).
Testo in friulanoSe tu vens cassù ta' cretislà che lôr mi àn soterât, al è un splaz plen di stelutis; dal miò sanc l’è stât bagnât.
Par segnâl, une crosute je scolpide lì tal cret, fra chês stelis nas l'arbute, sot di lôr, jo duâr cujet.
Cjôl sù, cjôl une stelute: jê 'a ricuarde il nestri ben. Tu j darâs 'ne bussadute e po' plàtile tal sen.
Quant che a cjase tu sês sole e di cûr tu préis par me, il miò spirt atôr ti svole: jo e la stele sin cun te. |
Traduzione letterale
Se tu vieni quassù fra le rocce, là dove mi hanno sotterrato, c’è uno spiazzo pieno di stelle alpine; dal mio sangue è stato bagnato.
Come segno, una piccola croce è scolpita lì sulla roccia, fra quelle stelle nasce l'erba, sotto loro io dormo tranquillo.
Cogli, cogli una stella alpina: essa ricordo il nostro amore. Tu dalle un bacio e poi posala sul seno.
Quando a casa tu sarai sola, e di cuore tu preghi per me, il mio spirito ti aleggia intorno: io e la stella siamo con te. |
Traduzione libera
Se tu verrai quassù fra le rocce, dove fui sotterrato, troverai uno spiazzo di stelle alpine bagnate del mio sangue.
Una piccola croce è scolpita nel masso; in mezzo alle stelle ora cresce l'erba; sotto l'erba io dormo tranquillo.
Cogli, cogli una stella alpina: essa ti ricorderà il nostro amore. E baciala, e nascondila poi nel seno.
E quando sarai sola in casa, e pregherai di cuore per me, il mio spirito ti aleggerà intorno: io e la stella saremo con te. |
| Il testo riportato è quello corretto ed originale dell’autore ed anche la grafia friulana è quella esatta. La traduzione sulla terza colonna è una libera interpretazione del poeta friulano Chino Ermacora così come la scrisse nella rivista “PICCOLA PATRIA” nel 1928 |
STELUTIS ALPINIS le strofe apocrife
Sinonimi del termine “apocrifo” sono falso, fasullo e falsamente attribuito. “Strano modo di iniziare un articolo”, penserà qualcuno ma, andando avanti, vedrete che l’inizio è attinente.
Alcuni giorni fa sulla casella di posta del coro arrivò una mail, scritta da una persona di Pontebba, inerente “Stelutis alpinis”. Aveva letto il mio articolo su questo canto (pubblicato su “Marmoléda” di settembre 2005) al quale era giunto tramite “Wikipedia”, la famosa “enciclopedia” della rete, dove viene evidenziata la presenza di due strofe apocrife, e chiedeva di cancellare dal sito del Coro Marmolada le due strofe in questione.
A parte il fatto che, quanto riportato nel sito, non è altro che la copia digitale di questo notiziario, stampato in numerose copie e, quindi, di impossibile cancellazione, ribadisco che nell’articolo in questione il testo di “Stelutis alpinis” è riportato, in un riquadro apposito, nella versione scritta da Arturo Zardini e, solo nel proseguo dell’articolo, ho segnalato le altre due strofe, che sapevo essere non originali ma non ne conoscevo l’autore, precisando che si trattava appunto di strofe apocrife. Sulla discussione in “Wikipedia” il presidente Rolando Basso ha precisato quanto sopra. Tutto quanto successo mi ha stuzzicato e, allora, sono andato alla ricerca di notizie in merito, ed ho trovato come si è arrivati a questa aggiunta.
Apro una parentesi precisando che altri canti hanno subito questo tipo di alterazione: solo per citarne uno, ricordo che anche “Signore delle cime”, di Bepi De Marzi, ebbe una terza strofa apocrifa scritta da un sacerdote, ancora negli anni ’60, cioè a poco tempo della pubblicazione del canto stesso.
Lo Zardini scrisse il canto a Firenze nel 1917, canto che, alla fine della guerra, divenne subito famoso, oltre che in Friuli e fra i friulani, anche fra gli alpini.
Rocco Tedino e Mauro Unfer, autori della pubblicazione “Il tempio ossario di Timau”, scrivono: « … Poi qualcuno, non si saprà mai chi, ribattezza “Stelutis” il “canto dell’Alpino morto” e sancisce, senza volerlo, un atto di adozione ufficiale della canzone da parte degli Alpini che ne faranno la gemma più preziosa del loro repertorio. Nel 1921, ad esempio, l’A.N.A. di Milano ringrazia Zardini e la Società Filologica Friulana per aver ottenuto il permesso di inserire “Stelutis Alpinis” in un canzoniere Alpino che l’Associazione ha in animo di pubblicare quanto prima, assicurando “…che la riproduzione sarà eseguita in tutta cura ed esattezza e che senza fallo alcune copie del Canzoniere verranno inviate a suo tempo a codesta Società…”».

Nello stesso anno il colonnello Vincenzo Paladini di Udine, ricevuto l’incarico di sistemare il cimitero di guerra di Timau, ebbe l’idea di far incidere “Stelutis Alpinis” su una lapide in marmo, da collocare in posizione preminente fra le sepolture, perché rappresenti un degno completamento degli onori da tributare a quei valorosi Caduti per l’Italia. Però, secondo lui, a questo testo mancava qualcosa e cioè un chiaro riferimento alla Patria ed allora chiese allo Zardini di completare la sua composizione con altre strofe che esprimessero, chiaramente, questo sentimento. Ed allora il 29 luglio 1921 il Paladini scrisse allo Zardini questa lettera: “Illustre Signore, essendomi caduta sott’occhio la sua bellissima poesia “Stelutis alpinis”, avrei pensato di farla incidere su di una lapide per adornare uno dei nostri cimiteri di guerra in Carnia. Ma a ciò manca nelle mirabili strofe, così piene di sentimento, un accenno alla Patria, che le farebbe più appropriate alle tombe di soldati morti per essa. E’ ardimento soverchio il mio, senza che abbia nemmeno l’onore di conoscerLa di persona, di pregarLa a voler mutare quanto basti perché corrispondano allo scopo? Mi sia, ad ogni modo, di scusa l’ammirazione che ho per il suo impegno, e insieme il culto verso i nostri gloriosi Caduti, e gradisca i sensi della mia riconoscenza profonda e della mia alta osservanza”.
A questa richiesta lo Zardini rifiutò di dare seguito anche perché considerava la sua canzone ben riuscita così com’èra e non intendeva assolutamente modificarne il testo. Intervenne anche un suo compaesano coetaneo, Francesco Bierti, che già aveva collaborato scrivendo alcuni testi poi musicati dallo Zardini stesso, ed alla fine sembra, e sottolineo “sembra”, che abbia ceduto lasciando che Bierti scrivesse le due quartine richieste dal Col.Paladini con lo specifico riferimento all’Italia.
Il 4 gennaio 1923 Arturo Zardini morì e, ad un anno dalla scomparsa, il fratello fece stampare un biglietto commemorativo che riportava il testo di “Stelutis alpinis” e, inspiegabilmente, anche con le due strofe del Bierti. Alle sdegnate rimostranze della vedova, signora Elisa, e degli amici, ritirò il biglietto e lo fece ristampare corretto.
Ma non era ancora finita! Nel 1948 alcuni personaggi espressero l’opinione di rimaneggiare il canto, anche nella parte musicale, perché “ … difetta di contrappunto ed armonia.”. Anche in questa occasione la vedova si fece sentire con una lettera ripresa dalla stampa. Un ultimo tentativo, o “castroneria”, come la definì la battagliera signora Elisa, vi fu nel 1952 quando, a seguito della commemorazione di Francesco Bierti presso la Società Filologica Friulana, la stampa locale attribuì al defunto commemorato l’intera paternità di “Stelutis alpinis”.
Veniamo ai giorni nostri: il nipote di Zardini continua a “combattere”, giustamente, contro queste strofe apocrife perché c’è ancora chi continua ad ignorare che le ultime strofe non sono di Zardini. Inoltre, e questo l’ho verificato ultimamente, esistono siti internet, di cori, ma anche di musica e di associazioni d’arma, che continuano nell’errore al quale, spesso aggiungono anche la caratteristica di definire il canto come “popolare”, senza indicarne l’autore. Poi ci sono quelli che, fatta una nuova armonizzazione, trascurano il nome dell’autore evidenziando, ovviamente, quello dell’armonizzatore. Il tutto è, senz’altro, questione di ignoranza e/o di superficialità.
Un’ultima testimonianza: il sottoscritto conosce “Stelutis alpinis” fin da bambino, perché appreso dalla madre ed ho sempre saputo che la canzone terminava con “… jò e la stele sin cun te”.
Poi, dopo la naja fra gli alpini, approdai all’A.N.A., e lì venni a conoscenza, perché usavano cantarle, di queste due strofe aggiunte.
La riproduzione del testo tratto da “Il tempio ossario” di Rocco Tadino e Mauro Unfer mi è stata autorizzata per via telefonica da uno degli autori (M.Unfer).
Analoga autorizzazione vale per la fotografia che riporta il testo autografo dello Zardini
Sergio Piovesan
“Cammina … cammina” è il titolo dello spettacolo, che, con due voci recitanti e coro, proporrà -in data 14 marzo 2008- il ricordo della ritirata di Russia attraverso le pagine di Giulio Bedeschi e Mario Rigoni Stern.
Sarà un “discorso corale” contro la guerra, contro tutte le guerre. E gli alpini ne sono testimoni anche attraverso i loro canti.
Per questa occasione, il Coro Marmolada, che farà da “controcanto” alla voce recitante, ha rispolverato alcuni canti sul tema fra i quali “Sul ponte di Perati”, un brano che ricorda il sacrificio degli alpini della Julia nella sciagurata campagna di Grecia 1940/1941.
Ma il brano non nasce in quell’occasione in quanto, ancora durante la
prima guerra mondiale gli alpini cantavano, sulla stessa melodia e con
parole simili, “Sul ponte di Bassano, / bandiera nera, / è il
lutto degli Alpini / che va alla guerra.”
Una guerra assurda, come tutte le guerre, e gli alpini lo
sapevano bene, tanto che, racconta qualche reduce, i versi spontanei di
quei giorni, sui monti della Grecia, erano : "Quelli che l'han
voluta non son partiti, quelli che son partiti non son tornati”.
Ma questo testo il regime non lo sopportava ed allora fu subito
censurato.
Le strofe, nelle numerose edizioni che ho avuto modo di consultare, sono diverse, forse anche aggiunte posteriormente, ed il testo completo è abbastanza lungo.
Riportiamo di seguito il testo nella versione che cantiamo noi del “Marmolada”: “Sul ponte di Perati bandiera nera / l’è il lutto degli Alpini che fan la guerra. Quelli che son partiti non son tornati / sui monti della Grecia sono restati. / Sui monti della Grecia c’è la Vojussa / col sangue degli Alpini s’è fatta rossa.. / Un coro di fantasmi vien giù dai monti / è il coro degli Alpini che sono morti. / Un coro di fantasmi vien giù dai monti / è il coro degli Alpini che sono morti. / Alpini della Julia in alto i cuori / sul ponte di Perati c’è il Tricolore.”
Piccole diversità nel testo, probabilmente dovute a trascrizioni, non negano la validità del canto che è, sempre e comunque, una denuncia sull’inutilità della guerra. Nella prima strofa della nostra versione troviamo “ … l’è il lutto degli Alpini che fan la guerra”, mentre su altre versioni, anche su quella originaria (Sul ponte di Bassano), il testo è: “… l’è il lutto degli Alpini che van la guerra”. I due verbi hanno una notevole differenza di significato nel contesto. Gli Alpini, ma anche tutti i soldati, non andarono in guerra perché volevano farla, e quindi non facevano la guerra, ma la subivano perché dovevano andarci, mandati da chi voleva fare la guerra che poi erano quelli, come detto sopra, che … non partivano!
Il canto, ambientato nelle vicende della campagna di Grecia, nasce quindi nel 1942 e divenne subito famoso, non solo fra gli alpini, ma anche fra il resto dell’esercito. Ed è per questo motivo che lo ritroviamo, negli anni successivi, ovviamente trasformato sia nei luoghi che nei nomi delle unità combattenti, fra altre unità dell’esercito italiano(1), fra i partigiani(2) e fra coloro che scelsero la R.S.I.(3).
Note
(1) - I soldati della divisione Acqui, decimati dai tedeschi a Cefalonia
trasformarono il titolo in “Banditi della Acqui” il cui testo della
prima strofa recita: “Banditi della "Acqui" / in alto il cuore / sui
monti di Cefalonia / sta il tricolore.
(2) - Nuto Revelli, ufficiale degli alpini della Tridentina nella
tragedia della campagna di Russia, che divenne uno dei primi
organizzatori della resistenza armata nel Cuneese, scrisse “Pietà l’è
morta”, ispirandosi, come scrisse lo stesso autore, al “Ponte di Perati”.
Palesemente ricalcato sul "Ponte di Perati" è anche il canto composto
collettivamente dai componenti della formazione partigiana "Maiella",
che operò anche nell'Appennino romagnolo, e che divenne in qualche modo
l'inno ufficiale di quel gruppo di partigiani abruzzesi.
“Sul ponte fiume Sangro, bandiera nera, / è il lutto
della Maiella che va alla guerra”.
(3) - “Sul fronte di Nettuno, / bandiera nera! / È il lutto del San Marco / che fa la guerra. / Lutto del Barbarico / che fa la guerra: / la meglio gioventù / che va sotto terra!”. Sono questi i versi creati da un reparto con le mostrine del San Marco, che prese il nome di Btg. Barbarigo, alle dipendenze della X Mas, che operò sul fronte di Anzio.
Tibié paiom .... di Bortnianskiy o di Čiajkovskij ?
Si sa che su internet si trova di tutto e di più; molto spesso si tratta di informazioni corrette, ma, a volte, quanto troviamo può definirsi "bufala". È importante, però, distinguere l'informazione corretta da quelle non giuste ed il modo più valido è quello di interrogare fonti diverse.
Premesso quanto sopra, entro nel merito di quanto ho trovato relativamente ad un canto che il "Marmolada" ha in repertorio da qualche anno. Si tratta di un canto della liturgia del mondo slavo, ortodosso, ma anche cattolico, e mi riferisco a "Tibié paiom" di Dimitri Bortnianskiy (1751-1825). (Tibié paiom / Tibié blagaslavim / Tibié blagadarim Gospodi // I malim ti sia Boje nach, / I malim ti sia Boje nach, 7 I malim ti sia Boje nach,Boje nach./ I malim ti sia Boje nach. ) (Traduzione: Noi ti cantiamo, / noi ti benediciamo, / noi ti ringraziamo, Signore nostro./ Ti preghiamo Dio nostro.).
Sergio Piovesan
TUTTE LE FUNTANELLE
Nella storia di un coro, a volte, i canti ritornano; può capitare, infatti, di apprendere un determinato canto e poi, dopo un certo periodo, di abbandonarlo. Ma, passati alcuni anni, per i più svariati motivi, il canto, a suo tempo abbandonato, viene ripreso. Per alcuni componenti il coro si tratta, però, di un nuovo brano, essendo questi entrati in organico solo dopo l’abbandono del canto in questione.
Questa premessa per rendere noto che, proprio di recente, abbiamo ripreso (e la prossima stagione sarà nuovamente inserito in repertorio) il canto abruzzese intitolato “Tutte le funtanelle” nell’armonizzazione di G.Carlo Bregani che, nello spartito annota trattarsi di “ canto popolare abruzzese, il cui testo poetico sembra possa attribuirsi al D’Annunzio”.
In altre fonti non ho trovato notizia di questa attribuzione e, d’altra parte, non si può definire un canto come “popolare” e poi attribuirlo ad un poeta che, nella storia della nostra letteratura, non è fra i meno noti.
Inoltre se fosse il D’Annunzio l’autore del testo, sarebbe noto anche il nome del musicista e, invece, tutte le fonti riportano come anonimo sia nel testo che nella musica.
Il Bregani, che annota sullo spartito questa probabile attribuzione, forse è stato tratto in errore dal fatto che il testo di “Tutte le funtanelle” viene riportato dal D’Annunzio nel suo romanzo “Il trionfo della morte” dove il canto viene ascoltato dal protagonista in “ … un pianoro dove le ginestre fiorivano con tal densità da formare alla vista un sol manto giallo, d'un colore sulfureo, splendidissimo. … “.
Le esecutrici sono cinque fanciulle che raccoglievano i fiori. “ … Cantavano un canto spiegato, con accordi di terza e di quinta perfetti. Quando giungevano ad una cadenza, sollevavano la persona di sul cespuglio perché la nota sgorgasse più libera dal petto aperto; e tenevano la nota, a lungo, a lungo, guardandosi negli occhi, protendendo le mani piene di fiori. … ”.
Ed ancora: “ … Favetta intonò, sul principio mal sicura, ma di nota in nota rassicurandosi. La sua voce era limpida, fluida, cristallina come una polla. Cantava un distico; e le compagne cantavano in coro un ritornello. Prolungavano la cadenza, concordi, riavvicinando le bocche per formare un sol flutto vocale; che si svolgeva nella luce con la lentezza delle cadenze liturgiche. … “.
Ed il canto intonato dalle fanciulle e riportato dall’autore è, appunto, “Tutte le funtanelle”.
Il canto è di autore sconosciuto e riportato dall’autore nel suddetto romanzo in quanto un canto della sua terra.
Nella prefazione a questo romanzo dedicata a Francesco Paolo Michetti, che il D’Annunzio chiama “Cenobiarca” (letteralmente “capo di un cenobio o abate” e, in senso figurato,”capo di un cenacolo letterario o artistico”), scrive: “ … in questo Trionfo io più volte ho celebrato le feste de' suoni, de' colori e de le forme.”
Ed inoltre: “ … E ti ho anche raccolta in più pagine, o Cenobiarca, l'antichissima poesia di nostra gente: quella poesia che tu primo comprendesti e che per sempre ami. …”.
Queste ultime affermazioni di D’Annunzio non fanno altro che confermare come il canto sia di autore sconosciuto e riportato da lui nel suddetto romanzo in quanto un canto della sua terra.
Il testo riportato del canto, un canto d’amore dove il sentimento d'amore o le pene che esso produce nel cuore ne costituiscono il motivo.
Tutte le funtanelle se sò sseccàte.
Pover'Amore mi'! More de séte.
Tromma larì lirà llarì llallerà
Tromma larì, lirà, vvivà ll'amóre!
Amóre mi té' sét'e mmi té' sète.
Dovèlle l'acque che mme si purtàte?
Tromma larì lirà...
T'àjje purtàte 'na ggiàrre de créte,
Nghe ddu' catène d'óre 'ngatenate.
Tromma larì lirà...
Questo testo, quindi, è da ritenersi il più affidabile in quanto trascritto da un poeta molto attento alla parola e che conosceva senz’altro bene la parlata della sua terra e della sua gente.
Sergio Piovesan
Una vecchia filastrocca veneziana: "San Martin"
C'è una canzone, una filastrocca, che anni fa tutti i bambini veneziani conoscevano e cantavano, accompagnandosi con pentole, coperchi, mescoli di legno e quant'altro potesse fare confusione, la vigilia di san Martino, festa che concludeva l'anno agricolo. Oggi solo sparuti gruppetti tornano a rinnovare queste antiche usanze.
Molto probabilmente l'origine geografica del canto è l'entroterra veneziano, la campagna, anche se di questo canto, là, mi risultano minori riscontri. Sicuramente il canto si rintraccia, da generazioni, a Venezia.
È un canto di questua in quanto i bambini si fermavano davanti a negozi e abitazioni e continuavano a cantare, battendo la "batteria" casalinga, finché non ricevevano qualcosa; " ... e col nostro sachetin, ve cantemo el San Martin" è il ritornello.
Il testo del canto recita così:
San Martin xè andà in sofita
par trovar la so noviza;
so noviza no ghe giera,
San Martin xè andà par tera.
E col nostro sachetin,
ve cantemo el San Martin.
Su 'sta casa ghe xè do putele
tute risse e tute bele
col viseto delicato
suo papà ghe lo gà stampato.
E col nostro sachetin,
ve cantemo el San Martin.
Siora Cate xè tanto bela
in mezo al peto la gà 'na stela,
se no la gavesse maritada
so papà no ghe l'avaria dada.
E col nostro sachetin,
ve cantemo el San Martin.
Siora Lussia la fassa presto
ch'el caigo ne vien adosso,
el ne vie adosso sul scarselin,
siora Lussia xè San Martin.
La prima strofa, però, così come mi è stato riferito da una signora di una "certa età", non sarebbe molto vecchia e risalirebbe a fine '800 primi '900. Infatti, il fatto che San Martino avesse una "noviza", una fidanzata, è un po' anacronistico, ma i versi sarebbero nati in quanto, all'epoca, nella contrada vicino a San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello, c'era un uomo anziano, di nome Martino, che aveva la velleità di corteggiare e concupire le giovani; una di queste, molto probabilmente per soldi, aveva ceduto ed il vecchio la considerava la sua "noviza". Questa, probabilmente, aveva qualcun altro ed un giorno il vecchio Martino, "el sior Martin", essendo andato a trovarla a casa, in soffitta, forse perché si trattava di un povera, non la trovò e ... rimase di stucco o come meglio dicono alcune versioni del canto " ... xè anda par tera" o, meno forbitamente "... col cul par tera".
Si riporta qui sotto lo spartito per due voci bianche e, cliccando qui, potrete ascoltare la musica (digitale) creata con lo spartito stesso.
Sergio Piovesan
Vamos Construir
Durante uno dei primi incontri, a casa dei signori Annamaria e Giovanni Gabrieli (lei è presidente dell’Associazione Amici della Colonia Venezia di Peruibe), organizzati allo scopo di concordare l’attività del coro al fine di organizzare alcuni concerti nei quali raccogliere fondi per il finanziamento dell’opera iniziata da Padre Giorgio Callegari, ci fu presentata una video-cassetta, registrata con Padre Giorgio a San Paolo ed a Peruibe.
Vi si vedeva come operava l’organizzazione che, anche con enormi difficoltà, era riuscita, e riusciva quotidianamente, ad intervenire nell’istruzione dei bambini e dei giovani e ad assicurare il vitto giornaliero a numerose famiglie povere delle “favelas”.
C’erano sempre molti bambini che attorniavano Padre Giorgio e che, nonostante tutto, sorridevano.
Ad un certo punto della registrazione si sentiva un bambino che, accompagnato da una chitarra, iniziava un canto; al primo ritornello si univa un’altra voce. Il canto era molto dolce e melodico. Nel proseguire delle strofe si univano altre voci, sempre di bambini, finché alla fine era veramente un coro che cantava: “Vamos Construir Uma Ponte Em Nos / Vamos Construir, Pra Ligar Seu Coraçao Ao Meu / Com O Amor Que Existe Em Nos!”
Restai subito affascinato da questo canto e, quando, terminata la riunione, uscii, ne ebbi conferma dall’amico Rolando perché anche lui aveva vissuto le stesse mie emozioni.
Tutti e due pensammo subito che sarebbe stato bello che anche il Coro Marmolada potesse cantare “Vamos Construir”.
Esistevano, però, delle difficoltà tecniche. I nostri ospiti di quella sera non erano in possesso dello spartito e, neppure interpellando la Colonia Venezia di Peruibe, furono in grado di procurarcelo. Esistevano solo il testo con gli accordi per l’accompagnamento della chitarra e la colonna sonora della video-cassetta.
Colonna sonora, testo ed accordi furono affidati ad una musicista, la M.a Stefania Caggiula, che, con perizia, ricostruì la linea melodica su spartito. Eravamo a buon punto! Era necessaria, ovviamente, un’armonizzazione che si adattasse alle nostre voci.
Fornimmo la linea melodica ad alcuni musicisti perché procedessero all’armonizzazione, precisando che il coro n’avrebbe scelta una: ci sono pervenute solo due armonizzazioni, una della stessa M.a Caggiula ed un’altra del M.o Michele Paguri, e la scelta del coro cadde su quest’ultima.
Ovviamente, dovendo eseguire il canto pubblicamente, il coro è tenuto ad indicare gli autori. Un’altra ricerca! Per fortuna c’è venuto in soccorso José de Rezende Ribeiro, presidente del Centro Ecumênico de Publicações e Estudos “Frei Tito” di Alencar Lima (CEPE), un’Ong fondata da frei Giorgio Callegari, che ci ha fornito queste informazioni: il canto “Vamos Construir” è la versione brasiliana di "Love can build a bridge" (L'amore può costruire un ponte) di John Barlow, Paul Overstreet e Naomi Judd, canzone creata, sembra, per conto dell’UNICEF. Nel 1992 fu eseguita e registrata la versione brasiliana intitolata “Vamos Construir” ed il relativo testo è opera di due ragazzi del Centro della Gioventù, Fejo e Dena.
Il canto è ora diventato quasi un inno della Colonia Venezia di Peruibe e noi del “Marmolada” siamo felici di poterlo cantare con loro, nell’incontro che avremo a Peruibe il 28 e 29 novembre, e per loro durante i nostri concerti, soprattutto in quelli dedicati al “Progetto Meniños – frei Giorgio” del quale il Coro Marmolada è “testimonial”.
TRADUZIONE
So che finché sono ancora bambino / Ho molto da imparare / Ma voglio restare bambino quando crescerò. / Il nostro mondo è un giocattolo. / Con piccole cose per unire. / Sarà tutto tuo, se tu penserai così.
Andiamo a costruire un ponte tra noi. / Andiamo a costruire, per
legare illegare il tuo cuore al mio, / Con l'amore che esiste in noi!
E tu che sei persona adulta / Puoi anche imparare / Che amare è importante per il mio mondo e per il tuo. / Ma io ho la speranza / In te che sei mio amico / Che torni a esser bambino, per poter giocare con me.
Andiamo a costruire......
Tutto quello che si sogna / Con l'amore si può ottenere. / Perché tutto è così, è così / E la gente vive molto più felice.
Andiamo a costruire.....
de Sergio Piovesan
Traduzione: Roseli Beatriz Da Silva Stafuzza
Vamos construir (versione portighese)
Na ocasião de um dos primeiros encontros na casa de Anna Maria (Presidente da Associação Amici della Colônia Venezia) e de Giovanni Gabrieli, para programarmos as atividades do Coro Marmolada, com o objetivo de recolher recursos para a Obra começada pelo frei Giorgio Callegari, eles me mostraram um vídeo-cassete representando frei Giorgio em São Paulo e Peruíbe.
As imagens permitiam de ver o funcionamento da obra social fundada por frei Giorgio que, apesar das inúmeras dificuldades, conseguia oferecer todo dia um serviço formativo a meninos e jovens e também alimentação para muitas famílias das favelas.
Frei Giorgio estava sempre rodeado de muitas crianças que, apesar de tudo, estavam felizes. Num momento da gravação deu para escutar um menino que acompanhado por uma guitarra, entoava uma canção. Depois do primeiro refrão, outras vozes se uniam, formando um coro. Era uma canção muito doce e melodiosa. Na progressão das estrofes, mais vozes se uniam, vozes de meninos, até conseguir um verdadeiro coro que cantava: “Vamos construir, uma ponte entre nós. Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós.”
Esta canção me emocionou profundamente. Saindo da reunião, percebi que o meu amigo Rolando tinha tido a mesma emoção.
Ambos concordamos de que teria sido muito bom se também o Coro Marmolada pudesse cantá-la.
Tinha porém uma dificuldade: nossos hospedes não possuíam o texto da música e não deu para consegui-lo no Brasil.
Só tínhamos disponíveis as indicações do acompanhamento com guitarra e a música ao vivo do vídeo-cassete.
Recorremos à mestra Maria Stefânia Caggiula que, com muita habilidade, conseguiu reconstruir o texto musical da canção.
Faltava uma harmonização da linha melódica e uma adaptação às nossas vozes. Confiamos mais esta tarefa a alguns músicos e escolhemos o trabalho elaborado pelo mestre Michele Paguri. Depois veio mais um desafio: tendo de fazer execuções públicas da canção, precisava indicar os autores da mesma. José Rezende, presidente do CEPE (a Ong fundada no Brasil por frei Giorgio Callegari) nos informou que a canção “Vamos construir” é uma adaptação brasileira da canção “Love can built a bridge” escrita para a Unicef por John Barlow, Paul Overstreet e Naomi Judd. Em 1992 foi feita e gravada a versão brasileira com o título “Vamos construir”. Autores do texto foram Fejo e Dena, dois jovens do Centro da Juventude. (qual? ).
Esta canção tornou-se um pouco o hino oficial de Colônia Veneza de Peruíbe e nós do Coro Marmolada seremos felizes de podê-la cantar junto com eles no encontro que teremos em Peruíbe nos dias 28 e 29 de novembro. E também de cantá-la para eles nos nossos concertos, sobretudo os que fazemos para ajudar o “Projeto Meninos – frei Giorgio Callegari”, de que o Coro Marmolada é ‘testimonial’.
Sei Que Ainda Sou Criança / Tenho Muito Que Aprender / Mas Quero Ser Criança / Quando Eu Crescer / Nosso Mundo É Um Brinquedo / Com Pecinhas Para Unir / Ele Sera Todo Seu, / Se Voce Pensar Assim.
Vamos Construir Uma Ponte Em Nos / Vamos Construir, Pra Ligar Seu Coraçao Ao Meu / Com,O Amor Que Existe Em Nos!
E Voce Que É Gente Grande / Também Pode Aprender / Que Amar É Importante Pro Meu Mundo E Para O Seu / Mas Eu Tenho A Esperança / De Voce Ser Meu Amigo / De Voltar A Ser Criança, / Pra Poder Brincar Comigo
Vamos Construir …
Tudo O Que Se Sonha / Com Amor Se Pode Conseguir / Por Que Tudo È Assim, É Assim / E A Gente Vive Muito Mais Feliz!
Vamos Construir …


